cambiailmondo
Cina
Perché il Messico è la nuova variabile nei rapporti tra Usa e Cina

di Federico Giuliani (da Insiderover)
I dati pubblicati lo scorso 8 febbraio dal dipartimento del Commercio Usa hanno generato curiosità e stupore. Per la prima volta in più di due decenni, nel 2023 la principale fonte di beni importati dagli Stati Uniti non coincideva con la Cina. A rubare la corona al gigante asiatico è stato il Messico, specchio delle crescenti tensioni economiche tra Washington e Pechino, nonché degli sforzi attuati dall’amministrazione Biden per importare mercanzia da Paesi geograficamente più vicini rispetto alla Repubblica Popolare Cinese ma, soprattutto più amichevoli del Dragone.
Attenzione però, perché se è vero che gli Usa stanno scommettendo sul Messico per delocalizzare al suo interno le loro aziende – una volta ben felici di essere ancorate al ricco mercato cinese, realtà dorata ormai compromessa dalle tensioni geopolitiche – allo stesso tempo il gigante asiatico sta a sua volta guardando al vicino di casa Usa per far confluire in loco le proprie società. A che pro? Semplice: per farle esportare negli Stati Uniti eludendo dazi e tariffe, e giocando sul fatto che i loro prodotti non sono made in China bensì in Messico.
Ci troviamo così di fronte ad una situazione tanto bizzarra quanto complessa: mentre Washington spera di smarcarsi il più in fretta possibile da Pechino, importando prodotti da altri Paesi in via di sviluppo, le aziende cinesi incrementano le loro attività in quelle stesse nazioni, per produrre beni da inviare nel mercato statunitense come se niente fosse. Il Messico, ancor più del Vietnam, è dunque una variabile emblematica del nuovo equilibrio economico che regola i rapporti tra le due superpotenze del XXI secolo.
La variabile Messico
Nel 2023, dicevamo, gli acquisti statunitensi di prodotti cinesi hanno raggiunto i 427,2 miliardi di dollari, in calo del 20% rispetto al 2022. Al contrario, il Messico ha esportato prodotti in Usa per un valore di 475,6 miliardi di dollari, in un aumento del 4,6% rispetto all’anno precedente. Risultato: Città del Messico è diventata la principale esportatrice verso Washington soppiantando per la prima volta Pechino in 21 anni.
Le ragioni, come detto, hanno tuttavia meno a che fare con il Messico in sé e più con le attuali tensioni internazionali. Detto altrimenti, come spiegato da El Paìs, gli Stati Uniti vogliono smettere di acquistare prodotti a basso costo dalla Cina, e il governo messicano sta lottando per ottenere almeno una parte di quella fetta di torta. Una fetta, si badi bene, potenzialmente destinata a crescere ancora, visto che Joe Biden sta valutando nuovi aumenti delle tariffe su beni cinesi come veicoli elettrici, apparecchiature legate all’ambito dell’energia solare e semiconduttori meno avanzati.
La decisione finale dovrebbe essere presa nella prima metà di quest’anno, ma Pechino ha iniziato a prendere adeguate contromisure. Già, perché come ha evidenziato il Financial Times la Cina sta semplicemente spedendo più merci negli Stati Uniti attraverso il Messico (e altri Paesi), eludendo ogni dazio possibile e immaginabile. La controprova arriverebbe dall’aumento del numero di container da 20 piedi spediti da Pechino a Città del Messico: 881.000 nei primi tre trimestri del 2023, in crescita rispetto ai 689.000 rilevati nello stesso periodo del 2022.
Altro dato rilevante: l’ente commerciale messicano per i fornitori di ricambi per auto, l’INA, ha evidenziato come 33 aziende di proprietà cinese, ma operanti in Messico, abbiano inviato negli Stati Uniti componenti per un valore di 1,1 miliardi di dollari nel 2023, in aumento rispetto ai 711 milioni di dollari del 2021. Che cosa significa tutto questo? Tanto, tantissimo, considerando che le automobili importate negli Stati Uniti dal Messico sono soggette ad un prelievo statunitense pari al 2,5%, mentre le parti assemblate in Messico sono soggette a una tariffa compresa tra lo 0% e il 6%. Al contrario, le automobili e i ricambi importati direttamente dalla Cina pagano un’ulteriore tassa del 25%, secondo il regime fiscale introdotto da Donald Trump e mantenuto da Biden.
L’intermediario tra Usa e Cina
Dal canto suo il Messico è consapevole di essere sotto i riflettori, e l’anno scorso ha annunciato tariffe che vanno dal 5% al 25% su merci provenienti da Paesi come la Cina (anche se non è chiaro quanto e come il nuovo regime verrà applicato o influenzerà le importazioni). A dicembre, inoltre, il governo messicano ha firmato un memorandum d’intesa con gli Stati Uniti sul controllo degli investimenti esteri – compresi i nuovi impianti cinesi di veicoli elettrici – in relazione ai rischi per la sicurezza nazionale.
Come se non bastasse, a giugno sono in programma le elezioni presidenziali messicane che decreteranno chi sarà il successore di Andres Manuel Lopez Obrador. In lizza troviamo due donne: Claudia Sheinbaum, portabandiera del partito MORENA al potere, appoggiata dall’attuale presidente e in rampa di lancio, e Xochitl Galvez, volto della coalizione di opposizione, composta da PAN, PRI e PRD. Le intenzioni di voto per Sheinbaum si aggirerebbero intorno al 64% a fronte del 31% della rivale. Molto distaccato, intorno al 5%, Jorge Alvarez Maynez, del partito Movimento Cittadino (di centrosinistra). Qualora dovesse vincere Sheinbaum, è lecito supporre che il nuovo leader del Paese riproponga l’agenda di Obrador, cercando dunque di ampliare le opzioni economiche a disposizione di Città del Messico, compresa la pista cinese.
Nel frattempo le aziende del Dragone hanno cambiato modo di fare affari con Washington. Alcune, come Hisense – che dal 2022 produce elettrodomestici e frigoriferi per il mercato nordamericano – ha piazzato uno stabilimento dal valore di 260 milioni di dollari in Messico, mentre le società automobilistiche SAIC Motors e JAC Motors hanno annunciato piani per costruire in loco impianti di assemblaggio. Va da sé, sempre in ottica mercato Usa.
In tutto questo troviamo chi vede l’integrazione tra Messico e Stati Uniti come la prova più evidente del successo nel disaccoppiamento Usa dalla Cina, e chi, al contrario, crede che il gigante asiatico stia cercando di migliorare le sue relazioni con il vicino statunitense per evitare sanzioni e tariffe. Insomma, l’ “intermediario” Messico ha il potenziale per riscrivere, in un senso o nell’altro, i rapporti tra le due superpotenze del pianeta. Tutto o quasi dipenderà da chi, tra Usa e Cina, chi riuscirà ad attrarre prima il Paese latinoamericano alla propria sfera di influenza. Con investimenti, progetti e accordi milionari.
Le nuove alleanze militari di Washington nell’area Asia-Pacifico (Economia di guerra oggi, parte VIII)
di Andrea Vento
All’interno della la zolla geopolitica statunitense, posizionata a levante della frattura geopolitica presente ai bordi orientali della massa continentale euroasiatica1, il trend dell’impennata delle spese militari ricalca, seppur in tono leggermente minore, la traiettoria di crescita della Repubblica Popolare Cinese (tabella 1). L’incremento in corso risulta riconducibile anche all’impulso impresso dalle alleanze militari, tese al rafforzamento della cintura anticinese nell’Indo-Pacifico2, rivitalizzate e recentemente create dagli Stati Uniti nell’area, a partire dal Quad (Quadrilateral Security Dialogue) e dall’Aukus (Australia, United Kingdom, United States Security Teatry).
Tabella1: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023
| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||
| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |
| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |
| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |
| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |
| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |
| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |
| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |
| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |
| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |
| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |
| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |
| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |
| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |
| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |
| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |
| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |
| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||
| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||
Il Quadrilateral Security Dialogue
Il Dialogo Quadrilaterale di Sicurezza (Quad) fondato nel 2007 da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, allo scopo di stabilire un sedicente “Arco asiatico della democrazia” avrebbe dovuto comprendere anche gli Stati centro-asiatici, la Mongolia, la Corea del Sud, il Giappone e altri del Sud-Est asiatico, “praticamente tutti i Paesi ai confini della Cina, ad eccezione della Cina stessa”3. Rimasta tuttavia sin dalla nascita scarsamente operativa per la rinuncia dell’Australia nel 2007 e successive divergenze interne, torna a nuova vita su input dei quattro Paesi fondatori a seguito dell’incontro a margine del vertice dei Paesi Asean4 di Manila del 2017, nel cui contesto viene anche stabilita una sinergia militare anticinese con quest’ultima organizzazione.
Dal 2017 il Quad ha quindi progressivamente incrementato le proprie attività, soprattutto in termini di cooperazione ed esercitazioni militari congiunte, fornendo nuova linfa all’inasprimento del confronto globale Usa-Cina che proprio nel Sud-Est asiatico trova uno dei due principali suoi epicentri.
Il nuovo corso del Quad, trae ispirazione dalla strategia di Hillary Clinton dell’ “Indo-Pacifico libero e aperto” e costituisce un progetto di contenimento della Cina in risposta alle “Vie della seta”, non casualmente definito dall’ex funzionario del Dipartimento di stato Usa, Morton Abramowitz, come “una mossa anti-cinese”5.
Strategia di accerchiamento che ha spinto Pechino alle contromisure geopolitiche come il rafforzamento e l’ampliamento dello Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai. Quest’ultimo, già creato nel 2001 da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, in risposta registra, infatti, l’ingresso di India e Pakistan nel 2017 e dell’Iran nel luglio 2023.
Gli alleati strategici di Washington nell’area aumentano le spese militari
Nella dinamicità dello scenario appena tratteggiato, sta acquisendo nuovo status geopolitico il Giappone. Secondo il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, l’ex potenza imperiale rappresenta infatti l’architrave del disegno strategico Usa nella regione. Tokyo ha ormai abbandonato la sua tradizionale politica non interventista e non militarista, sancita dall’articolo 9 della sua Costituzione6, tant’è che, senza essere stato modificato, il governo nipponico ha recentemente intrapreso una nuova corsa al riarmo in conseguenza della discontinuità sancita dalla “Nuova strategia di sicurezza nazionale”. Pubblicata nel 2022, quest’ultima, “Definisce piani ambiziosi per aumentare la capacità militare del Paese nel prossimo decennio in risposta alle crescenti minacce percepite da Cina, Corea del Nord e Russia”. In sostanza si tratta di una mutazione genetica della tradizionale postura pacifista imposta al Paese dagli Stati Uniti dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale7 che il ricercatore del Sipri, Xiao Liang, ha così puntualizzato: “Il Giappone sta attraversando un profondo cambiamento nella sua politica militare. Le restrizioni imposte al Giappone nel dopoguerra alle sue spese militari e alle sue capacità militari sembrano allentarsi”.
Un cambiamento di rotta pilotato da Washington il quale, accertata l’affidabilità dell’alleato, ha deciso per il suo riarmo8 in funzione del contenimento cinese, elevandolo ad asse portante della struttura militare erta ai bordi del mar Cinese Orientale, l’altro principale epicentro di instabilità nello scontro Usa-Cina.
L’analisi dell’andamento delle spese militari di Tokyo effettuate dal Sipri (tabella 1) confermano che il capovolgimento della sua politica militare ha origini molto recenti: al cospetto di un aumento nell’ultimo decennio del “solo” 18%, buona parte si è verificato nel 2022 quando l’incremento è risultato del 5,6%. Lo scorso anno, le uscite militari di Tokyo sono così salite a 46 miliardi di $, pari all’1,1% del Pil.
L’altro tradizionale alleato di Washington nella macroregione, la Corea del Sud, che ospita 8 basi militari statunitensi dalla guerra di Corea (1950-53), risulta, al pari del suo omologo del Nord, una delle zone più militarizzate del pianeta, in considerazione del passaggio della frattura geopolitica in questione lungo il 38° parallelo, la linea di armistizio sulla quale si concluse all’epoca il conflitto. Rappresentando la penisola coreana, l’unico tratto nel quale la linea di faglia scorre su territorio continentale, vi è stata creata una fascia smilitarizzata lunga 250 km e larga 4 km al fine di ammortizzare le tensioni fra le due zolle9 (carta 1). Nonostante la massiccia militarizzazione del territorio già in essere, nel decennio 2013-22, Seul ha aumentato le spese militari di ben il 37% attestandosi al nono posto nella graduatoria mondiale subito davanti al Giappone, con un esborso di 46,4 miliardi di $ nel 2022, pari al 2,7% del Pil.
Carta 1: la situazione militare nella penisola di Corea con la fascia smilitarizzata di separazione

Taiwan divenuto principale teatro di scontro fra Usa e Cina ad inizio agosto del 2022, dopo la visita della Speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi che ha scatenato la reazione di Pechino, ha anch’essa intrapreso la strada del riarmo già alla fine dello stesso mese quando il governo ha apportato una proposta di revisione al rialzo del budget militare per l’anno 2023 di ben il 13,9%, stanziando fondi anche per l’acquisto di nuovi caccia. La spesa militare di Taiwan dovrebbe quindi salire nel 2023 a 19,4 miliardi $, portando il Paese nella poco edificante Top20 mondiale, a ridosso della Spagna (grafico 1). Le spese militari rappresenteranno un crescente fardello per le casse pubbliche di Taipei visto che, secondo le previsioni, arriveranno ad assorbire ben il 14,6% del budget statale dell’anno in corso10.
Cifre più da economia di guerra che da tempi di distensione.
Grafico 1: previsioni di spesa militare nel 2023

A rendere più complicata la situazione nello stretto di Taiwan nell’ambito dello scontro fra la Repubblica Popolare e la Repubblica di Cina, risulta la delicata posizione geostrategica di alcuni arcipelaghi di Taipei localizzati in prossimità della costa continentale. In particolare, si tratta principalmente degli arcipelaghi Kinmen (Quemoy) e Matsu che trovandosi, il primo a 2 soli km di fronte alla metropoli cinese di Xiamen, nella provincia di Fujian, e l’altro, in posizione più settentrionale a 19 km dalle coste della stessa provincia cinese, potrebbero costituire elemento di criticità per entrambi i Paesi, in caso di ulteriore inasprimento della tensione (carta 2).
Carta 2: gli arcipelaghi taiwanesi a ridosso delle coste della Repubblica Popolare

Per la Cina, appurata l’estrema vicinanza alle proprie coste, rappresenterebbero una spina nel fianco, dall’altro per Taiwan risulterebbero difficilmente difendibili in caso di un ipotetico attacco. Soprattutto l’arcipelago Matsu, essendo dotato di un sito missilistico contrariamente al più popoloso Kinmen, secondo il ministero della difesa di Taipei costituisce uno dei primissimi obiettivi sensibili. Si tratta di foschi ma tutto sommato improbabili scenari che infatti non turbano la vita e i pensieri degli abitanti dei due arcipelaghi, i quali mantengono buone relazioni con la Repubblica Popolare: “La popolazione di Matsu si è sempre sentita appartenente a una sola famiglia, quella cinese”11. Una convinzione abbastanza diffusa fra gli abitanti di Matsu anche in considerazione del fatto che lo stesso Arcipelago fa parte della contea di Lienchiang, il cui territorio è diviso fra la parte amministrata dalle Matsu, quindi sotto Taipei, e una parte sotto il controllo della provincia di Fujian.
Il consolidamento del potere dell’Anglosfera tramite l’Aukus
L’altra alleanza militare, l’Aukus, lanciata da Washington il 15 settembre 2021 ha caratteristiche imperialistiche più marcate, appurato che raccoglie 3 dei Five eyes12 anglofoni, nell’ordine: Australia, unico presente geograficamente nella macroregione, Regno Unito e Stati Uniti.
Il programma dell’Aukus è incentrato sull’ammodernamento della flotta australiana di sottomarini con mezzi strategici a propulsione nucleare e rientra nel quadro di rafforzamento delle alleanze in funzione anticinese, per il mantenimento dell’ordine internazionale a guida statunitense (carta 3).
Carta 3: la dotazione di sottomarini da parte dei tre Paesi Aukus e della Cina

In sostanza si tratta di una strategia per fornire a Canberra sottomarini di progettazione statunitense, affinché l’Australia possa ampliare la profondità strategica della propria potenza navale13. L’annuncio della costituzione dell’Aukus è stato accompagnato da un clamoroso dietrofront dell’Australia che, pur avendo già sottoscritto contratti di fornitura di sommergibili a propulsione diesel-elettrico con la Francia stimati fra 40 e 55 miliardi di euro, non ha esitato a rinunciarvi a favore dei più potenti e tecnologicamente avanzati statunitensi. Mossa spregiudicata che ha indispettito non poco Parigi al punto di imbastirvi un caso diplomatico14, richiamando pro tempore gli ambasciatori a Washington e Canberra per consultazioni15 (immagine 1).
Immagine 1: la nascita dell’Aukus in funzione anticinese con risentimento francese e dell’Ue

La politica di riarmo dell’Australia, in linea con gli altri Paesi dell’area, risulta tuttavia aver origini precedenti rispetto al varo dell’Aukus, appurato che nel decennio 2013-22 l’incremento delle spese militari è risultato il terzo più elevato nella Top15 mondiale col +47%, a una corta incollatura da un altro Five eyes, il Canada (+49%), e a qualche lunghezza di distanza dalla Cina che detiene il triste primato con +63%, al netto del particolare caso dell’Ucraina (+1.661%) da un decennio in fase di massiccio potenziamento militare (tabella 1).
Trovandosi i contratti dei sottomarini nucleari statunitensi ancora in fase progettuale, le spese militari di Canberra lo scorso anno hanno registrato solo un modesto incremento dello 0,3%, con scarsa incidenza sul deciso trend di crescita decennale che ha portato nel 2022 le uscite a 32,3 miliardi di $, facendo attestare il Paese al 13° posto della graduatoria mondiale, davanti al Canada con 26,9 miliardi di $.
L’Australia alla luce del riarmo in corso, sottomarini nucleari compresi, e delle potenzialità di proiezione militare che scaturiscono dall’Aukus, sta acquisendo un ruolo geopolitico-militare di crescente importanza sia nello scacchiere Asia-Pacifico, sia su scala mondiale. A livello continentale, invece, l’Australia gode del tradizionale status di potenza egemone, appurato che nel 2022 da sola ha rappresentato il 91,5% delle spese militari totali dell’Oceania (35,2 miliardi di $).
L’India fedele alla politica di non allineamento
Ampliando lo sguardo su tutto lo scacchiere Asia-Pacifico, la partecipazione dell’India al Patto di Sicurezza Quadripartito, il Quad, ha determinato l’affermazione del concetto geostrategico, nato in seno all’Anglosfera, di Indo-Pacifico come area di propria influenza geopolitica. Progetto riguardante nello specifico l’ampliamento della fascia statunitense di contenimento dell’espansione cinese dal Giappone fino all’Oceano indiano, passando per l’Australia (carta 3). Una strategia di accerchiamento che ha indotto Pechino a dotarsi di infrastrutture di trasporto terrestri per raggiungere i porti nell’Oceano Indiano a occidente della penisola indiana: come il “corridoio Cina-Pakistan”16 che dallo Xinjang raggiunge Islamabad e trova conclusione nello strategico terminale di Gwadar sul Mar Arabico, in Pakistan. Paese quest’ultimo con il quale Pechino va consolidando alleanza e relazioni economiche.
L’India è, tuttavia, riluttante a sposare la linea dura del contenimento cinese, attuata da Washington e alleati17, e, fedele alla propria tradizione di Paese “non allineato”, non intende deteriorare, nonostante vari fronti di attrito e di scontro, i rapporti con Pechino. Il governo nazionalista indù di Narendra Modi seppur interessato a cooperare con i Paesi occidentali su tecnologia, armamenti e mantenimento dello status-quo nell’Indo-Pacifico, non sembra intenzionato ad elevare il livello dello scontro con la Cina in quanto New Delhi, nell’attuale scenario geopolitico in fase di trasformazione, è riuscita a conseguire una rendita di posizione internazionale che le consente di avere mano libera per tessere la tela su più fronti.
Il ruolo di battitore libero ritagliatosi dall’India risulta particolarmente propizio per i vantaggi economici che sta riuscendo a ricavarne. Fra le varie rileviamo come in base ai calcoli effettuati dall’agenzia russa Ria Novosti rielaborando i dati ufficiali Eurostat, nei primi 9 mesi del 2023 New Delhi sarebbe diventata il secondo fornitore di prodotti petroliferi raffinati all’Unione Europea, dietro solo all’Arabia Saudita18. L’aspetto singolare, oltre che beffardo, è rappresentato dal fatto che il 40% del petrolio raffinato dall’India e venduto all’Ue proviene dalla Russia19, con buona pace delle sanzioni e delle sue ricadute negative sui committenti europei.
La contemporanea adesione dell’India all’Organizzazione della Cooperazione di Shangai (Sco) e al Quad, solo ad un approccio superficiale può essere definito come semplice doppiogiochismo. Ad una analisi più approfondita, anche sulla scorta del sostegno all’allargamento dei Brics ad altri 6 Paesi all’ultimo vertice in Sud-Africa e dell’incremento delle relazioni commerciali con la Russia dopo il febbraio 202220, emerge infatti che New Delhi sta implementando una politica di potenza autonoma tesa ad accrescere il proprio status internazionale non solo dal punto di vista economico, ma anche militare e geopolitico. Inoltre, ponendosi insieme alla Cina a guida del Sud globale, tali potenze emergenti, di concerto con Russia e Brasile, tramite l’allargamento dei Brics ambiscono alla realizzazione di un ordine internazionale multipolare e al superamento della struttura economico-finanziaria incentrata sul dollaro sancita a Bretton Woods nel 1944-45.
La storica ostilità di New Delhi con il Pakistan, entrambi dotati di ordigni nucleari, ha da tempo comportato un aumento delle spese militari, contribuendo alla scalata dell’India al quarto posto nella graduatoria mondiale dietro a Usa, Cina e Russia. Nel 2022 le uscite indiane per la difesa sono ammontate a 81,4 miliardi di $, pari al 2,4% del Pil, quando erano solo 14,7 miliardi di $ nel 200221, nel cui contesto, il corposo aumento del 6% rispetto all’anno precedente va ricondotto ad una accelerazione nella politica di perseguimento dello status di potenza militare di livello mondiale.
Conclusioni
Il clima da nuova “Guerra fredda” che sta imperversando a livello internazionale, col suo progressivo carico di tensioni e scontri, sta inevitabilmente facendo da traino all’aumento tendenziale delle spese militari mondiali, i cui picchi vengono registrati dal Sipri proprio nei Paesi ai margini delle due principali faglie geopolitico-militari (tabella 2): quella nell’Est Europa fra Usa-Nato e Russia, deflagrata in conflitto militare, e l’altra ai bordi del continente asiatico fra Usa e suoi vari alleati, da un lato, e Cina e, secondariamente, Corea del Nord e Russia, dall’altro.
Nello scontro in atto fra il tenace tentativo degli Stati Uniti di mantenere il potere geopolitico unilaterale mondiale e le potenze emergenti che da parte loro hanno iniziato a realizzare un nuovo ordine internazionale multipolare, l’Occidente globale a guida statunitense continua a mantenere ancora nettamente, seppur in traiettoria declinante, il primato mondiale in campo militare.
Nel complesso, i Paesi della Nato nel 2022 hanno, infatti, totalizzato ben 1.232 miliardi di $ di spese militari, pari al 55,1% del totale mondiale, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Di gran lunga in testa alla graduatoria mondiale sono saldamente attestati gli Stati Uniti, (tabella 1) con una spesa di ben 887 miliardi di $, pari al 39% delle spese mondiali, seguiti dai suoi principali partner europei tutti insediati nella Top15: il Regno Unito 6° con 68,5 miliardi, la Germania, anch’essa sulla via del riarmo con +33% nell’ultimo decennio, in settima posizione con 55,8 miliardi, seguite dalla Francia al 8° posto con 53,6 miliardi, dall’Italia al 12° con 33,5 miliardi di dollari e dal Canada al 14°.
Al fine di quantificare l’entità reale della potenza militare dell’Occidente globale occorre aggiungere le spese degli altri principali alleati statunitensi nei vari scenari regionali: Arabia Saudita 5° posto con 75 miliardi di $, Corea del Sud al 9° con 46,4, Giappone al 10° con 46,0, Australia al 13° (32,3) e Israele al 15° (23,2). Conseguentemente, considerando anche questi Paesi, la spesa complessiva della cosiddetta “Nato globale” sale a 1.455 miliardi di $, pari al 69,9% del totale mondiale.
La scelta strategica di Washington, teorizzata nei vari documenti annuali dell’Agenzia di Sicurezza Nazionale (Nsa), di perseguire la strada del contenimento di Russia e Cina, principali due Potenze Emergenti, tramite l’opzione militarista sta aumentando le tensioni internazionali e alimentando focolai di scontro e addirittura di guerra, come in Ucraina.
Il conseguente incremento irrefrenabile delle spese militari a livello globale pari a +19% nell’ultimo decennio (tabella 2) risulta da un lato foriero di venti di guerra e dall’altro finisce inevitabilmente per impattare sui bilanci statali riflettendosi in tagli alle spese sanitarie, all’istruzione e all’assistenza sociale, nonché agli investimenti produttivi.
Tabella 2: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023
| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||
| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |
| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |
| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |
| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | 0,9 |
| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |
| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |
| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |
| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |
| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |
| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |
| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |
| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |
| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |
| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |
| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |
| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |
| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |
| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |
| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |
Il tutto, amplificato dal sensibile rallentamento delle economie europee causato dall’adozione delle sanzioni alla Russia e dai suoi nefasti effetti collaterali, quali aumento delle quotazioni delle materie prime, fiammata inflazionistica e rialzo dei tassi22.
L’aspetto maggiormente inquietante a nostro avviso, tuttavia, risulta rappresentato dal fatto che i governi, in linea con i principi dell’economia di guerra, stanno affrontando i problemi di bilancio tagliando la spesa sociale e gli investimenti, invece di diminuire i budget per la difesa.
Una politica scellerata che sta avendo pesanti ripercussioni sia nel ciclo economico che nelle condizioni sociali, già gravemente deterioratesi negli ultimi decenni di dominio del dogma neoliberista. Fase storica contrassegnata da crisi economiche cicliche dalle quali la ristrutturazione capitalistica in atto cerca di uscire rilanciando la finanziarizzazione, i conflitti e l’economia di guerra.
Come interrompere la spirale liberismo – spese militari – guerre rappresenta l’ineludibile questione che tutti noi dovremmo affrontare.
Andrea Vento – 10 dicembre 2023 – Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1 L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico
2 Indo-Pacifico: termine geografico reso noto dallo studioso tedesco di geopolitica Karl Hushofer che lo utilizzò in molte sue opere negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. A partire dal 2010 è stato sempre più frequentemente utilizzato, a partire dagli Stati Uniti, nelle analisi geopolitiche. Viene ipotizzato che la sua accezione geopolitica potrebbe condurre ad una ridefinizione geostrategica delle macroregioni terrestri, in quanto la sua adozione e diffusione risulta correlata all’istituzione del “Dialogo quadrilaterale di sicurezza” (Quad), un’alleanza informale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, il quale, oltre ad ampliarsi fino all’oceano indiano, offre una visione geopolitica diversa rispetto al concetto di Asia-Pacifico. In sostanza il Quad consiste in un’ampia cintura di contenimento intorno alla Cina che attraversa parzialmente i due oceani in questione
3 Frank Ching, Asian Arc of Democracy su The Korea Times 224 febbraio 2008
4 Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico è stata fondata l’8 agosto 1967 a Bangkok, Thailandia, con la firma della Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok) da parte dei Padri Fondatori dell’ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia. Il Brunei Darussalam è entrato a far parte dell’ASEAN il 7 gennaio 1984, seguito dal Vietnam il 28 luglio 1995, dal Laos e dal Myanmar il 23 luglio 1997 e dalla Cambogia il 30 aprile 1999, formando quelli che oggi sono i dieci Stati membri dell’ASEAN. https://asean.org/about-asean
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_quadrilaterale_di_sicurezza#cite_note-Ching-17
6Art. 9. – Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.
7 https://www.ilsole24ore.com/art/giappone-addio-pacifismo-tokyo-accelera-corsa-riarmo-AEXje4eB
8 https://www.analisidifesa.it/2022/07/il-giappone-gonfia-le-spese-militari-al-2-per-cento-del-pil-in-5-anni/
9 https://lospiegone.com/2017/03/13/usa-corea-del-sud-tra-propaganda-e-realta/
10 https://www.agi.it/estero/news/2022-08-25/taiwan-aumento-record-spesa-militare-17851034/#:~:text=AGI%20%2D%20Taiwan%20intende%20aumentare%20il,%2C4%20miliardi%20di%20dollari).
11 https://www.internazionale.it/reportage/lorenzo-lamperti/2022/04/24/isole-matsu-cina-taiwan
12 Five Eyes in inglese, acronimo: FVEY. I Cinque Occhi è un’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti . Questi paesi fanno parte dell’accordo UKUSA, un trattato di cooperazione congiunta in materia di intelligence dei segnali
13 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/aukus-e-la-corsa-al-riarmo-sottomarino-nellindo-pacifico-132662
14 https://it.insideover.com/difesa/lalleanza-del-pacifico-che-fa-infuriare-la-francia.html
15 https://www.ilsole24ore.com/art/la-francia-richiama-due-ambasciatori-AERdbbj
16 https://www.limesonline.com/corridoio-cina-pakistan/96725
17 https://www.geopolitica.info/india-politica-estera-usa/
18 Tra gennaio e settembre di quest’anno l’UE ha importato 7,9 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati dall’India, una cifra più che doppia rispetto all’anno precedente e tripla rispetto al 2021. Secondo il rapporto, il volume di prodotti petroliferi raffinati di quest’anno ha catapultato l’India dal sesto posto del 2022 al primo posto del 2023, con Francia, Paesi Bassi e Italia come tre maggiori importatori, seguiti da Croazia, Lettonia, Romania e Germania.
19 La Russia è il secondo esportatore nella UE di prodotti petroliferi, attraverso l’India (scenarieconomici.it)
20 Secondo un rapporto della BBC, le importazioni di petrolio dell’India sono aumentate di dieci volte, raggiungendo i 2,2 milioni di barili al giorno in aprile rispetto alla media pre-invasione di 0,2 milioni di barili al giorno.
21 https://it.tradingeconomics.com/india/military-expenditure
22 Economia di guerra oggi, parte VII. Ormai il re è nudo. Bce: la recessione resta uno scenario possibile
L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico (Economia di guerra – Parte VI°)
di Andrea Vento
Lo scacchiere Asia-Pacifico, comprendente, al netto del Medio Oriente, Asia ed Oceania, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in atto da ormai un decennio, è divenuta da alcuni anni la seconda macroregione/continente terrestre per spese militari raggiungendo, nel 2022, i 575 miliardi di $, dietro solo al Nord America, primo con 904 miliardi, nel cui contesto gli Stati Uniti coprono ben il 98% del totale. La poco confortante corsa al riarmo dell’area Asia-Pacifico è testimoniata dai dati del Sipri (tabella 1) i quali evidenziano il più cospicuo aumento delle spese militari nel decennio 2013-22 fra le macroregioni terrestri, ben il 48%, con l’Europa seconda al 38%, non causalmente l’altro principale teatro di scontro degli Stati Uniti per il mantenimento della sua declinante egemonia mondiale unilaterale (carta 1).
Tabella 1: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023
| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||
| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |
| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |
| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |
| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | O,9 |
| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |
| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |
| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |
| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |
| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |
| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |
| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |
| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |
| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |
| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |
| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |
| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |
| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |
| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |
| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |
Carta 1: lo scenario europeo e quello dell’indo-Pacifico teatri di scontro mondiali

Le “due catene di isole” statunitensi presidiano la faglia geopolitica dell’Estremo oriente
La specificità della macroregione che in ambienti statunitensi viene definita Indo-Pacifico, è determinata dalla profonda frattura geopolitica che scorre ai bordi del mar Cinese Orientale e di quello Meridionale separando, in Estremo Oriente, la zona d’influenza cinese da quella statunitense, con quest’ultima che si articola in due linee fortificate tramite una fitta rete di basi militari, distanti mediamente dai 1.000 ai 2.000 km e all’incirca con lo stesso andamento nord-sud (carta 2 e 3).
La “prima catena di isole” come viene definita la linea più ravvicinata al continente, attraversa l’arcipelago giapponese passando per lo strategico avamposto militare di Okinawa, scorre sul confine tra le due Coree, lambisce Taiwan da levante, per poi inglobare nella zolla statunitense Indonesia, Malesia e Vietnam, delimitando entrambi i mari prospicienti le coste cinese.
L’altra linea fortificata, la “seconda catena di isole”, origina anch’essa dal Giappone nei pressi di Tokyo, raggiunge l’isola di Guam, fondamentale roccaforte Usa dotata di numerose basi navali e aree1, e termina nell’estremità nord-occidentale della Nuova Guinea, in territorio indonesiano.
La doppia linea fortificata creata dagli Stati Uniti in collaborazione con i suoi alleati regionali, ha creato una superiorità marittima su una vasta area, corrispondente al mar cinese meridionale, sulla quale Washington fino a pochi or sono esercitava un sostanziale controllo della navigazione (carta 2 e 3).
Carta 2: la carta geopolitica dell’Indo-Pacifico con basi militari Usa. Fonte: Limes
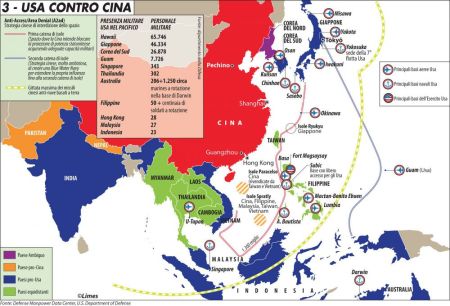
La strategia espansionistica di Pechino nel mar Cinese Meridionale
La Repubblica Popolare, con l’acuirsi delle tensioni, ha percepito la superiorità del potere marittimo statunitense come un crescente pericolo sia militare, anche alla luce delle alleanze militari strette da Washington nell’area, sia per la sicurezza della navigazione mercantile nel mar Cinese Meridionale, che ha come rotta ineludibile verso Occidente lo stretto di Malacca, un passaggio di particolare fragilità geopolitica per l’arteria commerciale dell’economia cinese, in quanto controllato da Washington tramite una base navale a Singapore (carta 2 e 3).
In considerazione di ciò, a Pechino sussiste il non infondato timore che in caso di uno scontro con gli Stati Uniti, questi ultimi si troverebbero nelle condizioni di imporre un blocco navale nello stretto di Malacca e di interrompere gli approvvigionamenti di materie prime e i flussi commerciali in uscita creando in tal modo gravi problemi all’economia cinese. Pertanto, per la Cina il controllo dei due mari prospicienti le sue coste costituisce un elemento imprescindibile, sia in chiave economica, che di sicurezza nazionale, oltre ad un forte valore simbolico per un Paese che ambisce ad un ruolo geopolitico proporzionale alla levatura economica.
Carta 3: Mar cinese orientale e meridionale e le due cinture insulari fortificate create dagli Usa in funzione anti Pechino. Autore: Alberto Bellotto
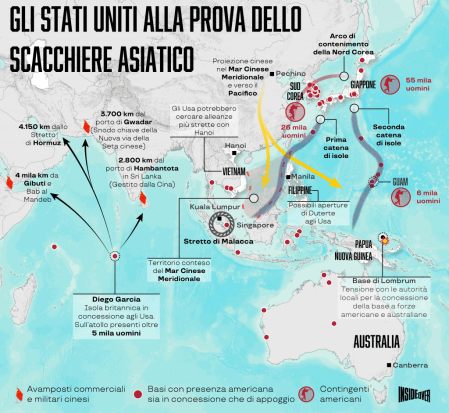
Il governo cinese, quindi, da alcuni ha anni iniziato a reclamare il controllo di circa l’80% del mar Cinese Meridionale e a presidiarlo tramite pattugliamenti aerei e navali. Vi ha, inoltre, costruito la base militare di Yulin nella propria isola meridionale di Hannan e avamposti militari su isole artificiali negli arcipelaghi Paracel e Spratly, tutt’oggi oggetto di contenzioso con vari Stati rivieraschi, soprattutto il Vietnam (carta 4). Il mar Cinese Meridionale è divenuto, ormai da alcuni anni, una delicata area geostrategica di scontro, anche per la presenza di risorse ittiche e ed energetiche, fra Cina e Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e, addirittura, Taiwan, tutti Paesi a vario titolo alleati di Washington, con alcuni che ospitano basi militari Usa sul proprio territorio2.
Per Pechino il quadrante in questione rappresenta un’area di tale vitale importanza da aver indotto il governo a varare un’apposita dottrina, l’Anti-access/area-denial (Ad/a2)3, che teorizza l’interdizione delle forze avversarie dall’area compresa tra le proprie coste e la parte centro-meridionale della “prima catena di isole”, dove sono localizzate numerose basi statunitensi.
Al contempo gli Stati Uniti hanno intensificato i pattugliamenti nel mar Cinese Meridionale4, le visite di importanti esponenti politici a Taiwan e le forniture di armi a Taipei5, progettato nuove basi e stretto nuove alleanze militari, facendo salire ulteriormente la tensione, soprattutto in merito allo status dell’isola che Pechino aspira a riunificare in qualità di sua 22esima provincia. Isola che, invece, gli Stati Uniti stanno riarmando nella prospettiva di impedirne il ritorno alla Cina e di trasformarla in un caposaldo fortificato, al pari della vicina Okinawa, della “prima catena di isole”. Conseguentemente alle tensioni, nell’area dell’indo-Pacifico sono sensibilmente aumentate anche le esercitazioni militari sia di singoli Stati, come quelle cinesi nei pressi di Taiwan, che congiunte fra Paesi che hanno convergenze di interessi nell’area, come Russia e Cina, da un lato, e Usa con Vietnam6 e Filippine7, dall’altro.
La pressione statunitense nel mar Cinese Orientale
A nord di Taiwan, la frattura geopolitico-militare, che fiancheggia il mar Cinese Orientale, attraversando l’arco delle isole minori giapponesi per poi raggiungere le quattro maggiori, rappresenta una struttura militare fortificata avversaria che sta creando problematiche ancor maggiori a Pechino, anche per la presenza di due stretti “alleati” degli Stati Uniti, come Giappone8 e Corea del Sud9 dove ha impiantato una fitta rete di basi militari, vi effettua esercitazioni congiunte e vi sta aumentando le forniture di armamenti10.
Tramite la disputa per le strategiche isole Diaoyu/Senkaku attualmente sotto controllo amministrativo di Tokyo, la Cina cerca di contendere al Giappone il controllo della porzione del mar Cinese Orientale (carta 4) a occidente delle suddette isole11. I rapporti di forza sfavorevoli a Pechino, anche per la vicinanza alle proprie coste della “prima catena di isole” in questo mare, lo hanno indotto a indirizzare la propria strategia verso il controllo del bacino marittimo del Sud-Est asiatico, principale rotta del commercio marittimo mondiale nonché base di espansione della sua potenza militare nella macroregione.
Carta 4: le rivendicazioni marittime e le dispute insulari cinesi

L’aumento delle spese militari alimentano i venti di guerra
L’area circostante la profonda faglia in questione rappresenta, insieme all’Europa Orientale, una dei due principali teatri di scontro a livello mondiale le cui crescenti tensioni hanno alimentato la politica di riarmo in tutti gli attori geopolitici regionali a partire dalla Cina. Pechino, infatti, registrando il 28° anno consecutivo di aumento delle spese, è salita a 292 miliardi nel 2022 con una crescita record del 63% nel decennio 2013-22.
Tuttavia, la Repubblica Popolare seppur secondo Paese per spese militari in valore assoluto a livello mondiale, evidenzia un rapporto delle stesse col Pil dell’1,6% inferiore a quello di Stati Uniti 3,5%, Russia 4,1% e India 2,6%, oltre ad altri importanti player mondiali, che le riserva la possibilità di espanderle ulteriormente senza gravare eccessivamente sulla ricchezza nazionale e sul bilancio statale (tab. 2).
Tabella 2: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023
| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||
| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |
| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |
| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |
| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |
| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |
| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |
| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |
| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |
| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |
| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |
| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |
| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |
| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |
| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |
| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |
| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |
| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||
| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||
| Totale globale | 2.240,0 | 100,0 | 3,7 | 19 | 2,2 |
Anche in questo delicato scacchiere geopolitico, l’aumento delle tensioni legate alla politica statunitense di contenimento della, tutto sommato legittima, strategia di espansione dell’influenza cinese nei mari adiacenti le proprie coste, sta pericolosamente trainando al rialzo le spese militari degli attori regionali. L’Asia Orientale, rappresenta infatti la seconda macroregione terrestre ad aver registrato il più cospicuo aumento delle spese militari nel decenni 20013-2022, pari a +50%, solo dietro all’Europa dell’Est che detiene il poco invidiabile primato mondiale con +72% (tab. 1)
Una trama ormai tristemente famosa, e da noi recentemente analizzata nel saggio “Lo scontro strategico per l’egemonia globale sospinge l’aumento delle spese militari”12, che lascia intravedere lo stesso drammatico finale verificatosi nell’est europeo, una volta terminata la guerra in Ucraina. Tuttavia, a complicare ulteriormente i piani di Washington per il mantenimento dell’egemonia globale affrontando militarmente in modo separato prima con la Russia e, successivamente, con la Cina, è involontariamente intervenuta la guerra a Gaza, che col rischio di allargamento del conflitto ad altri attori regionali, ha costretto gli Stati Uniti a spostare corposi gruppi navali dotati di portaerei nel Mediterraneo Occidentale e nel golfo Persico. Al cospetto dell’esito non favorevole della guerra in Ucraina, il doversi impegnare militarmente su più fronti contemporaneamente, sia direttamente che indirettamente, potrebbe rivelarsi una situazione complessa anche per la superpotenza mondiale. Situazione della quale sono perfettamente consapevoli al Pentagono, la speranza è che lo siano altrettanto alla Casa Bianca.
Andrea Vento – 4 novembre 2023
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1 L’isola di Guam fondamentale per la strategia degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. https://nododigordio.org/breaking-news/lisola-di-guam-fondamentale-per-la-strategia-degli-stati-uniti-nellindo-pacifico/
2 https://www.analisidifesa.it/2022/11/nuove-basi-americane-nelle-filippine-in-equilibrio-tra-usa-e-cina/
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-access/area_denial#:~:text=Anti%2DAccess%2FArea%20Denial%20(,from%20entering%20an%20operational%20area.
4 https://www.agi.it/estero/news/2023-04-17/taiwan_nave_guerra_usa_nello_stretto_condanna_pechino-20998526/
5 https://www.atlanteguerre.it/armi-usa-a-taiwan-una-bomba-a-orologeria/
6 https://www.china-files.com/esercitazione-navale-congiunta-vietnam-usa-innervosisce-pechino/
7 https://www.china-files.com/al-via-la-piu-grande-esercitazione-tra-usa-e-filippine/
8 https://www.asianews.it/notizie-it/Con-uno-sguardo-alla-Cina,-Tokyo-si-unir%C3%A0-alle-esercitazioni-militari-di-Jakarta-e-Washington-56354.html
9 https://www.ilsole24ore.com/art/usa-corea-sud-riprendono-esercitazioni-militari-quattro-anni-AENWVhuB
10 https://www.ilsole24ore.com/art/corsa-riarmo-giappone-usa-nuova-commessa-militare-aerei-sorveglianza-AEV2me2C
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_sino-giapponese_per_le_isole_Senkaku
12 https://cambiailmondo.org/2023/10/23/economia-di-guerra-parte-v-lo-scontro-strategico-per-legemonia-globale-sospinge-laumento-delle-spese-militari/
Le nuvole nere sull’ordine mondiale

di Vincenzo Comito
La tragedia in Israele e Gaza non deve far dimenticare le trasformazioni di più lungo periodo dell’ordine mondiale, guidate dall’evoluzione economica delle diverse aree del mondo. Facciamo il punto sui nuovi rapporti di forza nell’economia del pianeta.
La tragedia in Israele e Gaza, la guerra in Ucraina, il moltiplicarsi di conflitti “locali” hanno radici storiche e politiche profonde, specifiche a ciascuna area, ma si inseriscono in un quadro comune, segnato dalla crescente fragilità dell’ordine internazionale. Oggi si trovano quasi tutti d’accordo sull’idea che il mondo uscito dalla seconda guerra mondiale stia ora progressivamente svanendo, come intitolava ad esempio un recente articolo di “Le Monde” (Frachon, 2023). Il segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterrez ha ribadito che “le strutture attuali di governance mondiale riflettono il mondo di ieri”. Ma ci sono idee piuttosto confuse su come esso si stia veramente trasformando e in che direzione si stia andando. E non manca chi cerca di frenare il movimento.
Certo, non siamo nella situazione in cui si è trovato a suo tempo Claudio Rutilio Namaziano, che, partito in nave da Roma per ritornare alla natia Gallia dopo un soggiorno nella capitale dell’Impero e facendo sosta ogni sera lungo il percorso in un porto diverso, assistette in tempo reale al crollo in pochi giorni del sistema imperiale, città per città (è il tema del suo poema De reditu suo, diventato di recente un film, De reditu, “Il ritorno”). Nel nostro caso il percorso appare invece lungo e tortuoso.
C’è un vasto accordo sul fatto che la potenza economica, finanziaria, tecnologica, militare degli Stati Uniti, sino a ieri paese di gran lunga dominante, si stia progressivamente riducendo rispetto al resto del mondo, anche se il dibattito è aperto su quanto forte sia tale riduzione e come si collochi oggi invece in termini di peso effettivo la potenza in ascesa, la Cina, rispetto a quello degli Stati Uniti.
Certo, per quanto riguarda le trasformazioni in atto alcuni dati appaiono impressionanti. Secondo i calcoli di IMF e Banca Mondiale, nel 2022 il pil cinese, calcolato con il criterio della parità dei poteri di acquisto, risultava ormai grosso modo pari al 19% di quello mondiale e quello degli Stati Uniti “solo” al 15%.
Anche in campo tecnologico studi recenti nostrano come la Cina tende a diventare più importante degli Stati Uniti, anche se essa presenta qualche debolezza su alcuni settori. Una ricerca australiana (Hurst, 2023), sponsorizzata anche dal dipartimento di Stato statunitense, indica in effetti che su 44 settori tecnologici esaminati nello studio la Cina ha oggi il primato su tutti gli altri paesi, compresi gli Stati Uniti, in ben 37 di essi, mentre questi ultimi continuano a guidare il resto del mondo soltanto nelle restanti 7 tecnologie. Nessuno degli altri paesi ha quindi il primo posto in qualche settore.
In particolare gli sviluppi in atto nel campo delle tecnologie relative alle energie rinnovabili, settore nel quale il dominio della Cina appare quasi incolmabile, mostrano la forza di tale trasformazione in atto.
Più in generale il mondo occidentale non appare più egemonico ed esso ha perduto e sta perdendo un numero crescente dei suoi monopoli. Ricordiamo, a questo proposito, che ormai i paesi in via di sviluppo controllano circa il 60% del pil mondiale e che nel 2030 i due terzi delle classi medie saranno in Asia. La partita, per molti versi, sembra ormai decisa.
Gli Stati Uniti cercano di resistere
Ma gli Stati Uniti non vogliono riconoscere le nuove realtà in atto. Graham Allison, professore ad Harvard, riassume perfettamente la situazione: “Gli americani sono scioccati dall’idea che la Cina non resti al posto che gli era stato a suo tempo assegnato in un ordine internazionale diretto dagli Stati Uniti” (Bulard, 2023).
Così, dopo le misure varate da Trump contro le merci asiatiche, con Biden l’ostilità è fortemente aumentata. Si è sviluppata un’offensiva economica, tecnologica, finanziaria, militare, politica, tout azimut, rivolta contro tutte le iniziative e le mosse di Pechino, cercando di coinvolgere quanto più paesi possibile in tutti i continenti e su tutte le questioni.
Una nuova isteria maccartista ha conquistato tutti gli strati della società e della politica Usa, se escludiamo alcune parti del sistema economico che hanno invece interesse a sviluppare i rapporti con il paese asiatico.
L’offensiva di Washington presumibilmente fallirà, almeno in gran parte, ma essa rischia di danneggiare intanto gravemente la relativa pace del mondo e lo sviluppo dei rapporti economici tra i vari paesi del mondo.
Verso un nuovo ordine multipolare?
Certamente Cina e Stati Uniti saranno i due massimi protagonisti della scena mondiale ancora almeno per un lungo periodo, con la stessa Cina che dovrebbe accrescere ancora il suo peso rispetto al rivale. Essi continueranno comunque insieme a condizionare gli sviluppi del mondo in maniera molto rilevante. Ma la rivalità tra i due paesi non sembra poter esaurire il quadro del nuovo ordine mondiale in via di formazione. Può darsi che si stia configurando un secolo cinese, come pensano alcuni, ma molti altri prevedono invece l’affermazione di un mondo pluralista, in cui, accanto ai due giganti economici, si affermino una serie di potenze intermedie che, cercando di tenere buoni rapporti con i due, tendano comunque ad affermare la propria autonomia.
Bisogna considerare che gli stessi cinesi auspicano da parte loro la costruzione di un mondo multipolare.
Qualcuno ha parlato a proposito di questi nuovi sviluppi di “età delle potenze intermedie”, sia nel senso di un loro peso economico e politico piuttosto consistente, che in quello di una posizione di mezzo tra le due grandi potenze. Invece di un menu di alleanze a prezzo fisso, in cui bisognava scegliere uno dei due campi, si potrebbe affermare un mondo con scelte à la carte (Russell, 2023), in cui magari i vari paesi tendano anche a giocare le due grandi potenze una contro l’altra, per ottenere il massimo dei vantaggi possibili. C’è chi, ad esempio lo storico Franco Cardini (Cardini, 2023), vede peraltro delinearsi un “multipolarismo imperfetto”, “confuso, slabbrato, pieno di labilità e di incognite”.
I rapporti Cina-Usa
Bisogna comunque a questo punto fare una disgressione. Da anni ormai gli Stati Uniti perseguono in ogni modo il tentativo di ridurre al massimo i rapporti economici con la Cina e stanno cercando anche di spingere i fedeli e mediocri esecutori che guidano Bruxelles a fare altrettanto. E certo qualche risultato è stato in questo senso raggiunto e qualcun altro potrebbe seguire. Ma bisogna d’altro canto considerare che tale politica di riconfigurazione delle catene di approvvigionamento è alla fine almeno in parte evitata dalla Cina attraverso una triangolazione di produzioni. Le imprese del paese asiatico, invece di esportare le loro merci direttamente in Usa, lo fanno attraverso paesi terzi; la dipendenza degli Stati Uniti dalla Cina rimane così intatta (The Economist, 2023) ed anzi le mosse di Biden spingono a più stretti legami tra la Cina e gli altri paesi esportatori, ottenendo così l’effetto opposto a quello desiderato. Mentre gli Stati Uniti non possono fare a meno di alcuni tipi di prodotti cinesi, ora la lotta al cambiamento climatico ha comunque bisogno del sostegno delle tecnologie e delle produzioni del paese asiatico.
Tutta la manovra di Biden produce d’altro canto dei costi più elevati per le imprese e per i consumatori, mentre l’industria cinese rappresenta oggi intorno al 30% di quella mondiale, qualcosa in più della situazione presente al momento in cui Trump ha lanciato la campagna anticinese, mentre, più in generale, l’industria mondiale si concentra sempre più nell’Asia del Sud-Est (Bezat, 2023).
Appare comunque abbastanza chiaro che la stessa Cina, viste anche le difficoltà con l’Occidente, tende a rafforzare fortemente i suoi rapporti economici con i paesi del Sud del mondo. Intanto il Fondo Monetario Internazionale mette in guardia contro una frammentazione geo-economica, una nuova spinta protezionista che potrebbe frenare lo sviluppo dell’economia mondiale (Bezat, 2023).
I paesi Arabi
Uno degli esempi possibili di come si possa configurare il nuovo ordine mondiale è rappresentato dagli sviluppi in atto nei paesi del Golfo (England, 2023).
In tale area ci sono due potenze principali, l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, la prima il più importante esportatore di petrolio del mondo, la seconda il centro commerciale dominante. Per diversi decenni tale area è stata fortemente nell’orbita statunitense; gli Usa erano il garante della loro sicurezza, mentre i paesi arabi assicuravano ad essi delle forniture stabili e sicure di energia.
Ma oggi l’area rifiuta di accettare la domanda degli Stati Uniti di essere con loro o contro di loro (England, 2023). La Cina è oggi in effetti il principale cliente del petrolio del Golfo ed altri importanti partner sono anche l’India e la Turchia. Il commercio dell’Arabia Saudita con la Cina è altrettanto grande in valore quanto quello con gli Usa, la Gran Bretagna e l’UE messi insieme. Al di là del solo commercio, i paesi arabi, assetati di tecnologie, portano avanti importanti progetti nel campo della stessa energia, dell’IA, dell’auto, finanza, infrastrutture, ecc., mentre vengono avanti investimenti diretti reciproci. Con la Cina i paesi del Golfo hanno firmato un accordo di partnership strategica. Essi si sono poi ben guardati di condannare la Russia per la questione ucraina, paese con cui cooperano attraverso l’Opec+.
Non che i rapporti con gli Stati Uniti siano diventati ostili. Il paese continua ad essere il principale fornitore di armi e l’alleanza militare è mantenuta, mentre continuano ad essere molto rilevanti gli investimenti dei paesi del Golfo in Usa. Si potrebbe dire che la loro sicurezza riposa oggi con gli Usa, la politica energetica si fa con la Russia, mentre la prosperità economica è sempre più legata alla Cina e agli altri paesi asiatici (England, 2023). Essi alla fine sono per un mutamento nell’ordine mondiale e pensano che saranno uno dei poli principali del mondo multipolare emergente.
E gli altri paesi del Sud
Il caso dei paesi del Golfo può essere considerato per molti versi come abbastanza rappresentativo della posizione della gran parte degli altri paesi intermedi, dall’India, al blocco dei paesi dell’Asean, al Brasile, al Sud-Africa, all’Algeria, all’Argentina, alla Turchia, per citarne molti tra i principali, per molti versi alla stessa Germania, anche se quest’ultima rimane un caso particolare. Certo, ognuno di questi paesi ha più simpatie verso uno dei due raggruppamenti, chi verso la Cina/Russia, chi verso gli Stati Uniti, ma comunque essi si sforzano di tenere rapporti amichevoli con ambedue i fronti.
Un caso particolare è quello dell’India, piuttosto ostile alla Cina, ma amica contemporaneamente di Russia e Stati Uniti, comunque nello stesso tempo partecipe dei raggruppamenti dei Brics, a sostanziale guida cinese e alla Sco, a guida cinese e russa. Un altro caso ancora più particolare è quello della Germania, che, pur inserita nell’area atlantica, vede al suo interno manifestarsi una lotta tra quelli che vogliono mantenere stretti contatti economici con la Cina e gli atlantisti.
Da segnalare infine come la Russia, in relazione agli avvenimenti in Ucraina, stia velocemente spostando la sua collocazione economica dalla Europa all’Asia.
Il caso degli enti internazionali
Esaminiamo a questo punto la situazione e le prospettive di alcune strutture, pilastri della dominazione statunitense sul mondo, le istituzioni finanziarie e commerciali e il dollaro.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale fu creata una serie di istituzioni che avrebbero dovuto contribuire a stabilizzare il nuovo ordine mondiale uscito dalla fine della guerra. Furono così creati il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l’Organizzane per il Commercio Mondiale. Tali organismi risultarono presto essere governati in via quasi esclusiva dagli Stati Uniti, anche se l’Europa avrebbe avuto diritto, per graziosa concessione Usa, alla direzione del Fondo.
Tali organismi si trovano oggi in grande difficoltà e per diverse ragioni. Prendiamo in particolare il caso del Fondo Monetario Internazionale. Oggi molti paesi in via di sviluppo, dal Brasile alla Cina, contestano le sue operazioni, indicando che tali organismi sono operanti e sono organizzati per favorire l’Occidente ed anche al recente vertice dei Brics è stato chiesto una maggiore rappresentanza nell’organismo per i paesi in via di sviluppo. Lo stesso segretario generale dell’Onu ha chiesto una più grande peso dei paesi in via di sviluppo nelle organizzazioni internazionali. Lula ha poi espresso preoccupazione perchè a suo dire il Fondo asfissia le economie in difficoltà ponendo condizioni molto dure al loro salvataggio (Beattie, 2023).
In teoria è allo studio una revisione delle quote dei vari paesi. Considerando il suo peso economico, la Cina dovrebbe passare dall’attuale 6,4% di quote al 14,1%, mentre gli Stati Uniti dovrebbero scendere dal 17,4% al 14,8% (Beattie, 2023), perdendo anche il diritto di veto sulle decisioni dell’organismo. Ma questi ultimi sono ovviamente contrari a questo mutamento e la situazione appare bloccata. Intanto il Fondo, come la Banca Mondiale, avrebbero bisogno di molti più fondi per operare (la cooperazione dei paesi ricchi diminuisce mentre le necessità dei paesi del Sud aumentano; è stato così calcolato che la Banca Mondiale ha oggi una capacità di finanziamento cinque volte minore che negli anni sessanta del Novecento (Bouissou, 2023), all’aumento dei quali la Cina potrebbe collaborare in maniera sostanziale.
Con il blocco, i tre organismi stanno sempre più perdendo di rilevanza, mentre la Cina, i parte con altri paesi, sta potenziando dei meccanismi alternativi, che tendono a diventare più importanti di quelli citati. Ricordiamo che sono in piedi orami da dieci anni i meccanismi della BRI, che in tale periodo ha messo in opera investimenti per mille miliardi di dollari rivolti a 150 paesi. Ci sono poi gli organismi di finanziamento del commercio estero del paese asiatico, mentre ormai funziona quasi a pieno regime l’AIIB, rivolta all’Asia e si stanno potenziando le istituzioni bancarie dei Brics e dello Sco.
La dedollarizzazione
L’egemonia degli Stati Uniti sul resto del mondo riposa per una parte molto consistente sul controllo della moneta internazionale, il dollaro. La moneta Usa è di gran lunga la più usata per gli scambi commerciali, per le operazioni finanziari sui mercati, come infine moneta di riserva, portando ad un “esorbitante privilegio” per il paese, come ha detto qualcuno. In tale situazione, da una parte il paese si può permettere una politica di bilancio molto libera, dall’altra può condizionare e ricattare gli altri paesi del mondo.
Come è noto, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina gli Stati Uniti hanno reagito tra l’altro con il sequestro delle riserve in dollari della Russia; ma è anche noto che tale misura ha scosso in profondità i governi della gran parte dei paesi del Sud, che hanno cominciato a pensare che la stessa cosa avrebbe potuto succedere anche a loro in futuro.
Così negli scorsi mesi abbiamo assistito ad una serie di iniziative anche disordinate volte a ridurre il peso del dollaro nel regolamento delle transazioni commerciali tra i vari paesi. Il fenomeno più vistoso manifestatosi sino ad oggi è indubbiamente il passaggio dal regolamento della maggior parte delle transazioni della Russia dal dollaro allo yuan. C’è da dire che in generale le ipotesi della sostituzione del dollaro con lo yuan non sembra completamente fattibile, vista l’ostilità da parte di alcuni paesi, ma comunque il suo ruolo dovrebbe aumentare fortemente. Intanto va avanti il progetto dello yuan elettronico. I Brics stanno ora discutendo su quale meccanismo utilizzare per ancorarvi i loro scambi. Comunque l’abbandono del dollaro da parte dei paesi del Sud, che a chi scrive sembra ormai inevitabile, si potrà svolgere solo lentamente e con fatica, visto il radicamento profondo dell’attuale sistema e la resistenza occidentale a ogni cambiamento. Il dollaro conserverà peraltro ancora a lungo un ruolo importante.
Certo la soluzione migliore sarebbe quella di riformare il sistema monetario internazionale sulla base del meccanismo dei diritti speciali di prelievo, soluzione anch’essa osteggiata dagli Stati Uniti.
Conclusioni
Nel testo abbiamo cercato comunque di cogliere i movimenti essenziali delle trasformazioni in atto nell’assetto dell’ordine mondiale.
Tale trasformazione procede lentamente, almeno su alcuni fronti, ma apparentemente in maniera inesorabile. Forse non si tratta tanto di un passaggio del testimone dagli Stati Uniti alla Cina, come si era magari portati a pensare qualche tempo fa. Tale ipotesi si scontrerebbe da una parte con le evidenti riserve di una parte almeno dei paesi del Sud, ma anche con l’apparente scarso interesse della stessa Cina ad occupare tale ruolo, anche se essa non è da scartare del tutto. Questo non toglie che la Cina si avvii probabilmente ad essere la potenza economica più rilevante a livello economico e tecnologico e non impedisce il fatto che gli Usa conservino comunque una forza considerevole in diversi campi.
Naturalmente la storia ci ha abituato a sconvolgimenti anche repentini della situazione e le previsioni che possiamo fare sono comunque soggette a molta cautela.
Ci troviamo oggi comunque in una situazione nella quale, per riprendere un’idea di Gramsci, il vecchio ordine non ce la fa più e il nuovo stenta ancora ad emergere. Si può ricordare a questo proposito come la crisi del ‘29 sia stata anche provocata dal fatto che la Gran Bretagna non aveva più la forza per governare il mondo e gli Stati Uniti non erano ancora pienamente in grado di sostituirla. Viviamo degli anni di rilevanti disordini che potrebbero appunto essere originati dalla mancanza di un nuovo e chiaro ordine delle cose (Leonhardt, 2023).
In ogni caso, se andiamo verso un mondo pluralista, come sembra di poter intravedere, bisogna cercare di creare al più presto delle istituzioni adeguate per il suo governo. Tra l’altro, sarebbe necessario varare un nuovo sistema monetario inclusivo e mettersi d’accordo sul rinnovamento di Banca Mondiale, Fondo Monetario, Organizzazione per il Commercio. La maggiore difficoltà alla costruzione di tale sistema rimangono gli Stati Uniti.
Testi citati nell’articolo
-Beattie A., Why the «Global South» isn’t running the IMF, www.ft.com, 5 ottobre 2023
-Bezat J-M., Chine-Etats-Unis, l’impossible divorce, Le Monde, 29 agosto 2023
-Bouissou J., FMI et Banque mondiale : le Sud veut peser, Le Monde, 11 ottobre 2023
-Bulard M., Quand le Sud s’affirme, Le Monde diplomatique, ottobre 2023
-Cardini F., La deriva dell’Occidente, Laterza, Bari-Roma, 2023
-England A., « Bridges with everyone » : how Saudi Arabia and UAE are positioning themselves for power, www.ft.com, 23 agosto 2023
-Frachon A., Le monde post-1945 s’efface, Le Monde, 6 ottobre 2023
-Hurst D., China leading US in technology race in all but a few fields, thinktank finds, www.theguardian.com, 2 marzo 2023
-Leonhardt D., The global context of Hamas-Israel war, www.nytimes.com, 9 ottobre 2023
-Russell A., The à la carte world : our new geopolitical order, www.ft.com, 21 agosto 2023
–The Economist, Costly and dangerous, 12 agosto 2023
FONTE: https://sbilanciamoci.info/le-nuvole-nere-sullordine-mondiale/
La Cina pubblica libro bianco su proposte e azioni per costruire “una comunità globale dal futuro condiviso”
Il mondo intero dovrebbe leggere attentamente questo libro bianco della Cina: Editoriale del Global Times

Il 26 settembre, l’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un libro bianco intitolato “Una comunità globale dal futuro condiviso: Proposte e azioni della Cina” (versione ENG – versione ITA). In occasione del decimo anniversario della proposta del Presidente Xi Jinping di costruire una comunità globale di futuro condiviso, la Cina ha presentato la base teorica, la pratica e lo sviluppo di una comunità globale di futuro condiviso, indicando la strada verso un futuro migliore per il mondo. Chiunque, sia che si tratti di Paesi in via di sviluppo che cercano di imparare dalla Cina, sia che si tratti di individui provenienti da Paesi occidentali interessati ad approfondire la conoscenza della Cina, troverà ispirazione in questo documento, a patto che lo affronti senza pregiudizi.
Nel 2013, il presidente Xi Jinping ha proposto l’idea di costruire una comunità globale dal futuro condiviso, sottolineando che tutti i Paesi dovrebbero dedicarsi alla pace globale e allo sviluppo comune. Negli ultimi 10 anni, il panorama internazionale ha subito rapidi cambiamenti. Il processo di globalizzazione ha affrontato cambiamenti, come il “disaccoppiamento” e gli approcci “cortile piccolo, recinto alto”, che contraddicono i tempi attuali. La rinascita del confronto tra blocchi e i segnali di una “nuova guerra fredda” hanno continuamente interrotto la cooperazione globale. Soprattutto negli ultimi anni, eventi inaspettati come il “cigno nero” e il “rinoceronte grigio” si sono verificati di frequente, portando a rapidi cambiamenti nelle situazioni che la maggior parte delle persone non aveva inizialmente previsto.
La società umana si trova ora di fronte a una “scelta di vita o di morte”: entrare in un circolo vizioso di continui scontri e divisioni o cercare un percorso di cooperazione e di vittoria, che permetta a più di 7 miliardi di persone di avere una vita migliore. Il mondo intero è alla ricerca di risposte. Questo conferma anche la natura estremamente preveggente e lungimirante del concetto di comunità globale del futuro condiviso.
Senza esagerare, si può dire che questo Libro bianco è un documento di portata storica e globale, proprio come il suo tema, che riguarda il destino dell’intera umanità. Sebbene sia stato proposto dalla Cina, non è un’esclusiva della Cina. Fornisce risposte coraggiose e profonde all’interrogativo sollevato da tempo sul futuro dell’umanità e rappresenta un bene pubblico globale di importanza critica che la Cina offre al mondo.
Il Libro bianco, con circa 22.000 parole, è relativamente conciso, considerato il suo peso. Il suo linguaggio è altamente condensato, preciso e vivace. Pur trattando argomenti profondi, è abbastanza leggibile e comprensibile. Raccomandiamo vivamente alle persone che hanno a cuore il destino dell’umanità, indipendentemente dalla loro nazionalità o etnia, di dedicare del tempo alla lettura del testo originale.
Chiediamo inoltre con forza ai Paesi occidentali, compresi gli Stati Uniti, di mettere da parte pregiudizi ed egoismi e di aprire le loro visioni. Dovremmo lavorare insieme nel quadro di una comunità globale dal futuro condiviso e cercare la prosperità e l’armonia comuni con tutti i Paesi. Che siano disposti o meno, il mondo ha bisogno di una nuova serie, o addirittura di più serie, di soluzioni.
In effetti, da quando la Cina ha proposto il concetto di comunità globale di futuro condiviso 10 anni fa, esso è stato incluso nelle risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sei anni consecutivi, così come nelle risoluzioni o nelle dichiarazioni di meccanismi multilaterali come l’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai e i BRICS. Ha ottenuto la comprensione e il sostegno della comunità internazionale, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo. Tuttavia, ciò ha suscitato vigilanza, resistenza e persino ostruzione da parte dei Paesi sviluppati come gli Stati Uniti, che sono diventati il principale ostacolo alla costruzione della comunità globale del futuro condiviso.
In realtà, se le élite politiche occidentali sono disposte a mettere da parte la loro arroganza e ad ascoltare attentamente la voce della Cina, scopriranno che la proposta del concetto di comunità globale del futuro condiviso non intende sfidare o competere con l’Occidente. Questa “comunità” include anche la partecipazione e la cooperazione dei Paesi occidentali sviluppati. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla ricchezza di un Paese, nessun Paese o individuo è escluso. La visione che promuove per un mondo migliore include anche il benessere dei cittadini dei Paesi occidentali. Pertanto, sia che si tratti di società sviluppate che di Paesi in via di sviluppo, essi dovrebbero contribuire alla causa comune della pace e dello sviluppo.
Il mondo di oggi è diventato una comunità dal futuro condiviso, con i Paesi che viaggiano insieme su una nave dal destino comune. Una piccola barca non può resistere al vento e alle onde, solo una nave gigante può resistere al mare in tempesta. Per quanto un Paese possa essere potente, non può dominare il mondo da solo e deve impegnarsi nella cooperazione globale.
Come si legge nel Libro bianco, “Questo è un mondo integrato. Coloro che gli voltano le spalle non troveranno posto in esso”. In questo mondo, il vero potere che trascende il tempo è contenuto nelle idee silenziose e sottili, proprio come la grandezza pratica dimostrata dal concetto di comunità globale del futuro condiviso.
FONTE: https://www.globaltimes.cn/page/202309/1299005.shtml
Traduzione: Cambiailmondo.org
Scarica il “libro bianco”
La Cina pubblica un libro bianco sulle sue proposte e azioni per costruire “una comunità globale dal futuro condiviso”.
By Yang Sheng and Li Xuanmin

Il governo cinese ha pubblicato martedì un libro bianco per introdurre la base teorica, la pratica e lo sviluppo di una comunità globale di futuro condiviso, in modo da contrastare, presentando la visione cinese del corso dello sviluppo umano, il pensiero egemonico di alcuni Paesi che cercano la supremazia.
Dieci anni fa, il presidente cinese Xi Jinping ha avanzato l’idea di costruire una comunità globale dal futuro condiviso. “La sua proposta illumina il percorso da seguire mentre il mondo annaspa alla ricerca di soluzioni e rappresenta il contributo della Cina agli sforzi globali per proteggere la casa comune e creare un futuro migliore di prosperità per tutti”, si legge nel libro bianco, intitolato “Una comunità globale dal futuro condiviso: Proposte e azioni della Cina”.
Il momento in cui viene pubblicato questo documento è cruciale, poiché oltre a segnare il 10° anniversario della proposta di un’idea significativa, il mondo è in grave turbolenza e sta vivendo profondi cambiamenti che non si erano mai visti nell’ultimo secolo, per cui la comunità internazionale ha chiesto soluzioni e la Cina, in quanto grande potenza responsabile e molto più potente di 10 anni fa, ha la responsabilità di contribuire con la sua saggezza e le sue azioni a soddisfare la domanda di quest’epoca, hanno detto gli analisti cinesi.
Secondo gli esperti cinesi, il Libro bianco, senza menzionare gli Stati Uniti, ha espresso chiaramente una ferma opposizione a molte idee e comportamenti di Washington, come “democrazia contro autoritarismo”, “confronto basato sull’alleanza” e “cortile piccolo, recinto alto”, a dimostrazione del fatto che la Cina è ora apertamente in disaccordo con l'”ordine basato sulle regole” proposto dagli Stati Uniti, che in realtà è un modo per preservare il vecchio ordine dominato dall’egemonia statunitense.
Molte idee e comportamenti dell’Occidente guidato dagli Stati Uniti hanno già causato conflitti e tensioni infinite e continue in tutto il mondo e porteranno il mondo a una nuova guerra fredda. La Cina e la maggior parte dei Paesi del mondo condividono preoccupazioni simili e hanno la responsabilità di trovare un percorso per riformare efficacemente l’ordine mondiale e costruire una comunità globale dal futuro condiviso, hanno detto gli esperti.
Opporsi e proporre
Il gioco a somma zero è destinato a fallire, si legge nel Libro bianco. “Ma alcuni Paesi si aggrappano ancora a questa mentalità, perseguendo ciecamente la sicurezza assoluta e i vantaggi monopolistici, che a lungo andare non giovano al loro sviluppo, ma creano una grave minaccia per il mondo”.
È sempre più evidente che l’ossessione per la forza superiore e la mentalità a somma zero sono in conflitto con le esigenze del nostro tempo, si legge nel libro bianco, sottolineando che la nuova era richiede nuove idee.
Wu Xinbo, direttore del Centro per gli studi americani dell’Università di Fudan, ha dichiarato martedì al Global Times che molti modi di pensare e azioni degli Stati Uniti sono contrari agli interessi della Cina e della grande maggioranza dei Paesi del mondo.
“Come grande Paese responsabile, noi, la Cina, dovremmo chiarire la nostra posizione e dire chiaramente al mondo cosa stiamo sostenendo e, se vogliamo che gli altri Paesi ci sostengano, dovremmo dire loro dove stiamo andando”, ha detto Wu.
Il Libro bianco e le iniziative proposte dalla Cina non mirano a sfidare gli Stati Uniti e l’Occidente o a servire l’ambizione della lotta per il potere, ma in realtà a procedere nell’interesse comune dell’umanità, perché “l’approccio degli Stati Uniti porterà sicuramente il mondo a una nuova guerra fredda”, ha osservato Wu.
Le proposte e le azioni della Cina non sono per il proprio beneficio o interesse personale, ma per il bene comune dell’umanità, ha detto l’esperto.
Il libro bianco afferma che “costruire una comunità globale dal futuro condiviso significa perseguire l’apertura, l’inclusione, il mutuo beneficio, l’equità e la giustizia”. L’obiettivo non è quello di sostituire un sistema o una civiltà con un’altra. Si tratta invece di paesi con sistemi sociali, ideologie, storie diverse, diritti condivisi e responsabilità condivise negli affari globali, si legge nel documento.
Maya Majueran, direttrice della Belt and Road Initiative Sri Lanka (BRISL), un’organizzazione con sede in Sri Lanka specializzata nella cooperazione BRI, ha dichiarato al Global Times che “gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali cercano da tempo di influenzare gli altri Paesi e l’ordine mondiale con i propri valori e il proprio sistema politico in nome della promozione della democrazia e dei diritti umani e continuano a fare pressione sui Paesi le cui posizioni differiscono da loro”.
“Molti Paesi guardano alla proposta della Cina come a un motore per stimolare la propria ripresa economica allineandosi con essa”, ha detto Majueran.
Li Haidong, professore presso la China Foreign Affairs University, ha dichiarato al Global Times che le proposte e le iniziative della Cina sono state accolte con favore in tutto il mondo, ma alcuni Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, cercano sempre di boicottare, stigmatizzare o sminuire le proposte della Cina, a causa della loro arroganza e ignoranza, e non vogliono che il sistema internazionale iniquo che li avvantaggia ingiustamente venga riformato.
Saggezza e azioni
Il concetto di comunità globale del futuro condiviso ha radici profonde nel profondo patrimonio culturale della Cina e nella sua esperienza unica di modernizzazione. Porta avanti le tradizioni diplomatiche della Cina e attinge alle straordinarie conquiste di tutte le altre civiltà, si legge nel Libro bianco. Inoltre, manifesta le antiche tradizioni storiche della Cina, le caratteristiche distintive dei tempi e la ricchezza dei valori umanistici.
Il Libro bianco ha anche indicato la direzione e il piano per costruire una comunità globale dal futuro condiviso, tra cui l’avanzamento di un nuovo tipo di globalizzazione economica in cui i Paesi devono perseguire una politica di apertura e opporsi esplicitamente al protezionismo, all’erezione di recinti e barriere, alle sanzioni unilaterali e alle tattiche di massima pressione, in modo da collegare le economie e costruire congiuntamente un’economia mondiale aperta.
Il concetto sostenuto dalla Cina non si basa sul sacrificio degli interessi dei Paesi vicini, in netto contrasto con la fase di accumulo di capitale dei Paesi occidentali, ha dichiarato al Global Times Wirun Phichaiwongphakdee, direttore del Centro di ricerca Thailandia-Cina sulla Belt and Road Initiative.
L’esperto thailandese ha citato alcuni progetti BRI nel Sud-est asiatico, tra cui la ferrovia Cina-Thailandia in fase di costruzione, che secondo lui dimostra come la Cina e l’ASEAN stiano lavorando insieme per costruire una comunità dal futuro condiviso.
Contributi convincenti
La Cina non si limita a fornire proposte, ma attua attivamente le proprie idee con le azioni, e ha fornito al mondo un’ampia serie di risultati. Nell’ultimo decennio, la Cina ha contribuito con forza alla costruzione di una comunità globale dal futuro condiviso, con convinzione e azioni solide.
Ad esempio, entro il luglio 2023, più di tre quarti dei Paesi del mondo e oltre 30 organizzazioni internazionali avevano firmato accordi di cooperazione con la Cina sulla Belt and Road. La BRI è nata in Cina, ma le opportunità e i risultati che crea appartengono al mondo intero. È un’iniziativa di cooperazione economica, non di alleanze geopolitiche o militari, ed è un processo aperto e inclusivo che non si rivolge a nessuna parte né la esclude, si legge nel libro bianco.
Tra i vari progetti BRI, ad esempio, la ferrovia Cina-Laos è entrata in funzione il 3 dicembre 2021, con 167 gallerie e 301 ponti costruiti in 11 anni sulla sua lunghezza totale di 1.035 chilometri. La costruzione della ferrovia ha creato più di 110.000 posti di lavoro a livello locale e ha contribuito alla costruzione di circa 2.000 chilometri di strade e canali per i villaggi lungo la ferrovia, a beneficio della popolazione locale.
Inoltre, grazie alla mediazione della Cina, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno raggiunto una storica riconciliazione all’inizio di quest’anno, dando il buon esempio ai Paesi della regione per la risoluzione delle controversie e delle differenze e per il raggiungimento di relazioni di buon vicinato attraverso il dialogo e la consultazione, e catalizzando un’ondata di riconciliazione in Medio Oriente.
La Cina ha anche proposto una serie di iniziative regionali e bilaterali per costruire comunità dal futuro condiviso e lavorare con le parti interessate per costruire il consenso e ampliare la cooperazione, svolgendo così un ruolo costruttivo nella promozione della pace e dello sviluppo regionale. La Cina ha inoltre potenziato la cooperazione internazionale in settori quali la lotta alla pandemia COVID-19, la gestione del disordine nella governance del cyberspazio e la gestione della sfida climatica globale.
Tra i vari progetti BRI, ad esempio, la ferrovia Cina-Laos è entrata in funzione il 3 dicembre 2021, con 167 gallerie e 301 ponti costruiti in 11 anni sulla sua lunghezza totale di 1.035 chilometri. La costruzione della ferrovia ha creato più di 110.000 posti di lavoro a livello locale e ha contribuito alla costruzione di circa 2.000 chilometri di strade e canali per i villaggi lungo la ferrovia, a beneficio della popolazione locale.
Inoltre, grazie alla mediazione della Cina, l’Arabia Saudita e l’Iran hanno raggiunto una storica riconciliazione all’inizio di quest’anno, dando il buon esempio ai Paesi della regione per la risoluzione delle controversie e delle differenze e per il raggiungimento di relazioni di buon vicinato attraverso il dialogo e la consultazione, e catalizzando un’ondata di riconciliazione in Medio Oriente.
La Cina ha anche proposto una serie di iniziative regionali e bilaterali per costruire comunità dal futuro condiviso e lavorare con le parti interessate per costruire il consenso e ampliare la cooperazione, svolgendo così un ruolo costruttivo nella promozione della pace e dello sviluppo regionale. La Cina ha inoltre potenziato la cooperazione internazionale in settori quali la lotta alla pandemia COVID-19, la gestione del disordine nella governance del cyberspazio e la gestione della sfida climatica globale.
Nell’ultimo decennio, la visione di una comunità globale dal futuro condiviso ha ottenuto un sostegno più ampio. Un numero maggiore di Paesi e di persone ha compreso che questa visione serve gli interessi comuni dell’umanità, rappresenta le richieste popolari di pace, giustizia e progresso e può creare la massima sinergia tra tutte le nazioni per costruire un mondo migliore”, si legge nel Libro bianco.
FONTE: https://www.globaltimes.cn/page/202309/1298963.shtml
Traduzione: Cambiailmondo.org
Scarica il “libro bianco”
Macron vuole un invito al vertice dei BRICS? L’idea è coraggiosa e innovativa: l’Editoriale del Global Times di Pechino

Secondo quanto riportato dai media francesi, il Presidente francese Emmanuel Macron avrebbe chiesto al Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa di essere invitato al vertice dei BRICS in programma ad agosto. La notizia non è stata ancora confermata dall’Eliseo e il portavoce del presidente sudafricano ha dichiarato di non essere a conoscenza della richiesta di Macron. Mosca ha chiesto a Parigi di fornire una spiegazione: Vogliono stabilire ancora una volta un qualche tipo di contatto per mostrare l’attività di Parigi, oppure si tratta di una sorta di cavallo di Troia? La notizia ha suscitato una notevole attenzione, ma gli atteggiamenti delle varie parti in causa sono diversi. I media francesi hanno commentato: “È una cosa un po’ folle e senza precedenti”. In ogni caso, considerando l’attuale panorama internazionale, si tratta di un’idea audace e innovativa.
Considerare questa idea audace o addirittura “folle” è stata la reazione iniziale di molte persone quando hanno appreso la notizia. Vale la pena di approfondire il perché di questo atteggiamento. Ciò indica che le persone hanno assunto inconsciamente la divisione tra Nord e Sud e quella tra Est e Ovest come uno stato normale, al punto che anche un pensiero che possa rompere queste norme e schemi mentali appare piuttosto sorprendente.
D’altra parte, però, questa idea sembra ragionevole. La Francia è un grande Paese europeo che si è reso conto in anticipo dei cambiamenti storici che si stanno verificando nel panorama globale. Lo stesso Macron ha fatto dichiarazioni sorprendenti in diverse occasioni, dimostrando un certo livello di autonomia separato da Washington. Questi fattori fanno pensare che non sarebbe particolarmente strano se Macron partecipasse al vertice dei BRICS. Il fatto stesso che queste notizie emergano in Francia e non in altri Paesi la dice lunga.
I Paesi membri dei BRICS sono tutte economie emergenti che rappresentano gli interessi dei Paesi in via di sviluppo nella comunità internazionale. In quanto Paese sviluppato, è possibile che la Francia partecipi al Vertice dei BRICS? Che tipo di reazione chimica genererebbe la partecipazione della Francia? A prescindere da altri fattori specifici e intricati, nel contesto della crescente divisione tra Nord e Sud, Est e Ovest, e dell’intensificarsi dei confronti sul campo, è necessario che qualcuno trascenda le barriere ideologiche e geopolitiche e si liberi da vincoli mentali e concettuali. Questo potrebbe potenzialmente portare a effetti positivi inaspettati.
Macron ha sottolineato che l’Europa dovrebbe perseguire una “autonomia strategica” e la Francia ha anche una tradizione di diplomazia indipendente. Se la Francia riuscirà davvero a fungere da ponte tra i diversi schieramenti nelle divisioni e spaccature del mondo, sicuramente farà risaltare il suo status internazionale e creerà risultati storici. Macron ha chiaramente queste ambizioni e sta facendo questi tentativi e sforzi. Lo apprezziamo e lo rispettiamo, e siamo disposti a comprendere con benevolenza il rilascio da parte della Francia di informazioni sul desiderio di Macron di partecipare al vertice dei BRICS.
Tuttavia, ad essere sinceri, le preoccupazioni di Mosca non sono superflue. La Francia dovrebbe anche essere consapevole di quanto sia profonda la frattura tra Paesi occidentali e non occidentali e quanto sia sottile la fiducia reciproca. Soprattutto lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina e il contenimento e la reprimenda della Cina da parte degli Stati Uniti hanno creato una pressione sempre maggiore per costringere i Paesi a “schierarsi”. È molto difficile (in questo contesto, ndt) per la Francia ottenere un’autentica autonomia strategica e una diplomazia indipendente.
Dopo la visita di Macron in Cina ad aprile, egli ha esortato l’Europa a sviluppare una maggiore autonomia strategica, provocando una polemica simile a uno tsunami in Europa e negli Stati Uniti. Se poche parole hanno portato a una situazione del genere, è prevedibile che le resistenze incontrate saranno molto forti se si agisce (di conseguenza, ndt). È inevitabile che ci si chieda fino a che punto la Francia possa agire secondo la propria volontà o se debba ancora conformarsi alle forti opinioni di Washington. I Paesi BRICS devono considerare la notizia della richiesta di Macron in modo completo e attento.
Una cosa è certa: Questa vicenda ha dimostrato l’enorme influenza del meccanismo di cooperazione dei BRICS. “BRICS+” aderisce al principio del multilateralismo, attirando decine di economie emergenti e Paesi in via di sviluppo a partecipare al processo di cooperazione, che coincide con il nuovo multilateralismo sostenuto da Francia ed Europa. Il “BRICS+” può aprirsi ai Paesi sviluppati come la Francia, grazie alla sua enorme influenza nei Paesi in via di sviluppo? Si tratta di una domanda interessante, che l’organizzazione BRICS potrebbe prendere in seria considerazione alla luce di questa notizia. Tuttavia, deve essere pragmatica, non formalistica, e non lasciare che il perseguimento di questa forma influisca sulla cooperazione pragmatica del meccanismo BRICS stesso.
Diverso da un circolo ristretto come il Gruppo dei Sette (G7), il meccanismo dei BRICS esiste come piattaforma emergente per la governance globale. Aderisce all’apertura, all’inclusione, alla cooperazione e ai risultati vantaggiosi per tutti e crea un partenariato di sviluppo globale unito, equo, equilibrato e inclusivo. Purché si presentino con uguaglianza e buona volontà e vogliano sinceramente promuovere la cooperazione e lo sviluppo, i Paesi BRICS accolgono con favore la partecipazione di altre entità alla cooperazione allo sviluppo globale, tra cui non solo la Francia, ma anche gli Stati Uniti.
FONTE: https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292607.shtml – (14/06/2023)
Traduzione: cambiailmondo.org
Come la Cina si protegge dalle incursioni dei capitali speculativi dell’economia-mondo
di Giordano Sivini

Da una ricerca storica sulla Repubblica Popolare Cinese del ‘900 è emersa l’ipotesi, esplicitata fin dal titolo “La costituzione materiale della Cina. Le ragioni storiche della crescita del capitalismo cinese fuori dall’economia-mondo finanziarizzata” (Asterios, 2022), che all’incessante sviluppo cinese nel nuovo millennio abbiano contribuito gli investimenti diretti dall’estero e il concomitante divieto agli investimenti di portafoglio di entrare nell’area di accumulazione cinese. Il divieto era stato deciso alla fine degli anni ’90. La Cina stava preparandosi ad entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio e adeguava il sistema istituzionale ed economico alle forme del capitalismo globale. Nel 1996 aveva promesso al Fondo Monetario Internazionale che la ‘moneta del popolo’, il renminbi, sarebbe stata resa gradualmente convertibile, ma il sopravvenire della crisi finanziaria asiatica fece bloccare il processo. Mentre nell’economia globalizzata i capitali produttivi stavano diventando tributari di quelli finanziari (Sivini, 2018), in Cina venne presa la decisione di vietare l’ingresso a quei capitali esteri che non avessero obiettivi immediatamente produttivi.
L’ipotesi che l’elemento distintivo del capitalismo cinese fosse legato a questa decisione è ripresa in esame in questo articolo alla luce delle autorizzazioni date dalla Cina nel nuovo millennio ad investitori stranieri ad operare in borsa e a grandi istituti finanziari esteri di realizzarvi investimenti di portafoglio. Il fine principale di queste aperture è stato di rendere il mercato finanziario cinese più competitivo, capace di produrre innovazioni nel sistema finanziario, orientato a sostenere le attività produttive ma ritenuto scarsamente efficiente.
Le autorizzazioni sono state accompagnate dal vincolo di operare in renminbi in condizioni paritetiche con i soggetti cinesi già operativi. Questo vincolo produce effetti analoghi a quelli del divieto, progressivamente rimosso, ai capitali finanziari speculativi di entrare in Cina, poiché li priva dello spazio globale di mobilità che caratterizza le loro incursioni speculative. Concludendo, l’ipotesi iniziale va rivista per considerare anche che, in ultima istanza, gli stretti limiti alla convertibilità dl renminbi fungono da dispositivo di sicurezza dell’area di accumulazione cinese rispetto all’economia-mondo finanziarizzata.
Lo spazio produttivo e l’accumulazione
Giovanni Arrighi utilizza rispettivamente i termini ‘centri di accumulazione’ e ‘reti di accumulazione’ per cogliere con quest’ultimo la molteplicità dei processi di formazione del capitale, e con l’altro le posizioni di comando su questi processi (Arrighi, 1996). Si tratta di concetti che gli servono per definire l’autonomia relativa del capitale rispetto allo Stato, costituito da ‘reti di potere’, con il quale le reti e i centri di accumulazione stanno in rapporto, poiché “lo sviluppo dell’accumulazione su scala mondiale ha bisogno della presenza di un potere politico che organizzi i mercati, protegga gli investimenti, assicuri i profitti”. La trasformazione dell’economia-mondo capitalistica da sistema nel quale le reti di accumulazione erano incorporate e subordinate alle reti del potere, a sistema nel quale le reti del potere sono incorporate e subordinate alle reti di accumulazione, è avvenuta, secondo Arrighi, attraverso una serie di cicli sistemici, al cui interno sono emersi centri di accumulazione presieduti da specifici soggetti degli affari e della finanza.
La formazione dell’area di accumulazione cinese
Questa concettualizzazione serve per definire la collocazione della Cina popolare come rete di accumulazione incorporata e subordinata alla rete di potere del partito comunista, entrambe materialmente strutturate dalla leadership che è al centro di entrambe le reti. La formazione della Repubblica Popolare uscita dalla guerra rivoluzionaria, ha evitato che le potenzialità del grande spazio produttivo cinese fossero sottomesse al giogo del capitalismo, termine con cui Mao definiva ogni tipo di sfruttamento e di diseguaglianza. La Cina non sarebbe stata una economia sottoposta al dominio esterno come tutte quelle che nell’economia-mondo avevano cercato di emergere liberandosi dei vincoli dell’imperialismo; doveva affermarsi e svilupparsi entro un proprio spazio economico. Per realizzare il socialismo – obiettivo del partito comunista che aveva guidato la rivoluzione – questo spazio doveva essere esterno al mondo capitalista.
Anche se importanti risorse venivano dal sistema industriale rimesso in piedi dai tecnici sovietici, il 90 per cento della popolazione, liberata dal movimento rivoluzionario, si era appropriata della terra, generale mezzo di produzione e di sostentamento. L’accumulazione di ricchezza era alimentata dal plus prodotto realizzato dal lavoro contadino in forma cooperativa e dal lavoro industriale socializzato e pianificato (Sklair.1979: Riskin, 1987). Confiscati gli istituti finanziari, alla liberazione venne costituita la Banca popolare e creata la ‘moneta del popolo’, renminbi, stabilendo, nell’ambito del sistema di Bretton Woods, il suo valore di scambio rispetto al dollaro statunitense. La ricchezza sociale, costituita da beni d’uso a prezzi valutati politicamente in renminbi, confluiva nel centro dell’area di accumulazione controllata dal partito comunista, che la redistribuiva. Si aggiungeva a quella dei beni confiscati, da un cospicuo prestito in rubli da parte dell’Unione Sovietica, e dalle ripetute emissioni di prestiti nazionali, che davano interessi più alti rispetto ai depositi bancari (Le renminbi, 1969)
Nelle analisi sulla Cina popolare la separazione della sua area di accumulazione da quella dell’economia-mondo non viene mai colta. Implicitamente si assume che il capitalismo siia tutto includente, tutt’al più sistema-mondo di aree produttivamente interconnesse, nel quale un centro si impone sulle periferie e ne sfrutta le risorse (Minqi, 2016). Mao non ha posto la Cina come periferia; l’ha posta come nuova entità sovrana indipendente, autodeterminata, appunto come area di accumulazione separata dall’economia-mondo capitalistica. Cambiando radicalmente percorso, le leadership successive hanno realizzato la crescita del paese all’interno di quest’area, ribadendone la sovranità soprattutto rispetto alle minacce del capitale finanziario globale, e facendo dell’apertura selettiva all’economia-mondo una condizione per la sua propria crescita.
L’apertura controllata all’economia-mondo
Per creare ricchezza espandendo la scala della produzione e aumentando la produttività, la Cina aveva bisogno di mezzi finanziari e tecnologici. L’economia-mondo li ha forniti, nelle forme della valuta pregiata creata dai profitti tratti dalle esportazioni, degli investimenti diretti dall’estero e delle partecipazioni azionarie e obbligazionarie a capitali cinesi.
Alla fine degli anni ’70 Deng Xiaoping adottò una strategia che, ribaltando quella maoista, attribuiva priorità allo sviluppo delle forze produttive rispetto alla diffusione di rapporti di produzione egalitari, ed eliminò i vincoli produttivi basati sulla cooperazione e la pianificazione. Il mercato interno dei capitali decollò nei primi anni ’80 del ‘900, dando il via ad un fiorire di iniziative private che, rompendo il monopolio bancario, portarono alla formazione di una economia ombra e persino ad una febbre azionaria. Un intenso traffico valutario era causato dal sistema di doppia valuta che consentiva l’uso del renminbi per transazioni domestiche, mentre prevedeva certificati di cambio per quelle con l’estero (Vic, 2018). Il flusso transfrontaliero di capitali era ridotto e il conto corrente sostanzialmente in pareggio, in quanto gli importi delle esportazioni venivano determinati dal fabbisogno di divise estere per le importazioni, agendo su una sorta di liberalizzazione selettiva anticipata dei loro controlli, secondo il principio ‘prima l’afflusso, poi il deflusso’ (Huang, 2011). Dopo Tienanmen il governo si impegnò a regolare il mercato, e le iniziative locali vennero frenate e portate sotto il controllo centrale. Un inserimento nel mercato globale dei capitali fu possibile dopo lo sbarco nel 1992 del primo titolo cinese alla Borsa di New York.
Mentre le società cinesi si rivolgevano ai mercati azionari esteri per drenare risorse finanziarie, le società estere entravano in Cina nella forma di investimenti diretti. Particolarmente interessate erano le multinazionali, per le quali la costante crescita economica cinese, la valuta stabile, la modesta inflazione e il basso costo della forza lavoro costituivano rilevanti garanzie di espansione, sia all’interno del paese sia come base per la produzione di componenti e di merci finite da esportare. Nella seconda metà degli anni ’90 la Cina diventò il secondo destinatario al mondo di investimenti diretti esteri, superata solo dagli Stati Uniti. Dal 1979 al 1996, entrarono in attività oltre 140 mila imprese a capitale straniero. La loro quota sul totale della produzione industriale cinese raggiunse il 13 per cento con 17 milioni di dipendenti.
L’approdo in Cina rispondeva alla necessità dei capitali occidentali di superare la crisi di sovra produzione che l’economia-mondo stava sperimentando proprio negli anni in cui Deng Xiaoping e Zhu Rongji aprivano le porte. “Gli stranieri stanno attivamente cercando di venderci beni in eccedenza, tutti i beni in eccedenza del mondo”, fece notare Zhu, capo del governo, quando Jiang Zemin era segretario del partito. Nel 1996 erano stati allentati i controlli dei flussi di capitali transfrontalieri e il governatore della Banca centrale cinese aveva rassicurato il Fondo Monetario Internazionale che nel giro di dieci anni sarebbe stata realizzata la convertibilità della moneta cinese (Huang 2011). L’anno successivo la crisi finanziaria asiatica bloccò questo processo, inducendo la Cina a prendere misure per tutelarsi dalle scorribande del capitale finanziario dell’economia-mondo. Al governo fu chiaro che gli investimenti esteri avrebbero dovuto soltanto servire alla crescita dell’economia reale (Nolan, 2004; 2021). Zhu impose barriere alle attività speculative internazionali, una strategia mantenuta successivamente. “I leader cinesi hanno spesso sottolineato che la finanza non dovrebbe avere altro scopo che quello di sostenere gli investimenti e quindi la crescita economica” (Subacchi, 2017).
Favorevoli e contrari agli investimenti esteri di portafoglio
In Cina si è sviluppato dopo gli anni 2010 un intenso dibattito sull’apertura del paese ai flussi dei capitali finanziari internazionali sotto forma di investimenti di portafoglio. La banca centrale cinese ne ha sostenuto la liberalizzazione, e i suoi funzionari hanno spinto in questa direzione fin dagli anni ’80. La posizione rifletteva gli interessi del settore, ma era condivisa al di fuori del sistema bancario anche da economisti dell’imprenditoria privata e da politici che ritenevano che le restrizioni, più che proteggere dagli shock esterni, consentissero, in mancanza di competitività con l’estero, comportamenti finanziari interni irresponsabili. L’opposizione alla liberalizzazione veniva invece da vari settori intellettuali, come l’Accademia cinese delle scienze sociali, e da funzionari e politici con legami con le grandi imprese statali che beneficiavano della chiusura e mettevano soprattutto in rilievo gli effetti dirompenti della globalizzazione finanziaria su molti paesi in via di sviluppo (Steinberg, 2020).
La vulnerabilità del sistema bancario cinese alle pressioni della finanza internazionale era già stata sottolineata da James Petras. “Appena il settore finanziario statunitense ed europeo entreranno in partnership con le banche cinesi, probabilmente useranno le loro controparti come leva per cooptare, corrompere e fare pressioni su funzionari locali e statali al fine di liberalizzare ulteriormente, estendendo l’accesso straniero alle azioni, alle obbligazioni, ai titoli, al risparmio e, alla fine, alla proprietà completa di settori finanziari strategici” (Petras, 2007).
All’inizio del 2012 la Banca centrale produsse un documento che chiedeva di accelerare la liberalizzazione dei movimenti dei capitali. Justin Yifu Lin, economista, consigliere del governo cinese, già capo economista e vice presidente senior della Banca Mondiale, colse l’occasione di una tavola rotonda per un duro intervento critico. “Non sono d’accordo – disse – con la posizione del Direttore Generale della Banca centrale Sheng secondo cui “altri paesi con condizioni più povere hanno completamente liberalizzato il loro conto capitale, perché noi non dovremmo?”. Quei paesi si sono completamente liberalizzati, ma le loro economie non sono andate bene come la nostra. Perché dovremmo liberalizzare completamente? Le nuove teorie proposte dagli accademici finanziari degli Stati Uniti non riescono a capire la differenza tra capitale finanziario e capitale reale (…). Di fronte alle pressioni del governo degli Stati Uniti e del FMI, noi dobbiamo stare sulla difensiva, e la Banca popolare cinese deve essere in prima in linea. Con tutto il capitale speculativo che fluisce in tutte le direzioni e che penetra in ogni crepa, la gestione macroeconomica deve mantenere l’autonomia della politica monetaria” (Li, 2013).
Le Banche centrali dei paesi sviluppati dopo la crisi del 2008 avevano fatto ricorso a politiche monetarie espansionistiche. L’economia globale era stata inondata di liquidità, e i capitali finanziari avevano accelerato la ricerca di porti sicuri e di occasioni per speculare. Le autorità cinesi avevano ampliato la sfera delle operazioni in renminbi degli operatori stranieri QFII (Qualified Foreign Institutional Investors) ammessi ai mercati finanziari interni nel quadro di un programma lanciato già nel 2002. Nel 2014 era stato creato lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect, allargato due anni dopo a Shenzhen, per consentire di operare in renminbi sulle tre Borse; nel 2019 il collegamento tra Shanghai e Londra ha espanso le attività ai mercati europei dei capitali (Lardy, 2020).
Queste forme di crescente ma controllata apertura al capitale finanziario internazionale speculativo avevano l’obiettivo di attrarre investimenti e di spingere i capitali cinesi a rispondere alle sollecitazioni degli investitori esteri. “Negli ultimi anni, la Cina ha mantenuto una liquidità sufficiente, i tassi di interesse di mercato sono ampiamente diminuiti e la crescita del finanziamento aggregato ha tenuto il passo con la crescita del PIL nominale. Nel complesso, alla Cina non mancano i fondi, manca il capitale”, ha rilevato Yi Huiman, presidente della China Securities Regulatory Commission, in una analisi pubblicata alla vigilia del ventesimo congresso del partito comunista (Huiman, 2022).
L’apertura ‘con caratteristiche cinesi’ agli istituti finanziari globali
Preannunciata nel 2018, l’apertura al capitale finanziario dell’economia mondo si è realizzata l’anno successivo con le autorizzazioni ai grandi istituti finanziari di inserirsi sul mercato cinese tramite proprie fiduciarie su basi competitive con i soggetti cinesi già presenti. La misura anticipava l’Accordo di fase uno USA-Cina, firmato nel gennaio 2020 da Trump, che imponeva la rimozione delle barriere commerciali e di investimento per i fornitori statunitensi di un’ampia gamma di servizi finanziari, inclusi quelli bancari, assicurativi, mobiliari e di rating. Alcuni istituti, come Goldman Sachs, UBS, Credit Suisse e Morgan Stanley, erano già presenti in Cina da tempo, ma operavano da posizioni minoritarie in joint venture con entità locali; nel nuovo contesto potevano acquistare esclusiva capacità operativa.
A metà 2021 sono oltre cento le fiduciarie cinesi possedute dagli istituti esteri autorizzati ad operare in Cina. Ci sono istituti di compensazione per la gestione delle carte bancarie American Express e Mastercard; società di gestione patrimoniale facenti capo ad Amundi e BlackRock; banche di investimento come Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse, JPMorgan Chase, Nomura, DBS e Daiwa; società di rating come Standard & Poor e Fitch; e Yagi Tanshi per l’intermediazione valutaria. Generalmente i soggetti che operano sul mercato interno sono giuridicamente cinesi ed hanno nomi associati a quelli dei proprietari esteri (Panpan, 2022).
Yi Gang, governatore della Banca centrale cinese, dando comunicazione nel marzo 2019 dell’imminente misura, da lui già annunciata nel dicembre precedente, è molto chiaro: “Per l’apertura del settore finanziario sarà prevista la parità di trattamento per le istituzioni cinesi e quelle straniere in termini di requisiti e standard normativi, come la partecipazione azionaria, la forma di costituzione, la qualificazione degli azionisti, l’ambito di attività e il numero di licenze. Le istituzioni finanziate dalla Cina e dall’estero saranno trattate allo stesso modo trasparente e coerente con la pratica internazionale”.
Il governatore sottolinea che l’apertura del settore finanziario non comporta di per sé rischi finanziari per la Cina, ma può aumentare la complessità per prevenirli. “Faciliteremo gli investimenti esteri e miglioreremo la trasparenza del quadro giuridico, dei regolamenti, del sistema contabile e fiscale per gestire i rischi in modo efficace. Secondo me, siamo in grado di soddisfare l’esigenza di apertura del settore finanziario. Molti investitori globali vogliono investire nel regime valutario renminbi. Nell’attuale quadro di politica monetaria siamo in grado di gestire i rischi finanziari associati all’integrazione della Cina nell’economia globale e alla globalizzazione economica. Dal momento che il paese si è integrato nell’economia globale attraverso il commercio, gli investimenti, i servizi e il turismo, apriremo anche il settore finanziario e miglioreremo di conseguenza la politica monetaria”.
“Quello finanziario è un settore sottoposto a licenze”, aggiunge il governatore rispondendo ad una domanda. “Quando si tratta di raccogliere fondi dal pubblico si deve prestare grande impegno alla prevenzione dei rischi. Nel rilasciare licenze va fatta attenzione alla protezione dell’interesse pubblico, in particolare agli interessi dei depositanti al dettaglio e a quelli degli investitori. L’innovazione finanziaria ha accresciuto anche l’importanza del coordinamento normativo transfrontaliero. Molte innovazioni finanziarie comportano flussi di transfrontalieri di denaro, servizi e gestione patrimoniale. Il coordinamento normativo transfrontaliero è quindi imperativo” (Gang Yi, 2019).
I problemi di competitività delle fiduciarie di proprietà estera sono evidenziati dal quotidiano economico cinese indipendente Caixin. “Quattro istituti stranieri hanno acquisito partecipazioni di controllo nelle loro joint venture mobiliari, Goldman, UBS, Credit Suisse e Morgan Stanley. Altri quattro sono stati autorizzati a costituire società possedute a maggioranza o totalmente: il gigante americano dei servizi finanziari JPMorgan Chase, i titani finanziari giapponesi Nomura Holdings e Daiwa Securities, e il colosso bancario di Singapore DBS. La banca francese BNP Paribas, la giapponese SMBC Nikko Securities e la britannica Standard Chartered sono in attesa di approvazione per costituire società di intermediazione mobiliare. Una volta ottenute le autorizzazioni ci saranno 11 società di titoli controllate dall’estero che opereranno in un mercato affollato da oltre 140 soggetti, dominato da giganti di proprietà statale come Citic Securities, Huatai Securities e Guotai Junan Securities”.
“Nel settore della gestione patrimoniale, tre società straniere hanno ottenuto l’approvazione per costituire società di fondi comuni interamente controllate, BlackRock, Fidelity International e Neuberger Berman; altre tre sono in attesa di autorizzazione, Van Eck Associates, Alliance Bernstein e Schroders. Saranno in competizione con oltre 130 gestori di fondi comuni tra cui E Fund Management, China Universal Asset Management e GF Fund Management, che hanno registrato un utile netto del primo semestre 2021 compreso tra 1,3 e 1,8 miliardi di yuan”. (Yue, 2021)
Anche il Financial Times, definendo China’s Bing Bang l’apertura cinese agli istituti finanziari esteri, affronta il problema della loro competitività facendo riferimento ad alcune esperienze pregresse. JP Morgan, afflitto da battute d’arresto e da costi proibitivi che hanno limitato l’investment banking, ha perso in Cina 40 milioni di dollari negli ultimi due anni. Tuttavia considera che le perdite sono un prezzo necessario per un futuro redditizio; inoltre le commissioni raccolte dalla consulenza alle società cinesi sulle quotazioni a New York e Hong Kong sarebbero state molto più difficili da ottenere senza la base in Cina.
JPMorgan non è il solo ad aver finora fallito nel capitalizzare gli investimenti in Cina. Delle sette banche globali, solo tre – Goldman, UBS e Deutsche Bank – sono state redditizie negli ultimi tre anni; le altre – JPMorgan, Morgan Stanley, Credit Suisse e HSBC – sono in rosso. “Tutti gli istituti di credito si affrettano a sottolineare che le entrate dichiarate per le loro banche di investimento non sono rappresentative delle più ampie attività bancarie in Cina, come la sottoscrizione di obbligazioni e la consulenza tramite diverse entità onshore, a Hong Kong o altrove. Nessuno di loro rivela i ricavi totali. Ma i numeri dimostrano che devono fare molta strada per conquistare una fetta significativa dell’enorme mercato”. Affrontano con strumenti globali di alta qualità una situazione molto meno sviluppata di quella a cui sono abituati, e in rapido movimento. Le loro ambizioni si scontrano con giganti bancari cinesi come Citic Securities e CICC, che con le attività di investment banking guadagnano più di un miliardo di dollari all’anno.
“Le banche in Europa e negli Stati Uniti sono abituate a una sorta di processo decisionale centralizzato basato sui più elevati standard normativi a livello globale”, ha fatto osservare un ex dirigente che ha abbandonato un ruolo di alto livello in una banca globale. “In Cina ti trovi in conflitto con le pratiche attuali, dove a volte non hai nemmeno le regole scritte (…). Alla fine questo si riduce a uno scontro di filosofie tra due civiltà” (Kinder, 2021).
La consapevolezza di questa diversità emerge dalle aspettative delle autorità cinesi che la competitività migliori l’efficienza del sistema finanziario con l’introduzione di nuove forme di gestione, di servizi e di prodotti. (Panpan, 2022). Un grande successo è segnalato nell’ottobre 2022 da China Daily, quotidiano cinese. Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo, nella prima metà dell’anno ha ottenuto il 4,76% sui suoi investimenti nel mercato azionario cinese, rispetto al benchmark locale dello stesso periodo, lo Shanghai Composite Index, che ha perso il 6,63%. Il nuovo prodotto, lanciato in maniera discreta in collaborazione con il partner locale CITIC Securities a giugno, è andato a ruba tra gli investitori. “Per gli istituti stranieri che devono ancora avere un assaggio del mercato cinese, Bridgewater è una rivelazione”. Analogamente, all’inizio di agosto, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale del mondo, ha rilasciato un nuovo prodotto incentrato sulle società manifatturiere avanzate quotate sul mercato cinese. “Non c’è da stupirsi, i giocatori stranieri si stanno dirigendo verso una fetta della torta del mercato cinese” (Jing, 2022).
La Cina ha subìto diversi inciampi negli anni recenti, in particolare nel settore immobiliare e in quello delle banche locali. Il recente congresso del Partito Comunista non ha rieletto nel Comitato centrale quattro esponenti di punta del settore finanziario, che nel giro di pochi mesi lasceranno gli incarichi: Liu He consigliere economico di Xi Jinping, Yi Gang governatore della Banca centrale, Liu Kun ministro delle Finanze, Guo Shuqing presidente dell’organismo di controllo sulle banche e le assicurazioni. Dalle loro dichiarazioni, raccolte dal quotidiano South China Morning Post, emergono problematiche di rilievo, dai rischi del debito occulto alla scarsa trasparenza della struttura azionaria delle istituzioni finanziarie, dallo scarso rispetto della loro indipendenza ai segni di ‘graduale indebolimento della leadership del Partito’ nel settore (lee, 2022). Gli istituti finanziari globali sono grandi contenitori di liquidità per investimenti produttivi e di portafoglio, ma anche di spiccate capacità operative, e le autorità cinesi puntano sull’acquisizione di entrambi.
Il renminbi come dispositivo di sicurezza dell’area di accumulazione
Renminbi è la valuta cinese la cui convertibilità estremamente controllata protegge dagli attacchi speculativi l’area di accumulazione della Repubblica Popolare Cinese in cui circola come unità di conto, mezzo di scambio e riserva di valore; lo yuan, che è la sua unità di base, ha la forma di CNY all’interno della Cina continentale e quella di CNH al di fuori di essa. Il conto capitale, che riguarda i flussi monetari in ingresso e in uscita nell’area, ha una apertura molto limitata. Ciò tuttavia non influisce sull’utilizzazione delle diverse valute nelle operazioni commerciali transfrontaliere, poiché, dopo l’ingresso della Cina nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, il conto corrente non è soggetto a restrizioni.
Al fine di rendere possibile una conversione valutaria del renminbi in conto capitale, le autorità cinesi hanno creato all’estero mercati off-shore dove i flussi di ricchezza, che accompagnano le attività commerciali e di investimento, prima di entrare nell’area di accumulazione cinese devono essere convertiti in renminbi, quali che siano le loro origini valutarie. Un mercato off-shore richiede perciò un deposito di renminbi allestito dalla Banca centrale cinese presso la Banca centrale del paese con la quale viene sottoscritto l’accordo swap per il cambio di valuta; da esso vengono attinti i renminbi per essere spostati verso la Cina continentale già nella forma onshore di CNY. I fondi originati in renminbi e non rimpatriati possono essere cambiati nella forma offshore di CNH in altra valuta. “Spostando tutte queste transazioni all’estero, le autorità monetarie intendono proteggere il mercato onshore della Cina continentale da movimenti di capitali indesiderati e potenzialmente destabilizzanti che potrebbero minare la stabilità finanziaria interna del paese” (Subacchi 2016).
Il primo accordo swap risale al 2008 e riguarda la Banca centrale cinese e quella della Corea del Sud. Da allora al 2020 ne sono stati sottoscritti molti altri. Accompagnano gli investimenti cinesi all’estero (ODI, Outward Direct Investment) che mirano ad allargare l’accesso a materie prime e a tecnologie avanzate, conquistare mercati di sbocco per le sovraproduzioni interne, e, dopo il 2013, realizzare grandi progetti infrastrutturali nel quadro della Belt and Road Initiative (BRI), della quale la Nuova Via della Seta è una componente. Per queste attività la Cina investe all’estero in renminbi e in forex, la valuta estera di cui dispone la Banca centrale cinese. Nell’agosto 2022 il forex ammonta, valutato in dollari, a 3 mila miliardi, la più alta riserva di qualsiasi paese del mondo. Origina dal cambio in renminbi delle valute provenienti dall’estero fatto dalla Banca, che le investe all’estero in titoli obbligazionari e di prestiti interbancari.
Sulla base di accordi bilaterali i progetti della BRI realizzano infrastrutture di rilevante portata con prestiti in renminbi che i paesi devono rimborsare, ma che spesso non incassano perché vengono direttamente erogati alle imprese cinesi appaltatrici, le quali utilizzano forza lavoro e fornitori propri (Amighini, 2020). La parte che i paesi ricevono in renminbi, immessa sul mercato interno contribuisce, a partire da relazioni di importazione con operatori cinesi, ad alimentare una rete di rapporti in continua espansione (Song, 2020)
Un contributo decisivo per l’allargamento a livello regionale di questo processo espansivo è dato dalla costituzione nel 2014 della l’Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), promossa dalla Cina e da altri 20 paesi. Nel giro di un anno i fondatori sono diventati 57, dei quali 45 asiatici, e, in seguito, se ne sono associati altri 63. L’adesione iniziale era stata stimolata dall’impegno cinese di sottoscrivere metà del capitale, ridotto al 31 per cento in seguito alle partecipazioni dei nuovi sottoscrittori, con un potere di voto del 27 per cento entro il 73 del complesso dei paesi asiatici. L’iniziativa, osteggiata dagli Stati Uniti e dal Giappone alla quale contrappongono l’Asian Development Bank, è una risposta specifica all’enorme domanda di connettività asiatica, e si concentra sulla costruzione di infrastrutture volte a migliorare l’integrazione economica regionale. Costituisce un potente strumento di diffusione del renminbi, che ha già iniziato a spezzare il dominio del dollaro (Bora, 2020).
Contemporaneamente alla costituzione della Banca regionale, la Cina ha promosso, assieme a Brasile, Russia, India e Sud Africa, al sesto summit dei BRICS la fondazione della New Development Bank BRICS, che, come la AIIB, ha sede in Cina. L’iniziativa era già stata preannunciata in un memorandum d’intesa del 2012, ma la decisione è stata formalizzata dopo negoziazioni fallite con il Fondo Monetario Internazionale per una distribuzione più equa delle quote di voto di Usa e Ue. La Banca ha un capitale iniziale di 50 miliardi di dollari, ma gestisce un fondo strategico di riserva di 100 miliardi (41 della Cina, 18 a testa del Brasile, India e Russia, e 5 dell’India) al quale i partecipanti possono ricorrere per far fronte a crisi della bilancia dei pagamenti o ad attacchi speculativi. Attiva dal 2016, la Banca sta finanziando progetti sia in dollari sia in renminbi, che per lo più riguardano infrastrutture.
Le due nuove banche, una regionale e l’altra globale, promosse dalla Cina hanno contribuito alla decisione del Fondo Monetario Internazionale, presa nel 2015 e attuata l’anno successivo, di riconoscere il renminbi come valuta di riserva di portata internazionale, tale da entrare nel paniere che definisce la composizione dei Diritti Speciali di Prelievo, accanto a dollaro, euro, sterlina e yen. Tutti i paesi detentori di DSP hanno dovuto far posto alla moneta cinese, con un peso che è passato dall’iniziale 10,92% al 12,28% nel maggio 2022. Il riconoscimento internazionale nonostante la permanenza dei serrati controlli cinesi sul conto di capitale, è un’implicita rinuncia alla pretesa di liberalizzazione da sempre sostenuta dal Fondo Monetario. Il renminbi resta “lo strumento di una globalizzazione al contrario: non è la Cina ad aprire il suo settore finanziario al resto del mondo, ma è quest’ultimo ad accogliere una sempre maggiore presenza della Cina sui mercati finanziari internazionali, nonostante Pechino continui a proteggere il suo sistema finanziario dalla potenziale instabilità di una liberalizzazione incondizionata”, dice Alessia Amighini (Martinasso, 2022).
Il futuro dipenderà da come verrà interpretata l’affermazione di Xi Jinping al ventesimo congresso del Partito Comunista: “Promuoveremo l’internalizzazione del CNY in modo ordinato”.
Riferimenti bibliografici
Amighini A., Finanza e potere lungo le Nuove Vie della Seta, Bocconi Editore, 2021.
Arrighi G., Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il Saggiatore, 1996.
Bora L., “The nexus of BRI and internalization of renminbi”, Business & Management, 1, 2020.
Gang Yi, Governor Yi Gang: Deepening reform and opening-up comprehensively. Create new prospects for financial sector, People’s Bank of China, 30 Dec. 2018.
Gang Yi, Further Open Up the Financial Sector to Promote High-Quality Growth, People’s Bank of China, 2 May 2019.
Huang Y., Wang X., Gou Q.,Wang D., “Achieving capital account convertibility in China”, China Economic Journal 4, 2011.
Huiman Y., “The development of typically modern Chinese capital markets”, Qiushi Journal. Oct. 25, 2022.
Jing S., “Power of long-term investment opportunities”, China Daily, Oct. 17, 2022.
Kinder T., “Global banks have bet on ‘bing bang’ in China, but will pay off?”, Financial Times, Nov. 24, 2021.
Lardy N.R., Huang T., “China Financial Opening Accelerates”. Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 20-17, 2020
Lee A., “4 weacknesses in China economy, from local government finances to poor regulation”, South China Morning Post, 14 Nov. 2022.
Le renminbi chinois. L’une des rares monnaies stable du monde, Editions en languages etrangeres, 1969.
Lin J.Y., “Why I Do Not Support Complete Capital Account Liberalization”, China Economic Journal, 1, 2015.
Ly B., “The nexus of BRI and internationalization of renminbi (RMB)”, Business Management, 1, 2020.
Martinasso M.V., “E-RMB: La moneta digitale essenziale per la strategia economica cinese”, Il Bollettino, 17 febbraio 2022.
Miao Y., Deng T., “China’s capital account liberalization: a ruby Jubilee and beyond”, China Economic Journal, 3, 2019.
Minqi L., China and the Twenty-First-Century Crisis, Pluto Press, 2016.
Nolan P., China and the Asian Financial Crisis, Routledge. 2004; 2021.
Overholt W.H.,Ma G., Law C.K., Renminbi rising: a new global monetary system emerges,Wiley, 2016.
Panpan Y., “China Promotes Reform by Opening up: The Prospects of Financial Opening up and Economic and Trade Cooperation”, China Watch, 3, 2022.
Riskin C., China’s Political Economy: The Quest for Development since 1949, Oxford University Press, 1987.
Sivini G., La costituzione materiale della Cina. Le ragioni storiche della crescita del capitalismo cinese fuori dall’economia-mondo finanziarizzata. Asterios, 2022.
Sivini G., “La centralizzazione del capitale e la caduta del saggio di profitto. Il peso del capitale fittizio a partire dalle evidenze empiriche del McKinsey Global Institute”, Palermo-grad, 2018.
Sklair L., “Relations of production, productive forces and the mass line in the formation of the rural people’s Communes in China”, Journal of Peasant Studies,1979.
Song K., Xia L., “Bilateral swap agreement and renminbi settlement in cross-border trade”, Economic and Political Studies, 3, 2020.
Steinberg D., McDowell D., Gueorguiev D., “Inside looking out: how international policy trends shape the politics of capital controls in China”, Pacific Review, 6, 2021.
Subacchi P., The people’s money: how China is building a global currency, Columbia University Press, 2017.
Vic L. Y-W., China’s financial opening: coalition politics and policy changes, Routledge, 2018.
Yang L., “Analysis of Capital Control Policies in China”, American Journal of Industrial and Business Management, 10, 2020.
Yue Y., Liwei W., Ziyi T., “China opens doors to foreign finance companies, but can they prosper?”, Caixin, Nov. 27, 2021
FONTE:
La costituzione materiale della Repubblica Popolare Cinese
Sintesi della presentazione del libro La costituzione materiale della Cina, di Giordano Sivini, Asterios Editore, 2022
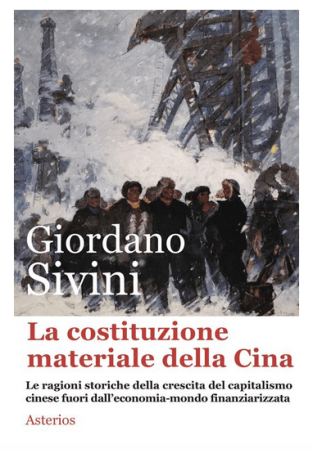
Il socialismo con caratteristiche cinesi è costitutivo di relazioni sociali produttive diverse da quelle capitalistiche? La risposta va cercata nella storia della Cina a partire dalla costruzione maoista della Repubblica popolare. Dopo la vittoria militare sull’imperialismo, l’attività del Partito Comunista ha puntato sulla diffusione di rapporti di produzione egalitari basati sulla socializzazione dei mezzi di produzione attraverso il lavoro collettivo dei contadini con l’impiego delle risorse e delle tecniche disponibili. La riproduzione della ricchezza, in termini di valori d’uso, è stata realizzata all’interno di un’area di accumulazione esterna e separata dall’area di accumulazione mondiale egemonizzata dagli Stati Uniti.
Dopo Mao Zedong, Deng Xiaoping ha portato il Partito Comunista a sostenere ideologicamente e pragmaticamente il primato delle forze produttive sui rapporti di produzione, l’economia si è aperta al mercato delle merci e dei profitti, e il socialismo in quanto ideologia e prassi, assunte ‘caratteristiche cinesi’, è stato ridefinito come impegno per il superamento della scarsità, posponendo a un tempo indeterminato la prospettiva dell’equità. Zhu Rongji dopo Deng Xiaoping, da capo del governo, ha avviato, con l’obiettivo di entrare nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, la trasformazione istituzionale della Cina in senso capitalistico, dando ai mezzi di produzione, già statizzati da Deng, la configurazione giuridica di capitali azionari controllati dal Partito Comunista. Nel contempo, per preservare l’area di accumulazione cinese dalle incursioni dei capitali speculativi internazionali, ha disposto che il capitale finanziario che entrava in Cina fosse messo esclusivamente al servizio dell’economia reale.
Con questo excursus storico si arriva a spiegare perché nell’area di accumulazione cinese il capitalismo produce valore, mentre nell’area di accumulazione dell’economia egemonizzata dagli Stati Uniti il capitale finanziario dominante lo distrugge. In Cina il valore è creato dal lavoro vivo della forza lavoro duramente sfruttata, e i capitali produttivi del mondo se ne avvalgono, purtuttavia contribuendo alla crescita della Cina nelle forme delle valute forti derivanti dai profitti delle esportazioni, degli investimenti diretti e degli acquisti esteri di azioni e obbligazioni cinesi. Per arrivare a queste conclusioni, il libro di Giordano Sivini La costituzione materiale della Cina. Le ragioni storiche della crescita del capitalismo cinese fuori dall’economia-mondo finanziarizzata (Asterios, 2022) affronta, con attenzione alle trasformazioni storiche nella produzione ed accumulazione della ricchezza e alle relative relazioni sociali, l’analisi storica dei problemi che la Cina ha affrontato e risolto negli anni del ‘900 per affermarsi come potenza nel nuovo millennio. Quella che segue è l’introduzione a questo lavoro di ricerca.
La Cina è innanzi tutto un grande spazio antropologicamente produttivo di cui il movimento maoista si è appropriato con la rivoluzione, sottraendolo all’imperialismo e al capitalismo, per fondare la la Repubblica Popolare. All’epoca di Mao (1949-1976), il partito comunista punta a realizzarvi un socialismo egalitario. Nelle campagne, dove vive gran parte della popolazione, costruisce nuove relazioni sociali basate sulla socializzazione dei mezzi di produzione attivati dal lavoro collettivo. La sua capacità di migliorare l’utilizzazione delle risorse storicamente appropriate dai contadini farà sviluppare le forze produttive. Si evita così di dipendere da tecnologie capitalistiche, e si assicura al paese indipendenza e autodeterminazione. La produzione industriale, che separa il proprio spazio urbano da quello agricolo da cui riceve i beni di sussistenza, è sottratta agli imprenditori capitalisti e temporaneamente data in appalto all’Unione Sovietica che contribuisce al suo consolidamento e alla sua espansione.
La Cina non entra a far parte di quelle economie sottosviluppate che cercano di liberarsi dall’imperialismo per affondare nel capitalismo. La rivoluzione maoista la costituisce come Stato, la cui ricchezza si riproduce in maniera allargata confluendo nel centro di un’area di accumulazione controllato dal partito comunista, separata da quella dell’economia-mondo capitalistica. La separazione dall’economia-mondo non viene recepita nelle interpretazioni della Cina, che solitamente fanno riferimento al capitale del mercato mondiale tutto includente. I teorici dell’economia-mondo considerano il capitalismo come sistema di aree interconnesse, nel quale un centro si impone sulle periferie e ne sfrutta le risorse. Mao non pone la Cina come periferia; è una nuova entità nazionale indipendente, autodeterminata e autosufficiente, appunto esterna all’economia-mondo capitalistica.
Deng Xiaoping (1977-1992), successore di Mao, ritiene che la strada tracciata dal maoismo sia quella di un socialismo nella povertà. Un altro socialismo è possibile, fondato sul mercato dove i produttori sono liberi di competere, sviluppando forze produttive che plasmano i rapporti di produzione. Questa inversione della relazione maoista tra rapporti di produzione e forze produttive si impone come elemento della costituzione materiale della Cina postmaoista. Il socialismo per Deng significa superamento della scarsità prima che promessa di redistribuzione della ricchezza al fine di attenuare le disuguaglianze sociali. La rimozione dei vincoli della collettivizzazione genera nelle campagne una esplosione di imprenditorialità fuori controllo. Sul mercato, tra le merci, emerge la forza lavoro, in cerca di salario per la sussistenza delle famiglie contadine che non reggono alla competizione. Deng, che tutto liberalizza nelle campagne, non rimuove il legame di questa forza lavoro con la terra, e la costringe alla condizione di lavoro migrante, che costa meno per chi la usa. Ha bisogno della ricchezza che il suo lavoro vivo produce, per far screscere l’economia e legittimare la leadership del partito.
Il controllo dei mezzi di produzione industriali, insieme alla terra, sono, anche per Deng, le fondamenta per l’indipendenza e l’autodeterminazione del paese. Per Mao erano beni socializzati, Deng li assume come proprietà dello Stato e fa prevalere l’efficienza economica sulle loro funzioni sociali. Per accelerare lo sviluppo delle forze produttive industriali apre l’area di accumulazione ai capitali esteri tecnologicamente qualificati nella forma di joint venture. Vengono attirati dalla incessante disponibilità di forza lavoro migrante per produrre merci da esportare.
Zhu Rongji (1993-2003), dopo Deng, e, da posizioni di governo, accanto a Jiang Zemin segretario del partito, realizza profonde riforme istituzionali. Facendosi aiutare dalla Banca Mondiale, mette sotto controllo, con anni di austerità, l’effervescenza imprenditoriale che creava inflazione, e disegna il nuovo assetto del paese. Ha come obiettivo l’adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio, e per entrarvi vincola le istituzioni ai principi e alle modalità organizzative ed operative dei capitali transnazionali che già si muovono sul mercato globale. Lo Stato riacquista la funzione di regolazione sistemica dell’economia sulla base di regole definite internazionalmente. Tra i mezzi di produzione già statizzati da Deng, fa assumere la forma di capitali a quelli che fanno capo ad imprese di Stato ritenute essenziali per il controllo dell’economia del paese e li proietta sul mercato globale per costringerli alla competitività. Privatizza o chiude le imprese di Stato economicamente inefficienti e licenzia milioni di lavoratori. La loro forza lavoro si aggiunge sul mercato a quella dei migranti rurali, tutti oggetto di tutele legali che non vengono applicate.
Per creare ricchezza espandendo la scala della produzione e aumentando la produttività la Cina ha bisogno di mezzi finanziari e tecnologici. Quelli interni bastano solo in parte; il resto fluisce dall’economia-mondo, nella forma di valuta pregiata creata dai profitti tratti dalle esportazioni, di investimenti diretti, e di partecipazioni azionarie e obbligazionarie estere a capitali cinesi. L’area di accumulazione cinese, che già Deng aveva iniziato ad aprire all’area di accumulazione dell’economia-mondo, viene mantenuta da essa saldamente separata. Traendo insegnamento dalle crisi finanziarie che colpiscono i paesi capitalisticamente periferici, Zhu impone barriere alle attività speculative internazionali. Nell’area di accumulazione cinese possono entrare soltanto capitali finanziari esteri che sostengono attività produttive. Nell’uso corrente con il termine capitalismo non viene fatta distinzione tra capitalismo produttivo che crea valore e quello finanziarizzato che lo distrugge. Nell’area di accumulazione cinese si crea valore in controtendenza rispetto all’economia-mondo dove il capitale finanziario domina quello produttivo. Il capitale finanziario al servizio dell’economia reale è l’elemento che si aggiunge alla costituzione materiale.
La chiusura al capitale finanziario dell’economia-mondo è una misura che va oltre l’obiettivo di sottrarre la Cina alle turbolenze della finanza internazionale e consente di accogliere gli investimenti finanziari diretti dall’estero con finalità produttive e e respingere quelli speculativi. Garantisce anche al partito comunista che governa il centro dell’area di accumulazione al quale sono diretti i flussi di ricchezza prodotti nello spazio produttivo cinese, di decidere senza interferenze esterne le politiche di crescita dell’economia del paese e quelle che assicurano la riproduzione del potere del partito ancorato al controllo dei mezzi di produzione, terra e imprese industriali.
“Il socialismo con caratteristiche cinesi” assume che la Cina sia nella fase iniziale del socialismo, e che il suo sviluppo dipenda da una crescita economica che raggiunga il livello in cui diventi possibile passare ad un socialismo tendenzialmente egalitario. Questo livello rimane indeterminato e lo stesso Xi Jinping nel 2021. in occasione del centenario della nascita del partito comunista cinese, proclamando che la Cina ha raggiunto l’obiettivo di essere una “società moderatamente prosperosa” ha detto: “Noi stiamo marciando a passi fiduciosi verso l’obiettivo del secondo centenario, di trasformare la Cina in un grande paese moderno socialista”. Il Congresso del partito aveva già posto l’obiettivo di diventare un’economia pienamente socialista entro il 2050, ma il problema della connessione del socialismo con questo capitalismo cinese che crea valore sfruttando lavoro salariato con modalità non diverse dalle periferie dell’economia mondo, resta affidato alla leadership cinese.
Rifarsi a Marx e a Lenin per sostenere che il capitalismo di Stato cinese possa sfociare nel socialismo non sembra reggere. Marx prospetta un passaggio rivoluzionario dal capitalismo al socialismo. Lenin sostiene che al socialismo si arriva attraverso un capitalismo sottratto alla borghesia dal proletariato che lo trasforma funzionalmente in capitalismo di Stato per realizzare rapporti di produzione socialisti. In Cina i rapporti di produzione capitalistici sono invece creati dal partito sulle ceneri del socialismo egalitario ma ‘povero’. Occorre dunque indicare una prospettiva socialista per il capitalismo cinese fuori dai riferimenti generici a Marx e a Lenin, e questa è l’ambizione del socialismo con caratteristiche cinesi che punta tutto sul superamento della scarsità. Ha poco senso tenere aperta una discussione sulla Cina di oggi in termini di socialismo o capitalismo, a meno che non si abbia la capacità analitica e teorica di intraprendere una ricerca per individuare gli elementi strutturali di un percorso nuovo.
I rapporti di produzione attuali non sono di difficile lettura, sono rapporti di produzione capitalistici, finalizzati a realizzare plusvalore con il lavoro vivo di una forza lavoro in condizioni di orrendo sfruttamento, e in larga parte tuttora legata giuridicamente alla terra. Il contesto è però profondamente diverso da quello del centro e delle periferie dell’economia-mondo, in quanto il plusvalore, formalmente appropriato privatamente da una moltitudine di imprese di Stato, fluisce nel centro di accumulazione controllato dalla leadership del partito. La sua specificità è legata alle fondamenta della costituzione materiale della Cina popolare, radicata nel maoismo e ridefinita da Deng e Zhu, sulla base della quale nel nuovo millennio la leadership cinese raggiunge l’obiettivo di superare con continuità la scarsità realizzando plusvalore e realizzando la grande infrastrutturazione del paese.
La Cina produce ricchezza che migliora le condizioni della popolazione in termini di redditi medi e di mobilità sociale. La sua leadership, da Deng in poi, guarda con questo obiettivo allo sviluppo tecnologico, riservando attenzione parallelamente, fin da Mao, agli strumenti di difesa necessari a preservare l’indipendenza, che nell’economia-mondo è percepita strumentalmente come sfida egemonica. Questo la rende diversa dai paesi dell’economia-mondo, con il cui centro si sta misurando per condividere l’accesso alle risorse globali. In questi paesi le condizioni sociali regrediscono. L’appropriazione della ricchezza sociale da parte della finanza è un elemento strutturale imposto dal dominio del capitale finanziario condiviso dalla politica, e l’imperialismo continua ad assoggettare periferie e semiperiferie soffiando nel mondo venti di guerra.
L’obiettivo iniziale di questo lavoro era di rispondere al quesito “Che cos’è la Cina?”, a partire dall’analisi delle vicende storiche della Repubblica Popolare, senza ipotesi pregiudiziali e con partecipativa politica curiosità. La risposta è arrivata alla fine dell’esame dei primi tre periodi, quelli di Mao, di Deng e di Zhu. Se c’è una novità nell’approccio rispetto ai tanti altri testi che cercano di interpretare la Cina, sta nella centralità della sua crescita intesa come produzione e accumulazione di ricchezza. Questo porta a dar rilievo al lavoro proletario che la produce e ai rapporti di produzione sottostanti, L’analisi si è conclusa quando dai tre periodi è emersa quella che può essere considerata la costituzione materiale della Cina, che la leadership cinese ha fatto propria posponendo il socialismo in un indeterminato futuro. Nel nuovo millennio il capitalismo cinese creando valore fa crescere i redditi, in controtendenza con quello dell’economia-mondo. Il dato comune è lo sfruttamento della forza lavoro. In Cina è politicamente gestito, nell’economia mondo mantiene le sue basi strutturali.
Le tendenze del capitale nel XXI secolo, tra “stagnazione secolare” e guerra
di Domenico Moro

La realtà geopolitica dell’inizio del XXI secolo va studiata a partire dalla categoria di modo di produzione. Tale categoria definisce i meccanismi di funzionamento del capitale in generale, astraendo dalle singole economie e dai singoli Stati. Per questa ragione, dobbiamo far interloquire la categoria di modo di produzione con quella di formazione economico-sociale storicamente determinata, che ci restituisce il quadro dei singoli Stati e delle relazioni tra di loro in un dato momento.
Inoltre, il nostro approccio dovrebbe essere dialettico, basato cioè sull’analisti delle tendenze della realtà economica e politica. Tali tendenze non sono lineari, ma spesso in contraddizione con altre tendenze. Solo lo studio delle varie tendenze contrastanti può permetterci di delineare i possibili scenari futuri.
- La “stagnazione secolare”
L’economia capitalistica mondiale è entrata in una fase di “stagnazione secolare”. A formulare tale definizione è stato nel 2014 Laurence H. Summers, uno dei principali economisti statunitensi, ministro del Tesoro sotto l’amministrazione Clinton e rettore dell’Università di Harvard. Summers ha mutuato il termine di “stagnazione secolare” dall’economista Alvin Hansen, che lo coniò durante la Grande depressione degli anni ’30, che iniziò con la crisi borsistica del 1929. L’attuale “stagnazione secolare” inizia, invece, con la crisi del 2007-2009, seguente allo scoppio della bolla dei mutui subprime.
La “stagnazione secolare” consiste di una crescita del Pil molto ridotta, ben al di sotto del potenziale. Secondo Summers, la bassa crescita è dovuta alla riduzione degli investimenti di capitale. Del resto, la crescita precedente alla crisi dei mutui subprime è stata sempre dovuta a una politica fiscale e monetaria eccessivamente espansiva, basata sul mantenimento di tassi d’interesse molto bassi da parte della Fed, la banca centrare statunitense. In sostanza, rileva Summers, negli ultimi quindici o vent’anni non c’è stato un solo periodo in cui si sia verificata una crescita soddisfacente in condizioni finanziarie sostenibili. Questo problema, però, non ha riguardato solo gli Usa, ma anche l’area euro e il Giappone.
Quanto scriveva Summers nel 2014 ha trovato conferma in quanto avvenuto fino ad oggi. La crescita del Pil si è ridotta dappertutto e nel 2020 si è avuta, a seguito della pandemia, la più grave recessione dalla fine della Seconda guerra mondiale. Tuttavia, il rallentamento è stato più accentuato nei principali Paesi avanzati e meno marcato in alcuni Paesi emergenti. Tale fenomeno può essere osservato mettendo a confronto i Paesi del G7 (Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Canada) con i Brics (Cina, India, Brasile, Russia e Sud Africa), sia nel periodo precedente alla crisi dei mutui subprime, tra 1980 e 2007, sia nel periodo successivo, tra 2007 e 2021 (Tabella 1).
La crescita dei Paesi della Triade, che comprende le tre aree storicamente dominanti del capitalismo mondiale, il Nord America, l’Europa occidentale e il Giappone, era già inferiore a quella dei Brics nel periodo 1980-2007, ma dopo il 2007 si è dimezzata. Gli Usa, ad esempio, tra 1980 e 2007 fanno segnare una crescita media annua del 3,1%, che nel 2007-2021 si dimezza all’1,5%. Dall’altra parte, Cina e India registrano una crescita molto superiore rispetto a quella Usa nel periodo 1980-2007, rispettivamente del 10,1% e del 6,1% medio annuo. Nel periodo 2007-2021 la crescita di Cina e India si riduce, ma molto meno di quella statunitense, rispettivamente al 7% e al 5,5% medio annuo, rimanendo così molto superiore a quella statunitense.

Ancora peggiore, in confronto a quella degli Usa, è la performance di Giappone e Europa occidentale. La crescita del Giappone nel periodo 1980-2007 è stata del 2,5% medio annuo, cioè di quattro volte inferiore a quella cinese e meno della metà di quella indiana, azzerandosi nel periodo 2007-2021 (+0,1%). L’Europa occidentale (Germania, Regno Unito, Francia e Italia), che nel periodo 1980-2007 aveva registrato una crescita inferiore a quella statunitense, nel periodo 2007-2021 subisce una vera e propria stagnazione con una crescita media annua inferiore all’1%, che, per quanto riguarda l’Italia, si traduce in una decrescita del -0,5% medio annuo.
Come abbiamo detto, la crisi del 2020 ha visto una contrazione del Pil a livelli mai visti nel periodo post Seconda guerra mondiale. Per combatterla, le banche centrali, a partire dalla Fed e dalla Bce, hanno abbassato il costo del denaro fino a farlo arrivare in area negativa, e, allo stesso tempo, i governi hanno messo in campo politiche fiscali espansive di grande entità. Non è un caso che, allo scoppio della pandemia, Draghi abbia sostenuto che la crescita dell’indebitamento e del deficit statali fosse una necessità, come in guerra, e non più il male assoluto da evitare a ogni costo con politiche di austerity. L’economia, spinta dalle politiche espansive, nel 2021 è rimbalzata, ma nel 2022 la crescita si è già ridimensionata. Dunque, non solo viene confermata la “stagnazione secolare”, ma addirittura si prospetta uno scenario ancora peggiore: l’accoppiata tra crescita ridotta e alta inflazione, la cosiddetta “stagflazione”. L’aspetto più grave è che, per combattere l’inflazione, le banche centrali, in particolare la Fed statunitense e la Bce, hanno deciso di rialzare il costo del denaro e ridurre i programmi di acquisto di titoli di Stato. È la fine delle politiche espansive monetarie, che determina il rallentamento della ripresa e, secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale, una probabile recessione nel 2023.
Ritornando a Summers, appare evidente dal suo ragionamento che il vero problema dell’economia mondiale non risiede nella carenza di liquidità, ma nel suo eccesso: le crisi finanziarie sono una conseguenza della sovrabbondanza o sovraccumulazione di capitale produttivo. Una sovrabbondanza che è relativa, cioè determinata dalla incapacità delle imprese private a impiegarla profittevolmente. Il calo del tasso reale d’interesse crea bolle borsistiche a ripetizione che, scoppiando, determinano una ricorrente situazione di instabilità finanziaria che si estende all’economia nel suo complesso. L’economia capitalistica si trova così presa nel circolo vizioso di recessione, politiche espansive monetarie e fiscali, creazione di bolle, scoppio delle bolle e ricaduta nella recessione.
La stagnazione, quindi, appare configurarsi come una caratteristica “secolare”, ossia di lungo periodo dell’economia capitalistica, specialmente nelle sue punte più avanzate, la Triade. Sorge a questo punto la domanda: come risolvere una tale “stagnazione secolare”? La risposta di Summers è che bisogna aumentare gli investimenti, ma questo non è possibile a meno del verificarsi di una condizione che si è ben lungi dall’augurarsi: “è certamente possibile che alcuni eventi esogeni possano intervenire ad aumentare la spesa e incentivare gli investimenti. Ma, guerra a parte, non appare chiaro quali potrebbero essere tali eventi.”[i] Quindi, solo una guerra e, in particolare, una guerra su larga scala come una guerra mondiale, potrebbe tirare fuori l’economia dei Paesi avanzati dalle secche in cui affonda. Del resto, è quello che è accaduto nella precedente “stagnazione secolare”, quella degli anni ’30. A risolvere la Grande depressione non fu il New Deal, varato dal presidente Franklin D. Roosvelt, ma furono le massicce spese belliche e gli investimenti per la ricostruzione, seguita alle enormi distruzioni della Seconda guerra mondiale, a determinare la ripresa dell’economia e a dare luogo all’espansione dei “trenta gloriosi”, fino alla crisi degli anni ’74-‘75.
- La caduta tendenziale del saggio di profitto e il crollo del capitalismo
Secondo quanto evidenziato da Marx, la tendenza tipica del modo di produzione capitalistico è la diminuzione della parte di capitale spesa in forza lavoro (capitale variabile) in rapporto alla parte spesa in mezzi di produzione e materie prime (capitale costante). In altri termini, si determina un progressivo aumento della composizione organica di capitale, cioè un aumento della parte di capitale costante in rapporto a quella di capitale variabile. Il fatto è che solo il capitale variabile, la forza lavoro, produce plusvalore. Ne deriva che, a parità di sfruttamento della forza lavoro (cioè a parità di saggio di plusvalore), la quantità di plusvalore tende a diminuire rispetto al capitale totale investito. Essendo il saggio di profitto dato dal rapporto tra plusvalore e capitale totale, si determina così una tendenza alla caduta del saggio di profitto.
In questo modo, si viene a creare una sovraccumulazione di capitale. Questo vuol dire che si è accumulato troppo capitale, in mezzi di produzione, rispetto alla capacità di generare un saggio di profitto adeguato alle necessità dei capitalisti. Quando la sovraccumulazione si viene a verificare nei settori principali dell’economia si ha una sovraccumulazione generale. A questo punto, i capitalisti, in assenza di un saggio elevato di profitto, riducono gli investimenti. Nello stesso tempo, la concorrenza tra singoli capitali si fa più spietata, e i capitali meno forti soccombono, generando una moria di imprese. In conseguenza di tutto ciò, si ha una contrazione della produzione generale che si traduce in crisi e recessioni.
Dal momento che l’aumento della composizione organica è più forte nei paesi capitalisticamente più sviluppati, la caduta del saggio di profitto tende a manifestarsi con più forza in questi Paesi. Per questa ragione, il tasso di crescita del Pil è minore nei Paesi capitalisticamente più sviluppati e maggiore in quelli meno sviluppati. Anche il rallentamento della crescita o il crollo della produzione, nel corso delle crisi, si determina con maggiore intensità nei paesi più avanzati, come abbiamo visto sopra nel confronto di lungo periodo tra i Paesi del G7, capitalisticamente più sviluppati, e i Paesi del Brics, capitalisticamente meno sviluppati.
Naturalmente, lo scoppio delle crisi e delle recessioni può avvenire per certe cause scatenanti, come lo scoppio di una bolla finanziaria, la penuria o l’aumento del prezzo di certe materie prime o di certi componenti o semilavorati, o per fattori esogeni all’economia, come una guerra o sanzioni economiche o una pandemia. Le crisi, inoltre, possono generarsi per uno squilibrio tra eccesso di merci prodotte e ristrettezza del mercato di assorbimento. Ciononostante, queste sono cause contingenti che accendono la miccia sul vero e proprio materiale esplosivo che è sottostante, ossia la sovraccumulazione di capitale e la caduta del saggio di profitto. La crisi generale è sempre da ricollegare a questa tendenza tipica del modo di produzione capitalistico.
Però, la caduta del saggio di profitto è una tendenza, importante sì, ma una tendenza. Marx scriveva che il problema teorico per gli economisti non è tanto capire il perché della caduta del saggio di profitto, bensì capire il perché una tale tendenza non sia più celere e accentuata, tramutandosi in crollo del sistema. In sostanza, dice Marx, “devono intervenire influenze antagonistiche che ostacolano o annullano l’attuazione della legge generale conferendole il carattere di una semplice tendenza; ed è per questa ragione che la caduta del saggio generale di profitto noi l’abbiamo chiamata tendenziale”[ii].
Al suo tempo, Marx evidenziava le seguenti influenze antagonistiche: l’aumento del grado di sfruttamento del lavoro, la riduzione del salario al di sotto del suo valore, la diminuzione di prezzo del capitale costante, la sovrappopolazione relativa, che porta alla creazione di un esercito industriale di riserva, ossia una massa di disoccupati, che, esercitando una pressione concorrenziale sugli occupati, permette una riduzione del salario. Tra i più importanti fattori c’è, poi, il commercio estero: sia l’esportazione dell’eccesso di merci, determinato dall’aumento della capacità produttiva del capitale, sia l’esportazione di capitale nei paesi periferici, dove il saggio di profitto è più alto a causa del minore sviluppo capitalistico e il lavoro viene sfruttato in maniera più intensa. Possiamo osservare come le stesse cause che producono la caduta del saggio di profitto determinano anche i fattori che la contrastano. Infatti, lo sviluppo tecnologico che porta alla sostituzione di forza lavoro con macchine, e cioè alla sostituzione di capitale variabile con capitale costante, se, da una parte, conduce all’aumento della composizione organica, dall’altra parte, genera l’aumento dello sfruttamento del singolo lavoratore e la creazione dell’esercito industriale di riserva.
Queste tendenze antagonistiche, che Marx evidenziava ai suoi tempi, sono ancora funzionanti a tutt’oggi. Da Marx a oggi, però, il capitalismo si è molto sviluppato: la sovraccumulazione di capitale è cresciuta a livelli talmente alti che, di fatto, il capitalismo sarebbe già crollato se non si fossero verificate delle condizioni nuove. Tra queste c’è la guerra mondiale: senza la Seconda guerra mondiale oggi il capitalismo forse non esisterebbe. C’è poi la finanziarizzazione, che consente, tramite tutta una serie di invenzioni speculative, di fare profitti senza passare per la produzione di merci. Per la verità, la finanziarizzazione viene rilevata anche da Marx, sebbene nella sua epoca non fosse arrivata agli estremi attuali. C’è, infine, l’intervento diretto dello Stato a sostegno dell’economia capitalistica. A causa dell’aumento della spesa pubblica, i debiti pubblici si sono rigonfiati a livelli mai visti prima in tempi di pace proprio perché nel corso dei decenni, soprattutto dopo i “trenta gloriosi”, lo Stato si è assunto il compito di stampella del capitalismo.
Tuttavia, questi nuovi fattori antagonistici presentano dei forti limiti: la finanza e il debito, pubblico e privato, oltre un certo livello rappresentano un forte fattore di instabilità e di crisi. Inoltre, il capitale ha già sfruttato tutte le leve, che, secondo Marx, ha a sua disposizione, dalla compressione del salario all’uso dell’esercito industriale di riserva alla esportazione di capitali dai paesi capitalisticamente più sviluppati verso quelli meno sviluppati. L’ulteriore accentuazione della contrazione del salario non fa che aggravare la crisi sul lungo periodo. Per questo, rientra in gioco l’aspetto della distruzione creatrice: la distruzione di capacità produttiva, che permette di ridurre la sovraccumulazione di capitale e rilanciare la produzione di profitto. Le stesse crisi sono un fattore di riduzione della sovraccumulazione mediante la distruzione di capitale, sotto forma di eliminazione di imprese e la centralizzazione, mediante fusioni e acquisizioni, di quelle che rimangono. Ma è soprattutto la guerra mondiale che si staglia sullo sfondo come elemento di ridefinizione delle condizioni di accumulazione mediante la distruzione di capitale.
Se la caduta del saggio di profitto fosse senza tendenze contrastanti, il modo di produzione capitalistico crollerebbe su sé stesso. Ma, come abbiamo visto, così non è. Tuttavia, per Marx, la caduta del saggio di profitto dimostra il carattere “ristretto, meramente storico, transitorio, del modo di produzione capitalistico: attesta che esso non costituisce affatto l’unico modo di produzione in grado di generare ricchezza, ma al contrario, arrivato a un certo punto, entra in conflitto con il suo stesso ulteriore sviluppo.”[iii] La tendenza del capitalismo al crollo è sempre più evidente e accentuata, sebbene non sia possibile pensare a un crollo automatico. Bisogna vedere cosa il capitale inventerà per spostare ancora una volta in avanti il suo redde rationem. A parte la carta della guerra, il capitale sembra volersi giocare la carta della transizione ecologica. Il passaggio alle fonti rinnovabili e trasformazioni radicali come il passaggio dal motore a combustione interna al motore elettrico rappresentano degli strumenti tesi a ridurre la sovrapproduzione di capitale e merci per rilanciare i profitti.
- Cambiamenti dei rapporti di forza mondiali
Come scriveva Lenin, il capitalismo concreto, cioè quello formato da un insieme di formazioni economico-sociali, è caratterizzato da una crescita diseguale[iv]. Le potenze egemoni, più “vecchie” dal punto di vista dello sviluppo capitalistico tendono a crescere meno, mentre quelle più “giovani” tendono a crescere più velocemente. Di conseguenza, i rapporti di forza economici tendono a modificarsi a favore di queste ultime. A un certo punto i nuovi rapporti di forza economici entrano in conflitto con i rapporti politici esistenti, generando una tendenza alla guerra.
La storia del capitalismo può essere letta come un avvicendarsi di cicli economici, più o meno secolari, che vedono il prevalere, di volta in volta, di una potenza egemone, attorno alla quale si determina l’accumulazione di capitale mondiale. È questa la teoria dei “cicli secolari”, ideata da Giovanni Arrighi, che definisce quattro cicli secolari del capitalismo, dal XVII al XXI secolo: quello ispano-genovese, quello olandese, quello britannico e, infine, quello statunitense[v]. La potenza economica si accompagna sempre alla potenza politico-militare: ad ogni ciclo gli Stati di volta in volta egemoni sono sempre più grandi e militarmente potenti. I cicli secolari sono divisi in due parti: una basata sulla produzione materiale e una sulla finanza. Fino a un certo punto gli Stati egemoni sono prevalenti dal punto di vista della produzione materiale, poi tale prevalenza viene meno, per la sovraccumulazione di capitale, e, allora, prevale l’aspetto finanziario di controllo dei flussi di capitale. Ma anche la crescita dei profitti trainata dalla finanza a un certo punto viene meno e, nel frattempo, emergono altre potenze che sfidano la potenza egemone. Si determina così un periodo di caos alla fine del quale, sempre dopo una guerra generale, la vecchia potenza egemone viene sostituita da una nuova potenza, attorno alla quale riprende il ciclo di accumulazione capitalistico.
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo la Gran Bretagna viene sopravanzata nella produzione e nella esportazione di beni da due potenze emergenti, la Germania e soprattutto gli Stati Uniti. La Prima e la Seconda guerra mondiale sono combattute per l’egemonia mondiale. Alla fine della lotta la Germania è sconfitta ma la Gran Bretagna è costretta a cedere il ruolo di potenza guida agli Usa.
Neanche gli Usa sfuggono, però, alle leggi storiche, incorrendo in una decadenza che si manifesta nel calo della crescita e nella drastica diminuzione della loro quota sul Pil e sulle esportazioni mondiali. Per la verità, oggi, la decadenza è riscontrabile anche negli altri Paesi che, insieme agli Usa, fanno parte del cosiddetto Occidente, cioè l’Europa occidentale e il Giappone. Come già accaduto alla Gran Bretagna, oggi gli Usa e gli altri Paesi centrali subiscono la forte concorrenza di alcuni emergenti, soprattutto quella della Cina (Graf.1).
Graf. 1 – Quota dei principali Paesi sul Pil mondiale (a parità di potere d’acquisto; in %)
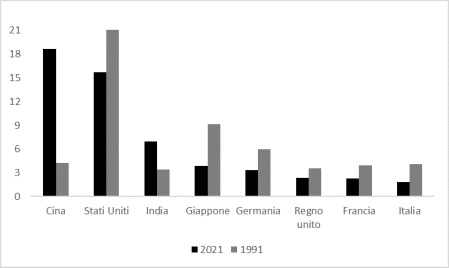
Infatti, se consideriamo il Pil a parità di potere d’acquisto, la Cina ha superato gli Usa già nel 2016. La Cina negli ultimi trenta anni, tra 1991 e 2021, è passata dal 4,3% del Pil mondiale al 18,6%, mentre gli Usa sono calati dal 21% al 15,7%[vi]. Anche la quota dell’India è cresciuta dal 3,4% al 7%, mentre quella degli altri Paesi centrali, alleati degli Usa, è calata. Ad esempio, il Giappone è passato dal 9,2% al 3,8% e la Germania dal 6% al 3,3%. Uno stesso calo è riscontrabile anche nella quota sulle esportazioni mondiali di beni manufatti. Tra 1991 e 2021 gli Usa passano da una quota del 12% al 7,9%, mentre la Cina passa dal 2% al 15,1%. L’india passa dallo 0,5% all’1,8%, mentre il Giappone scende dal 9% al 3,4% e la Germania dall’11,5% al 7,3%. Bisogna, però, considerare che, sul piano del Pil pro capite (sempre a parità di potere d’acquisto), la Cina è ancora distante dagli Usa, pur essendo cresciuta enormemente negli ultimi venti anni. Il Pil pro capite della Cina rappresentava nel 1991 il 3,8% di quello degli Usa e nel 2021 il 27,8%, mentre quello dell’India nel 1991 rappresentava il 4,1% e nel 2021 il 10,3%.
In sostanza, possiamo osservare che i rapporti di forza mondiali sul piano economico sono cambiati e che, per la prima volta da circa un secolo e mezzo, la Cina ha ripreso il primato sul Pil mondiale che aveva sempre avuto storicamente fino all’epoca delle guerre dell’oppio intorno alla metà del XIX secolo. Anche sul piano tecnologico la Cina sta facendo molti passi in avanti, sfidando anche su questo terreno gli Usa. Questi, però, se non hanno più l’egemonia sulla produzione e sull’export mondiali mantengono una egemonia sia militare sia finanziaria, grazie al dollaro.
- Il ruolo egemonico del dollaro e la tendenza al suo declino

Gli Stati Uniti hanno ricalcato le orme della Gran Bretagna, sebbene con importanti differenze, soprattutto con la sostituzione del dollaro alla sterlina come moneta mondiale. Con la Prima guerra mondiale molti paesi abbandonarono il gold standard, stampando massicciamente denaro per finanziare le spese militari. Il Regno Unito, invece, mantenne la sterlina legata all’oro, per conservarle il ruolo di moneta mondiale, ma fu costretto, per la prima volta nella sua storia, a prendere a prestito denaro dall’estero. Il Regno Unito e gli altri Paesi alleati divennero così debitori degli Usa, che furono pagati in oro. In questo modo gli Usa alla fine della guerra divennero il principale possessore di riserve auree. Gli altri Paesi, privi delle loro riserve in oro, non poterono più ritornare al gold standard. Nel 1931 anche il Regno Unito abbandonò definitivamente il gold standard e il dollaro sostituì la sterlina come valuta di riserva mondiale.
Fu, però, solo con la Seconda guerra mondiale che il dollaro vide consacrato il suo ruolo di moneta mondiale grazie agli accordi di Bretton Woods (1944), in base ai quali si decise di abbandonare il gold standard: le valute mondiali non sarebbero più state agganciate all’oro bensì al dollaro, che a sua volta era agganciato all’oro. In caso di richiesta i paesi creditori in dollari sarebbero stati pagati dagli Usa in oro. In questo modo, le banche centrali dei Paesi aderenti a Bretton Woods anziché oro accumularono dollari. Il sistema, però, entrò in crisi alla fine degli anni ’60, perché gli Usa, per finanziare la guerra in Vietnam e i programmi di welfare interni, cominciarono a inondare il mercato di dollari. Preoccupati per la svalutazione del dollaro, i creditori degli Usa cominciarono a chiedere di essere pagati in oro. Temendo di perdere le proprie riserve auree, il presidente Richard Nixon nel 1971 sganciò il dollaro dall’oro. Il dollaro rimase la valuta mondiale ma con il vantaggio, per gli Usa, di garantirsi la possibilità di pagare le importazioni e il debito pubblico semplicemente stampando dollari.
Il dollaro rimane, fino ad ora, il re delle valute. Oltre a rappresentare la maggior parte delle riserve valutarie mondiali è moneta di scambio nel commercio internazionale, grazie al fatto che la maggior parte delle materie prime, inclusi il petrolio e il gas, sono comprate e vendute in dollari. Non a caso, lo status mondiale del dollaro negli anni ’60 è stato definito “l’esorbitante privilegio” degli Usa dal ministro delle finanze francese Valery Giscard d’Estaing. La domanda di dollari a livello mondiale permette agli Usa di finanziarsi a basso costo, pagando cioè tassi d’interesse ridotti agli acquirenti dei loro titoli di Stato. Grazie a questo, dal 1968, gli Usa hanno cominciato ad accumulare un crescente e quasi ininterrotto debito del commercio estero. Nel 2021 il debito commerciale (solo beni) statunitense ammontava alla colossale cifra di 1.182 miliardi di dollari[vii], mentre il debito pubblico raggiungeva, sempre nel 2021, i 30,5 trilioni di dollari, vale a dire il 133,3% rispetto al Pil e 2,7 trilioni di dollari in più rispetto all’anno precedente[viii].
La centralità del dollaro nei pagamenti internazionali aumenta anche il potere degli Usa di imporre sanzioni finanziarie. Infatti, ogni transazione che tecnicamente tocchi il suolo statunitense dà agli Usa giurisdizione legale e quindi la capacità di bloccare le transazioni indesiderate. Le sanzioni, però, hanno un effetto boomerang sul dollaro, visto che spingono i Paesi che ne sono oggetto a fare uso di valute alternative al dollaro. È da un paio di decenni che l’egemonia del dollaro si sta erodendo, a causa soprattutto dell’aumento degli scambi su scala regionale e come risposta dei Paesi che vogliono sottrarsi al dominio valutario degli Usa. Tra 1999 e 2021 le riserve in dollari detenute dalle banche centrali sono scese dal 71% al 59%[ix]. Inoltre, oggi, il dollaro conta per il 40% delle transazioni internazionali, l’euro per il 35%, la sterlina per il 6% e lo yuan per il 3%[x].
La guerra in Ucraina ha accelerato questa tendenza. La Russia ha reagito alle sanzioni occidentali reindirizzando verso altri Paesi, come l’India e la Cina, le esportazioni di petrolio e gas che andavano verso l’Ue e regolando le transazioni non più in dollari ma in altre valute, come rubli, yuan e rupie. L’uso del rublo verrà esteso anche alla commercializzazione di altri prodotti tipici dell’export russo, per esempio ai cereali destinati a Turchia, Egitto, Iran e Arabia saudita. Inoltre, la Cina ha intenzione di mettere a disposizione della Russia il Cross-border Interbank Payment System (Cips), il proprio sistema di pagamenti internazionali alternativo allo Swift, lanciato nel 2015 per ridurre la dipendenza dal dollaro, internazionalizzare la propria valuta (lo yuan renminbi) e spingerne l’uso fra i Paesi coinvolti nella Nuova via della seta. La Cina ha stipulato anche accordi con alcuni Paesi, come la Turchia e il Pakistan, per commercializzare beni in yuan.
La decisione di accogliere le richieste della Russia di essere pagata in valute differenti dal dollaro e l’aggiramento del sistema Swift ha fortemente irritato gli Usa. Il vice consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Daleep Singh, ha dichiarato: “Non vorremmo vedere sistemi progettati per sostenere il rublo o minare il sistema finanziario basato sul dollaro o per aggirare le nostre sanzioni…ci sono conseguenze per i Paesi che lo fanno.”[xi] A esprimere preoccupazioni sulla tenuta del dollaro come valuta mondiale è stato anche il Fondo monetario internazionale: “l’esclusione dal sistema di messaggistica Swift potrebbe accelerare gli sforzi per sviluppare alternative. Ciò ridurrebbe i vantaggi in termini di efficienza derivanti dall’avere un unico sistema globale, e potrebbe potenzialmente ridurre il ruolo dominante del dollaro nei mercati finanziari e nei pagamenti internazionali”[xii].
- La tendenza alla guerra
Il dollaro non è soltanto uno strumento di guerra per gli Usa, ma rappresenta l’architrave stessa della loro egemonia mondiale: col dollaro gli Usa finanziano il loro Stato e indirettamente tutta la loro economia. Senza il dollaro gli Usa non potrebbero sostenere il loro enorme doppio debito, quello pubblico e quello commerciale. Quando il dollaro divenne moneta mondiale gli Usa producevano la metà del prodotto interno mondiale e detenevano il 21,6% delle esportazioni mondiali (1948)[xiii]. Oggi, la Cina ha scalzato gli Usa dal loro primato economico. In questa fase storica, l’economia statunitense ha un carattere fortemente parassitario. Anche più di quanto non accadesse all’epoca dell’egemonia britannica. L’imperialismo britannico poteva basarsi sulle risorse estorte alle colonie, in particolare all’India, dalla quale fluiva il surplus commerciale verso il centro finanziario di Londra[xiv]. Tuttavia, la sterlina era basata su qualcosa di tangibile, cioè sull’oro. Oggi, il dollaro non ha dietro di sé nulla di concreto e di reale che non siano le Forze armate statunitensi.
Dal momento che hanno perso la loro egemonia economica, gli Usa fanno sempre più affidamento sull’influenza geopolitica, che deriva in gran parte dal fatto che gli Usa possono disporre di una forza militare senza confronti. La spesa militare degli Usa è pari a 778 miliardi di dollari, mentre quella del secondo paese in classifica, la Cina, è di 252 miliardi, e quella della Russia è di 61,7 miliardi[xv]. In totale, il budget militare dei primi 10 Paesi del Mondo equivale a malapena al budget Usa.
Si innesca, a questo punto, un circolo vizioso: gli Usa mantengono l’egemonia del dollaro grazie alla forza militare e mantengono la forza militare, finanziandosi grazie al dollaro. Quindi, se il dollaro perde forza a livello mondiale risulta più difficile per gli Usa mantenere la loro forza militare e se viene meno quest’ultima viene meno anche l’egemonia del dollaro. Insomma, se si rompe il “giocattolo” del dollaro, gli Usa rischiano una crisi radicale.
Il peggioramento dei rapporti di forza economici e la necessità di mantenere, nonostante questo declino, l’influenza geopolitica spingono gli Usa verso la tendenza alla guerra. Una guerra che alcune volte viene combattuta direttamente, come in Iraq, e a volte indirettamente, come in Ucraina. Nella guerra attualmente in corso il vero oggetto del contendere è l’influenza geopolitica degli Usa e, attraverso di essa, la capacità del dollaro di mantenersi moneta di scambio e di riserva mondiale.
Note
[i] Lawrence H. Summers, Reflection on the New Secular Stagnation Hypothesis, p.36. Il corsivo è mio.
[ii] Karl Marx, Il capitale, Newton Compton editori, Roma 1996, p. 1070.
[iii] Ibidem, p.1077.
[iv] Lenin, L’imperialismo. Fase suprema del capitalismo, Editori Riuniti, Roma 1974.
[v] Giovanni Arrighi, Il lungo XX secolo. Denaro, potere e le origini del nostro tempo, Il Saggiatore, Milano 2003.
[vi] International monetary fund, World economic outlook (april 2022).
[vii] Unctad, data center.
[viii]International monetary fund, Database.
[ix] International Monetary fund, The Stealth erosion of dollar dominance.
[x] G, Di Donfrancesco, “L’Fmi: le sanzioni alla Russia minano l’egemonia del dollaro”, Il Sole24ore, 1 aprile 2022.
[xi] G. Di Donfrancesco, “Lavrov in India per offrire greggio ma Washington lancia l’allarme”, Il Sole24ore, 1 aprile 2022.
[xii] Ibidem.
[xiii] Unctad, data center.
[xiv] Marcello de Cecco, Moneta e impero. Economia e finanza tra 1890 e 1914, Donzelli editore, Roma 2016.
[xv] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/military-spending-by-country.
GUERRA IN UCRAINA E NUOVO ORDINE MONDIALE: Gli effetti nell’economia, nella finanza, nelle relazioni internazionali (III° Parte)
GUERRA IN UCRAINA E NUOVO ORDINE MONDIALE
Gli effetti nell’economia, nella finanza, nelle relazioni internazionali
Terza parte atti del seminario
(QUI la prima e la seconda parte degli atti già pubblicati)
di Raffaele Picarelli

Inflazione, alti tassi, recessione
Il 31 maggio scorso i dati preliminari di Eurostat hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo nell’Eurozona è salito all’ 8,1% su base annua, dal 7,4% di aprile, ben al di sopra del “consenso” degli analisti che era di un aumento del 7,7%.
In Germania l’inflazione a maggio ha toccato il 7,9% anno su anno come ai tempi della crisi petrolifera del 1973, in Spagna ha registrato un aumento dell’8,7%.
In Italia, dopo il lieve rallentamento di aprile, l’inflazione è tornata ad accelerare in maggio, portandosi al 6,9% anno su anno, un livello che non si registrava dal 1986.
In USA in aprile l’inflazione era all’8,3%. In maggio è cresciuta all’8,6%, nuovo massimo dal dicembre del 1981. Biden: “I nuovi dati dimostrano il perché l’inflazione è la mia priorità […]. I rialzi dei prezzi causati da Vladimir Putin hanno colpito duramente in maggio […]. Faremo il possibile per ridurre i prezzi.” (“Il Sole – 24 Ore” dell’11 giugno). Non c’è limite alla menzogna e alla spudoratezza! Le cause dell’inflazione sono varie e, si è detto, anteriori all’attuale conflitto in Ucraina, anche se la guerra, in alcuni casi, ha funzionato da acceleratore: prezzi energetici, rottura delle catene di approvvigionamento di materie prime, semilavorati e merci, “rarità” di alcune materie prime.
“Bisogna dare uno sguardo ai cambiamenti in atto. Il primo riguarda la globalizzazione: […] dopo aver […] guidato il mondo dagli anni ’80, si sta bruscamente invertendo. Ormai la maggior parte delle aziende ha capito che tenere catene globali delle forniture troppo lunghe rappresenta un rischio. Basta una pandemia, un porto chiuso o un conflitto che non arriva più nulla. Tanti stanno dunque accorciando le catene. O intendono farlo. Questo terrà alta l’inflazione. Stesso discorso per le materie prime: improvvisamente ci si accorge quanto siano scarse e dislocate nelle parti più instabili […]. Il 44% del palladio globale arriva dalla Russia. Idem per oltre il 16-17% del gas naturale e dei fertilizzanti. Scarsità, in economia, significa rincari. Prezzi alti. Insomma: inflazione […]. L’inflazione è diventata strutturale.” (M. Longo ne “Il Sole – 24 Ore” del 13 giugno). E ancora: “Per anni le aziende hanno aumentato i margini pur in un’economia stagnante, perché potevano tagliare i costi. Riuscivano a farlo perché potevano allungare le “supply chain” e sfruttare la manodopera dove il costo del lavoro era basso, oppure perché potevano usare materie prime anche di scarsa sostenibilità ambientale da qualche parte del mondo. Nessuno lo sapeva.” (R. Almeida di Mfs Investment Management, ibidem).
Ora tutto questo (sfruttamento selvaggio del lavoro, devastazione ambientale ecc) è più difficile. Allora “i costi salgono. E l’accorciamento delle catene globali fa il resto.” E “la domanda è: chi pagherà questi maggiori costi industriali? Le aziende riducendo i margini oppure i consumatori con prezzi più alti?” (Ibidem).
Un’analisi dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo (risalente a fine marzo) dimostra che oggi, in Europa, il balzo dei prezzi è in gran parte causato dall’energia. Prendendo come punto di partenza il maggio 2018, quando l’indice dei prezzi in Eurozona raggiunse l’obiettivo della BCE del 2%, Intesa Sanpaolo ha calcolato da cosa “è stata causata l’extra inflazione di oggi [fine marzo]. Si tratta di 3,9 punti percentuali in più [ora l’inflazione ufficiale è ancora più alta di almeno un punto]. Due terzi sono dovuti proprio alla componente energetica. E un’altra fetta importante (0,8 punti su 3,9) va cercata nel settore alimentare, anch’esso in gran parte gravato dai maggiori costi dell’energia e dei fertilizzanti. Insomma: senza il petrolio e il gas alle stelle, in Eurozona l’inflazione sarebbe ben più bassa.” (M. Longo, “Il Sole – 24 Ore” del 31 marzo).
Diversa la situazione in USA dove la componente energia ha causato solo un terzo del rincaro, mentre la parte più pesante è costituita dai rincari da domanda per consumi.
Di alcuni fattori che rendono strutturale il carovita abbiamo già trattato. La deglobalizzazione, è utile ribadirlo, è uno di questi. Il rischio di filiere produttive lunghe e globali concerne settori sensibili come i semiconduttori, l’energia, i prodotti farmaceutici, ed è opinione diffusa che. principalmente in questi settori, avverrà un rimpatrio delle produzioni (reshoring). E questo farà salire i prezzi. Altro fenomeno inflattivo è la transizione energetica: almeno per un certo lasso di tempo la transizione produce un aumento dei prezzi.
Giordano Lombardo della casa d’investimento Plenisfer, in un’intervista del 7 aprile scorso al giornale confindustriale dichiarava: “In un mondo che va verso una nuova divisione in blocchi è inevitabile che aumenti il potere geopolitico e negoziale di Paesi non allineati con il blocco occidentale ma fondamentali per l’approvvigionamento di materie prime. [E quindi aumentino i prezzi]”. In una realtà fatta “di blocchi antagonisti, uno guidato dalla Cina [e dalla Russia] e uno dall’Occidente, le supply chain (le catene di approvvigionamento) si devono accorciare. Ma […] questo farà salire l’inflazione”. Per il fattore inflattivo rappresentato dalla transizione energetica, il problema è che “da anni è in corso un deciso calo degli investimenti in tutti i combustibili fossili. Peccato che oggi proprio questi combustibili rappresentino ancora l’80% del fabbisogno energetico globale. Si stima che per soddisfarlo con altre fonti, bisognerebbe moltiplicare per tre l’energia nucleare esistente oggi, oppure per cinque quella solare, oppure per 10 quella eolica. Nel breve periodo è impossibile che queste fonti rinnovabili riescano a soddisfare le necessità”(Ibidem).
Allora, dato che in Europa l’inflazione non è da consumi ma quasi interamente causata da rincari eccezionali delle materie prime (accelerati, talora, dal conflitto in corso), si tratta di un’inflazione da costi, un’ “inflazione importata”. Essa riduce gli investimenti perché non sempre si è in grado di trasferire in tutto, ma anche in parte, l’aumento dei costi (prezzi di produzione) sul prezzo finale dei beni e dei servizi. E se questo avviene, l’inflazione riduce il potere d’acquisto dei ceti deboli, dei lavoratori a reddito fisso, dei pensionati, dei piccoli risparmiatori.
Scrive Luca Mezzomo, economista di Intesa Sanpaolo: “Quando l’inflazione dipende dal rincaro dell’energia e delle materie prime, si distruggono i consumi”. Inoltre, le politiche delle banche centrali sono poco efficaci quando l’inflazione è causata da energia e materie prime: per quanto alzino i tassi, i prezzi di petrolio e gas restano elevati. L’unica cosa che possono fare è causare una “devastante” recessione: diminuendo drasticamente i consumi, crolla la domanda di energia e materie prime e quindi, piano piano, anche i prezzi calano. Tutto questo processo, con conseguente aumento dei tassi, accade, non dimentichiamolo, in una fase di contrazione dell’economia europea e globale.
Ma “in Europa i salari non stanno salendo” e se aumenti ci saranno “non saranno elevati […]. Oggi invece l’occupazione è ben diversa: tanti lavoratori sono precari, a tempo determinato, impiegati nella gig economy e in generale meno sindacalizzati” (“II Sole – 24 Ore” cit.).
L’inflazione da costi è per definizione un massacro sociale.
Lo è direttamente perché distrugge redditi e consumi e, in certa misura, cioè nella misura in cui le aziende non riescono a trasferirla sui prezzi finali, anche gli investimenti. I più colpiti sono naturalmente i gruppi sociali più fragili.
Lo è indirettamente, con l’aumento dei tassi di interesse praticato dalle banche centrali e, a cascata, da tutto il sistema creditizio.
Questo aumento se, come si è detto, è vano direttamente contro l’inflazione importata, fa crollare più o meno rapidamente tutti i consumi (perché tende a propagarsi a tutti settori) e anche la domanda di energia e materie prime.
Quindi i prezzi cadono proprio attraverso e a causa di un massacro sociale.
Da qui il passo verso la recessione (forse attraverso una fase di stagflazione) è breve.
Le “stazioni” di tale massacro (riduzione del potere d’acquisto, impoverimento soprattutto dei ceti deboli, svalorizzazione dei risparmi e degli asset, liquidazione degli ultimi brandelli di welfare, disoccupazione, riduzione ulteriore degli investimenti, ulteriore disoccupazione, etc.), hanno anche un contraltare positivo per i governi molto indebitati: il debito pubblico (anche quello privato) con l’inflazione si svaluta.
A fronte di tutto questo, in Italia e non solo, i ceti popolari non hanno nessun valido strumento di protezione e recupero. Ma di ciò parleremo più avanti.
La dinamica dell’adozione dei tassi e delle condizioni finanziarie più restrittive
Il 10 giugno scorso la presidente Christine Lagarde ha anticipato gli aumenti dei prossimi mesi, “rebus sic stantibus”. Il 1 luglio terminerà il programma APP di acquisti netti di titoli pubblici da parte della BCE; il 21 luglio, alla prossima riunione del Consiglio della BCE, i tassi di riferimento saliranno dello 0,25% e di un altro 0,25 o 0,50% (a seconda dell’inflazione) alla riunione successiva dell’8 settembre.
Mercoledì 15 giugno la Federal Reserve ha deciso di alzare i tassi di 75 punti base (0,75%). È la prima volta dal novembre 1994 che un rialzo è così forte. E ulteriori consistenti rialzi sono previsti nei prossimi mesi.
Le borse mondiali hanno reagito con pesanti perdite, e titoli pubblici e corporate bond hanno visto aumentare in modo rilevante i rendimenti e scendere altrettanto cospicuamente i prezzi.
L’aumento dei tassi e la conseguente caduta della domanda non piace a Confindustria perché, in prospettiva, aumenta i costi di produzione e affievolisce le vendite. Per Carlo Bonomi l’aumento dei tassi della BCE “non è la soluzione per controllare l’inflazione […]. Il Paese è fermo, e abbiamo un debito pubblico enorme. Capisco che si debba controllare l’inflazione. Ma con il rialzo dei tassi avremo sicuramente dei problemi” (“Il sole-24 ore” 11 giugno).
Di fronte a possibili rivendicazioni salariali, il fuoco di sbarramento è la richiesta di soldi pubblici per il taglio del cuneo fiscale e contributivo.
Alla luce di quanto detto finora è semplicemente inconcepibile che un’inflazione da costi diventi, sic et simpliciter, un’ inflazione da domanda. Eppure la parola d’ordine in questi tempi del governo e della Banca d’Italia é di “non disancorare” l’inflazione e impedire la spirale prezzi-salari. Se i salari sono fermi, se non esistono meccanismi di indicizzazione e recupero, tali affermazioni surreali e spudorate che senso hanno? Hanno il senso di un fuoco di sbarramento contro ogni futura, possibile richiesta salariale.
E’ una menzogna, nella situazione attuale, evocare la spirale prezzi-salari. Nelle “Considerazioni finali” del 31 maggio scorso, il Governatore della Banca d’Italia Visco ammette che se è concepibile una spirale prezzi-salari in USA ove esiste un’inflazione da domanda, nell’area euro “la dinamica delle retribuzioni è sinora rimasta moderata”. Ciò nonostante, le richieste di adeguamenti salariali sarebbero accettabili solo se si risolvessero “in aumenti una tantum [perché in tal caso] il rischio di un circolo vizioso tra inflazione e crescita salariale sarebbe ridotto”. Anziché ad una “vana rincorsa tra prezzi e salari”, ci ricorda Visco, bisogna mettere mano alla produttività.
Il governo Draghi, in stretta assonanza, ribadisce il salvifico appello: “Sindacati, imprese e governo lavorino insieme”.
Indice IPCA / massacro sociale / un cenno ancora al gas
È giunto ora il momento di affrontare la questione dell’indice IPCA e della contrattazione collettiva. Ho presente al riguardo la pubblicazione online della collana “ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro, numero del 2013”. La collana è (o almeno era) diretta da Michele Tiraboschi e si ispirava ad Ezio Tarantelli. Il paragrafo che ci interessa reca appunto il titolo “Indice IPCA e contrattazione collettiva”.
Vi leggiamo: “Le crisi petrolifere del 1973-74 e del 1979-1980 hanno restituito all’Italia degli anni Ottanta un’inflazione galoppante, contrastata dagli interventi di politica dei redditi studiati dal professor Ezio Tarantelli (lodo Scotti e decreto di San Valentino), volti ad arrestare la spirale prezzi-salari-prezzi e ridurre l’inflazione giocando una politica salariale d’anticipo in grado di programmare gli aumenti retributivi in linea con l’inflazione attesa”.
Si legge inoltre che, nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione e sugli assetti contrattuali del 1993, le parti sociali “abbandonarono definitivamente il meccanismo della scala mobile, concordando l’utilizzo dell’inflazione programmata nel primo livello di contrattazione e garantendo, quale elemento di tutela del potere d’acquisto dei lavoratori, il recupero dello scostamento tra inflazione programmata ed effettiva.
Al secondo livello di contrattazione spettava invece la regolazione delle retribuzioni sulla base dei risultati di produttività e redditività aziendale”.
Questo meccanismo ha funzionato fino al 2009, allorché, con l’Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, “governo e parti sociali hanno stabilito un nuovo indice previsionale di inflazione: l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell’Unione Europea (IPCA) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. L’elaborazione è stata affidata ad un soggetto terzo, identificato […] a partire dal 2011 […] nell’Istat”.
L’IPCA è una delle innovazioni più note dell’Accordo del 2009, (la Cgil non aderì denunciando la minore protezione fornita da questo indice al potere d’acquisto dei salari).
“L’Accordo ha confermato il sistema di salvaguardia del potere d’acquisto [?!] attraverso la verifica di eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista [non più programmata] e quella reale effettivamente osservata”.
Quindi, tale indice istituzionalmente non contiene l’inflazione importata. I meccanismi dell’inflazione programmata prima e dell’inflazione prevista poi, prevedono recuperi degli altri tipi di inflazione ex post e solo in parte con l’inevitabile effetto che una parte del salario è sottratta ai lavoratori.
Se l’inflazione prevista non contempla, come non contempla, l’inflazione importata, quale strumento di difesa rimane ai lavoratori?
I rinnovi contrattuali che sono lenti, farraginosi, sempre rinviati.
Leggiamo su “Il Fatto Quotidiano” del 4 giugno scorso: “Quasi sette milioni di lavoratori italiani sono in attesa del rinnovo del contratto nazionale. Per dirla meglio, quasi sette milioni di persone aspettano un aumento in busta paga che permetta quantomeno di far fronte ai rincari. Non è tutto: oltre a questi, tanti altri lavoratori hanno ottenuto di recente il rinnovo, ma non ancorato all’inflazione [ora al 6,9%]. […]. Una serie di trattative sono in corso, ma di solito si ragiona prendendo come riferimento l’indice IPCA che non tiene conto dei rincari energetici importati […]. A marzo 2022, secondo l’Istat, il tempo medio di rinnovo dei contratti scaduti risulta pari a 30,8 mesi”.
Dall’abolizione della scala mobile, avviata con il referendum del 1985, i salari hanno molto perduto. La situazione si è aggravata negli ultimi trent’anni (è del 23 luglio 1993, abbiamo visto, il primo accordo interconfederale post scala mobile).
La massa salariale è scemata in modo esponenziale. l’Istat prevede che quest’anno il potere d’acquisto delle famiglie calerà almeno del 5% (la valutazione è benevola).
Secondo l’OCSE, l’Italia è l’unico Paese sviluppato nel quale durante gli ultimi trent’anni i salari sono calati del 3%, mentre in Germania sono aumentati del 34%, in Francia del 31% e in Spagna del 6% (Grafico 1).
Grafico 1: dinamica degli stipendi nei Paesi Ocse fra il 1990 e il 2020. Fonte Ocse
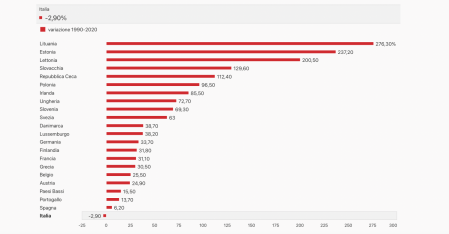
In conclusione, il governo e le elites dei gruppi capitalistici dominanti italiani ed europei (oltre gli USA) che hanno alimentato il carovita prima della guerra in Ucraina, e lo hanno incrementato con le loro politiche guerrafondaie e sanzionatorie nel corso del conflitto, stanno scaricando, e hanno in progetto di continuare a scaricare in futuro, tutto il peso della crisi sui subalterni, sulle masse popolari, le quali non dispongono in Italia (e non solo), di adeguati strumenti di difesa e di soggetti sociali e politici che abbiano la volontà e/o i mezzi per sostenerli.
Inflazione, riarmo, politiche monetarie restrittive, stagflazione, incipiente recessione (in alcuni paesi, esempio Regno Unito, già cruda realtà), disoccupazione, erosione dei risparmi, sostanziale estinzione dei pochi residui di welfare, è questo il quadro d’insieme che abbiamo davanti.
Solo un’ampia mobilitazione di massa dei lavoratori e dei pensionati contro il carovita e la guerra, per la difesa dei salari e delle pensioni, per il lavoro, può contrastare la deriva alla quale UE ed USA hanno condannato gran parte dei loro popoli.
Abbiamo precedentemente affrontato le dinamiche dei prezzi energetici e della loro riferibilità, se non in termini assai parziali, al conflitto in corso in Ucraina.
Dedichiamo ora un cenno al caso degli ultimi giorni del prezzo del gas e alle parziali sospensioni della sua erogazione, da parte di Gazprom, a Germania e Italia (totale la sospensione del poco gas erogato alla Francia).
Nelle ultime settimane l’UE ha proposto il piano REPower EU (confronta sopra) di chiusura strategica all’apporto del gas russo alle sue economie, ha stipulato accordi con l’Algeria per la fornitura di gas a parziale copertura di quello russo (gas che l’Algeria ha potuto fornire perché, per ragioni legate ai suoi rapporti bilaterali con la Spagna per la questione del Sahara Occidentale, lo ha completamente sottratto a quest’ultima). Sono stati stipulati accordi tra UE, Israele ed Egitto per la fornitura di GNL, trasformato dall’Egitto, ed arbitrariamente estratto come gas naturale da Israele nel Mediterraneo, senza intesa alcuna con altri Stati, come il Libano, che ne rivendicano pure la propria giurisdizione.
Tale accordo prelude a un ridisegno dell’area mediorientale con l’emarginazione definitiva di Libano e Siria dai grandi movimenti e interessi d’area e con l’allineamento, pressoché completo, (e questo è un fatto nuovo) delle politiche dell’UE e degli USA anche relativamente alla questione palestinese (a quando il riconoscimento di Gerusalemme capitale da parte della burocrazia di Bruxelles?).
È nota poi l’estensione della ricerca di fonti di approvvigionamento alternativo dell’UE a paesi africani e all’Azerbaigian.
Non si può sottacere inoltre che la Germania ha espropriato “Gazprom Germania”, nodo distributivo e finanziario importante di Gazprom nella diramazione del gas in Germania (e non solo).
L’UE ha varato, si è visto, la sesta tornata di sanzioni alla Russia per il petrolio e i prodotti petroliferi.
Dopo tutto questo, si attendeva dall’Occidente che tutto continuasse come prima da parte della Russia, in modo da permettere all’Occidente stesso di completare, in tempo utile per l’inverno, le operazioni di stoccaggio con il gas russo! Sembrano le pretese di un bambino prepotente che sottrae i giocattoli, tutti i giocattoli, a un altro bambino e vuole continuare, col consenso di quest’ultimo, a giocare con lui.
Inflazione e recessione: il caso emblematico dell’Inghilterra
All’inizio dell’anno la banconota britannica era ai massimi degli ultimi anni sull’euro. Nel giro di poche settimane la sterlina è di nuovo nel ciclone e sta perdendo rapidamente posizioni contro euro e dollaro. Ora il Pound è definito “il malato del mondo” tra le valute. Ha subito un calo del 10% sull’euro in tre mesi.
È una flessione molto rapida che si spiega con una scommessa al ribasso sul Paese: gli hedge fund hanno cambiato posizione sulla sterlina. I dati del mercato dei future statunitensi mostrano che i fondi speculativi hanno iniziato a scommettere contro la sterlina: una scommessa che ora vale quasi 5 miliardi di dollari.
Poco prima dell’inizio della guerra, il 24 febbraio, i dati della “Commodity Futures Trading Commission” hanno mostrato che i fondi detenevano una piccola posizione lunga scadenza sulla sterlina e la stessa valuta veniva scambiata a 1,4 sul dollaro. Nove settimane dopo, i fondi sono short (corti) in sterline per un totale di circa 59 mila contratti: è la più grande scommessa contro la sterlina da tempo.
La giravolta degli hadge fund è conseguenza dell’imminente recessione economica. La Banca d’Inghilterra teme una “apocalisse” economica nel 2022. Scrive ”Il Sole – 24 Ore” del 25 maggio: “Sono gli effetti del mondo post covid, che ha visto l’inflazione salire; e della guerra in Ucraina che ha dato una mazzata al costo dell’energia. Il costo della vita sta salendo a ritmi insostenibili: l’inflazione è attesa al 10% a fine anno, e i redditi delle famiglie sono erosi per pagare le bollette e gli affitti. Con meno consumi, in un’economia che vive di servizi, l’economia rallenta. Ecco che allora hedge fund fiutano la preda e [prendono] posizione. Il Regno Unito [che importa energia] ma anche molto cibo e semilavorati, ha fatto forza su accordi commerciali extra Ue per compensare le perdite del mercato unico. Accordi che finora hanno funzionato anche grazie una valuta forte. Per un paese importatore, significa potere d’acquisto. Ma con una sterlina debole […] diventa molto più costoso. E quindi, a cascata, ancora più inflazione e un’economia ancora più in difficoltà”.
E quindi ancora più vendite sulla valuta da parte dei fondi speculativi. Allora rialzo dei tassi e recessione.
Economia di guerra / armi / dollaro
L’Osservatorio del sulle spese militari italiane (Milex) – fondato nel 2016 con la collaborazione del Movimento Nonviolento, nell’ambito di attività della Rete italiana per il disarmo – il 16 marzo scorso riporta il voto a larghissima maggioranza (391 voti favorevoli su 421 presenti, 19 contrari) di un ordine del giorno collegato al decreto “Ucraina” proposto dalla Lega e sottoscritto da PD, FI, IV, M5S,e FdI. Il voto di tale odg impegna il governo ad avviare l’incremento delle spese per la “Difesa” verso il traguardo del 2% del Pil. Nella parte dispositiva del testo approvato, si legge che tale risultato dovrebbe essere raggiunto “predisponendo un sentiero di aumento stabile nel tempo, che garantisca al Paese una capacità di deterrenza e di protezione”. Mentre nell’immediato bisogna agire per “incrementare alla prima occasione utile il Fondo per le esigenze di difesa nazionale”. Ciò significherebbe, citando le cifre fornite dal ministro Guerini, passare da 25,8 miliardi l’anno attuali (68 milioni al giorno) ad almeno 38 miliardi l’anno (104 milioni al giorno).
L’indicazione di spese militari pari ad almeno il 2% del Pil in ambito Nato deriva da un accordo informale del 2006 dei Ministri della difesa dei Paesi membri dell’Alleanza atlantica, poi confermato e rilanciato al vertice dei Capi di Stato e di Governo del 2014 in Galles.
Era stato deciso che l’obiettivo dovesse essere raggiunto entro il 2024, con un 20% di spesa da destinare ad investimenti in nuovi sistemi d’arma.
La quota indicata del 2% del Pil non ha mai avuto una giustificazione specifica e di natura militare, cioè dettata da esigenze operative, ma è stata vista come spinta alla crescita della spesa. Accanto e oltre l’obiettivo del 2% dei paesi Nato, c’è un ulteriore fondo, “European Defence Fund” (Edf), per cofinanziare progetti transfrontalieri insieme ai bilanci nazionali.
L’Edf (cfr. “Il Fatto Quotidiano” del 26 maggio) ha il compito di assemblare le proposte della lobby delle armi di cui è espressione il Commissario europeo alla Difesa Thierry Breton.
“L’anno scorso Breton ha ufficialmente istituito un comitato di esperti in cui cura a porte chiuse i suoi rapporti personali con i giganti del business della guerra che ambiscono a spartirsi gli 8 miliardi stanziati dall’Edf dal 2021 al 2027”.
Al comitato partecipano 61 enti, la stragrande maggioranza produttori di armi. Tra questi l’italiana Leonardo, le francesi Thales e Safran, la spagnola Indra e Airbus, la società transeuropea con sede in Olanda.
Leonardo è tra i produttori di armi con cifre record per finanziamenti UE, spese di lobbyng ed export.
Nell’elenco dei primi 100 esportatori di armi al mondo, stilato nel dicembre 2021 dall’Istituto internazionale di ricerca sulla pace (Sipri) di Stoccolma, Leonardo occupa il 13º posto con vendite per un valore di 10,6 miliardi. In Europa è terza, alle spalle solo del britannica Bae Systems (22,7 miliardi) e della franco-tedesca Airbus (11,3 miliardi).
L’annunciato riarmo europeo (cfr. “Il Fatto Quotidiano” del 27 maggio), spingerà i Paesi a una ristrutturazione dell’industrie nazionali per sedersi al tavolo della futura Difesa comune, evitando duplicazioni nei programmi. Per questa ragione il governo sta mettendo a punto un “polo militare italiano”, secondo le parole di Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, che potrebbe passare dalla fusione tra Fincantieri e Leonardo.
Se la guerra darà impulso al progetto di Difesa europea bisognerà presentarsi con gruppi solidi e punti di forza di fronte ai concorrenti e in tale quadro va vista la liquidazione di Giuseppe Bono di Fincantieri, considerato un ostacolo all’operazione (era proprio quel Bono della cena con D’Alema, quest’ultimo scoperto a fare da mediatore per una commessa alla Colombia di armi di Leonardo e Fincantieri).
Germania e armi
“Quello che non è riuscito all’ex presidente USA Donald Trump”, (“Il Fatto” del 5 giugno scorso) ”è riuscito al democratico Joe Biden. La Germania pagherà. Comincerà col fondo straordinario di 100 miliardi di euro [da spendere in 3-4 anni] […] per ammodernare le forze armate tedesche […]. Gran parte di questi soldi verranno usati per comprare armi prodotte da aziende americane, a partire dagli F-35.”
Il Parlamento federale ha approvato il 3 giugno scorso la modifica della Costituzione necessaria per creare, con nuovo debito pubblico, il fondo di 100 miliardi annunciato dal cancelliere Scholz il 27 febbraio. E’ pure confermato l’impegno ad aumentare lo stanziamento annuale per la difesa al 2% del Pil, prodotto che nel 2021 ha superato 3.500 miliardi di euro (il doppio di quello italiano). Il che significa che raggiungere il 2% entro il 2024 vuol dire spendere quasi 17 miliardi in più all’anno. Ne è conseguita naturalmente una grande impennata delle quotazioni delle industrie tedesche di armi, in primis la Rheinmetall, colosso degli armamenti terrestri, e poi la Hensoldt, che produce sensori elettronici per i caccia Eurofighter.
Giulio Da Silva sul “Fatto” cit., ci spiega che appunto buona parte (dei 100 miliardi) verrà usata per armi statunitensi. La Germania in marzo ha deciso di comprare 35 cacciabombardieri F-35 prodotti dalla Lockheed, gli unici in grado di trasportare bombe atomiche. E intende comprare anche 60 elicotteri pesanti da trasporto prodotti dalla Boeing. Dagli USA verranno comprati anche missili della Raytheon.
Se l’80% degli stanziamenti tedeschi sarà mandato altrove (USA in particolare), il 60% delle armi già comprate dai Paesi UE tra il 2007 e 2016 è di provenienza USA (e Israele).
Regime militare USA e dollaro
Il Sipri (Istituto Internazionale di Ricerche per Pace di Stoccolma) ha calcolato che i primi 100 produttori di armi del mercato mondiale hanno totalizzato nel 2020 vendite per 531 miliardi di dollari. Mentre la spesa militare mondiale del 2021 ha superato per la prima volta i 2.000 miliardi, tenendo conto di tutte le voci ad esempio il personale (Grafico 2).
Grafico 2: andamento delle spese militari mondiali dal 1988 al 2021. Fonte Sipri

Sempre nel 2021 il Paese che ha speso di più sono stati gli USA (801 miliardi di dollari), seguiti da Cina (293 miliardi), India (76,6 miliardi), Regno Unito e Russia (Grafico 3).
Grafico 3: la spesa militare per Stato nel 2021. Fonte Sipri

Dati più recenti che tengono conto dell’incremento poderoso delle spese militari nel corso dell’attuale conflitto, proiettano la spesa USA non lontana da 1.000 miliardi nel 2022.
Le aziende statunitensi dominano, sono 41 tra le prime 100.
I dati elaborati dal Sipri sono riferiti al 2020 e solo ai ricavi nelle “armi e servizi militari”. Al primo posto c’è Lockheed Martin: 58,2 miliardi di dollari di ricavi su 65,4 del gruppo; al secondo Raytheon, si è visto primo produttore mondiale di missili, quali i noti Patriot. Produce anche gli Stinger e, con Lockheed, i Javelin anticarro forniti anche, e abbondantemente, all’Ucraina.
Terza è la Boeing, 32,1 miliardi di ricavi nella difesa (produce aerei da caccia e armi da rifornimento).
La prima europea è la britannica Bae Systems, sesta con 24 miliardi di ricavi nel settore delle armi. Di Leonardo abbiamo già detto.
La strategia, ormai quasi ottantennale degli USA, di “costruire nemici”, meglio se stabili e di lunga durata, è propria delle logiche di ogni Stato e regime militare. Serve a più scopi rimasti nel tempo abbastanza invariati.
In primo luogo è utile ai fini interni per compattare la popolazione e ottenere consenso all’azione del regime. L’adesione acritica diffusa, infantile, della gran parte dei nordamericani è “costruita”, direi scientificamente, utilizzando le più moderne tecnologie e un apparato vasto e complesso di personale e competenze permanentemente mobilitati allo scopo. Spesso collegati o addirittura emanazione della CIA e delle altre strutture simili (negli ultimi trent’anni soprattutto nell’est Europa sotto la veste esteriore di Ong).
In secondo luogo è basilare per la per la riproduzione capitalistica USA, cioè per quella parte di essa, assai importante, che si fonda sul complesso militar-industriale. Una spesa militare di quasi 1.000 miliardi all’anno destinata in misura rilevante a commesse verso le proprie aziende militari le quali grazie anche al trasferimento dell’innovazione tecnologica realizzata con fondi pubblici facilitano l’export di armamenti che risulta una voce di primo piano del Pil statunitense e della sua bilancia dei pagamenti (Grafico 4).
Grafico 4: i principali 10 Paesi esportatori di armamenti nel quinquennio 2017-21. Fonte: Sipri.

Qual è lo strumento che si è rivelato storicamente più efficace non solo per il predominio geopolitico, ma per la supremazia valutaria e finanziaria su scala planetaria?
È la forza, la forza militare, la preponderanza strategico-militare. Che è (o è stata) anche preponderanza tecnologico-scientifica.
La forza del dollaro, la possibilità per gli USA di ottenere “in perpetuo” il finanziamento del proprio cronico deficit esterno mediante l’uso dell’avanzo delle bilance dei pagamenti degli altri Stati, cioè con il risparmio mondiale, dipendono dalla (finora) grande affidabilità del dollaro e dall’enorme movimento di capitali planetari verso i porti della finanza americana. E tutto questo discende da varie cose, di cui una è essenziale: la primazia militare.
Per tale ragione le opposizioni – quale quella russa per interposta Ucraina – all’ormai longevo modello statunitense, destano reazioni viscerali e un’aspra volontà di annichilimento dell’oppositore, meglio se attraverso conflitti (degli altri) di lunga durata.
Quindi opporsi ai disegni guerrafondai degli USA, per interposta Nato e con l’assistenza ancillare dell’UE, è opporsi a quel modello e al conseguente signoraggio del dollaro.
Quale Russia?
Due mesi e mezzo fa (a 45 giorni dall’inizio delle ostilità) erano state valutate in più di 600 le multinazionali che si supponeva avessero deciso o annunciato di uscire in tutto o in parte dalla Russia. Nei settori più diversi, da petrolio e hamburger all’high tech, media e banche.
Secondo Jeffrey Sonnenfeld, dell’Università di Yale, gran parte delle imprese in uscita era statunitense ed europea con alcune rilevanti eccezioni asiatiche come Samsung e Toyota.
Del complesso delle aziende alcune si ritirarono (all’aprile scorso 250), altre sospesero le attività (257), altre si ridimensionarono (72), altre ancora presero tempo (99), rinviando gli investimenti. Secondo Sonnenfeld erano 194 i gruppi, per così dire, “arroccati” in Russia. Tra questi la conglomerata USA Koch Industries, Astra-Zeneca, J&J (“Il Sole – 24 Ore”del 9 aprile scorso).
Tra le italiane, l’ad (Amministratore Delegato) di Intesa San Paolo, Carlo Messina, ebbe a dichiarare in aprile che l’impatto sulla banca fosse “assolutamente gestibile”, mentre la presenza in Russia fosse ormai “in fase di revisione strategica”. Intesa “sin dall’inizio della crisi […] non ha perfezionato nuovi finanziamenti con controparti russe e bielorusse e ha interrotto le attività di investimento in strumenti finanziari”. L’esposizione complessiva di Intesa San Paolo verso la Russia era al momento di circa 5,1 miliardi di euro.
Più significativa era l’esposizione di Unicredit Russia (13,3 miliardi), presente al Forum di San Pietroburgo del 15-18 giugno (Spief) con Vadim Aparkhov, membro del consiglio di amministrazione della controllata russa AO Unicredit Bank.
Andrea Orcel, ad di Unicredit, nei giorni a ridosso del Forum, a proposito dell’attività della banca in Russia, ha dichiarato: “La nostra esposizione in Russia è stata gestita in modo razionale: l’abbiamo ridotta, ma svalutare il business non è corretto e non è nemmeno in linea con le sanzioni”. In sostanza Unicredit non intende svendere le sue attività in Russia.
L’ad di Enel, Francesco Starace, nei mesi scorsi a più riprese ebbe a dichiarare che il gruppo “non poteva avere un ulteriore crescita in Russia”, ove controlla tre impianti di generazione a ciclo combinato e due impianti eolici. Tutte le strade per lui “erano percorribili”.
Il 16 giugno scorso (cfr. “Il Sole – 24 Ore” del 17 giugno), prima energy company, Enel ha concluso un accordo di vendita di tutti gli asset in Russia. I compratori sono Lukoil (la più importante società petrolifera russa e una delle principali al mondo) e il Fondo privato di investimento Gazprombank-Frezia, non colpiti dalle sanzioni. Enel ha ceduto per 137 milioni di euro il 56,43% che deteneva di Enel Russia. L’operazione deve ancora ottenere il via libera della Commissione governativa russa per il monitoraggio degli investimenti esteri, autorizzazione che non dovrebbe mancare perché, ci spiega Starace, “i compratori hanno già avuto un via libera quando hanno rilevato le catene di distribuzione che la Shell ha venduto in Russia”.
Gli azionisti di riferimento di Lukoil, fino alle dimissioni in aprile di Alekperov, erano appunto Vagit Alekperov (28,30%) e Leonid Fedun (9,32%). Alekperov era un giovanissimo dirigente d’azienda sovietico, il quale, nella veloce transizione dei primi anni Novanta è diventato dirigente dell’azienda privatizzata e poi socio di riferimento della medesima. Le dimissioni, apparentemente per dissenso con l’ “operazione speciale” in Ucraina, per molti in Russia, sono stati un “escamotage” per salvare Lukoil in caso di esito infausto per la Russia della vicenda Ucraina (e per salvare Alekperov stesso). Non si può dire. Vedremo.
Senz’altro la cessione degli importanti asset dell’Enel in Russia è avvenuta a favore di soggetti privati, uno dei quali è un soggetto finanziario.
Per come si presenta, sembrerebbe un’operazione in continuità con il passato.
Un brevissimo cenno a Eni, la quale ha dichiarato di essere pronta a cedere le quote in Blue Stream (detenute con Gazprom). Fermiamoci qui.
La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, il 25 maggio scorso ha approvato una legge che consente al governo russo di nominare un nuovo management e di fatto espropriare le società (soprattutto USA, giapponesi ed europee) che hanno interrotto la loro attività nel paese, dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, non per motivi economici ma “per sentimenti antirussi” (“Il Sole 24 – Ore” del 26 maggio).
Secondo la Yale School of Management, a fine maggio, sono 500 le società che hanno deciso di lasciare la Russia. Esse rappresentano il 63% delle aziende straniere presenti nel territorio russo prima della guerra, con quasi 40 mila dipendenti e un fatturato di circa 7,5 miliardi di euro. “La lista nera stilata da Mosca comprende decine di multinazionali della logistica, dell’industria energetica, delle tecnologie, dell’automotive, della grande distribuzione: da Maersk a Msc; da Shell a Bp; da Volkswagen-Porsche a Toyota, Volvo e Renault; da Apple a Microsoft a Ibm; da McDonald’s a Starbuks, Levi’s, Ikea [etc.]. Molte di queste hanno sospeso le operazioni, […] altre hanno abbandonato tutto, nonostante i notevoli investimenti” (ib.).
Il 25° International Economic Forum di San Pietroburgo (SPIEF)
Il 6 giugno scorso, in un messaggio agli organizzatori del Forum, il presidente Putin ha parlato dei settori industriali in difficoltà. Si tratta in primo luogo del settore automobilistico sul quale pesa (oltre la partenza di importanti case straniere come Renault e Volkswagen), la mancanza, a causa delle sanzioni, di componenti importate. Ciò costringerà le fabbriche a chiudere via via che le scorte si esauriranno. Anche l’industria siderurgica rischia “sostanziali tagli produttivi nel medio termine”.
Entro fine luglio il Governo, secondo una direttiva presidenziale, dovrà definire una nuova impostazione del budget federale per i prossimi anni, che miri a ridare slancio alla crescita.
Sono molte le domande che nascono di fronte alla genericità del progetto di espropriazione delle realtà industriali dei “paesi ostili” e all’altrettale genericità del “nuovo” budget federale. A chi andranno le industrie espropriate o acquistate? Saranno puramente e semplicemente privatizzate? Chi costruirà i loro progetti industriali? Il management proverrà dal bacino del modello economico putiniano dei decenni precedenti? Le aziende pubbliche e/o pubblicizzate che ruolo avranno nella Russia del post-conflitto?
L’intervento di Putin del 17 giugno scorso alla sessione plenaria del Forum, qualche risposta (non molte) l’ha data.
Dividiamo il suo intervento in due parti: quella dell’attacco (fondato e condivisibile) all’Occidente e quella progettuale.
“Gli Stati Uniti si consideravano l’emissario di dio sulla terra ma ora la Russia sta prendendo il proprio posto in un nuovo ordine mondiale le cui regole sono stabilite da Stati forti e sovrani […]. L’era dell’ordine mondiale unipolare fondato sullo strapotere degli USA è finita”.
“Nulla sarà come prima, nulla è eterno” dice poi il presidente della federazione russa. “Il blitzkrieg economico contro la Russia non è riuscito, non aveva alcuna possibilità di riuscire fin dall’inizio”. Ed ora danneggerà di più chi ha imposto le sanzioni “folli e insensate”, una spada a doppio taglio che potrebbe far perdere all’UE più di 400 miliardi di dollari.
“La Russia” prosegue, “non ha alcuna responsabilità” per la crisi economica e per un’inflazione in Occidente le cui radici, sottolinea, risalgono a prima del conflitto. “La Russia perseguirà l’obiettivo di inflazione al 4% […]”.
“Abbiamo sentito parlare tutti di inflazione putiniana […]. Io penso: ma chi ha ideato questa stupidaggine? Chi non sa né leggere né scrivere. Ecco tutto”.
E ancora: “L’UE ha perso la sua sovranità politica, adottando sanzioni che le si sono ritorte contro e i cui costi ricadranno sulle popolazioni […]. Hanno fatto tutto con le loro mani”.
Per l’Europa poi già si intravede “un aggravamento delle disparità, delle tensioni sociali, dei radicalismi […] e in prospettiva il cambio delle elites al potere”.
Passando alla seconda parte, Putin dichiara che la Russia è “pronta ai cambiamenti globali e propone nuove soluzioni alla crisi”. Bisogna trasformare i problemi in possibilità. “Dobbiamo fare un lavoro sistemico, un piano di sviluppo a lungo termine impostato su alcuni principi chiave”.
In primis il rifiuto dell’isolamento: “La Russia si svilupperà come un’economia aperta, non imboccherà la strada dell’autarchia”.
Il secondo elemento fondamentale è l’appello al contributo degli imprenditori privati, come Oleg Deripaska, che ascolta in prima fila.
La Russia “deve essere in grado di produrre tecnologie chiave”. E’ fondamentale raggiungere “l’indipendenza” nelle alte tecnologie.
E, rivolto agli investitori, anche occidentali: “Il nostro Paese ha un enorme potenziale […] investite qui, investite nella creazione di nuove imprese […]”.
Un ruolo centrale nella Russia post-conflitto sembra destinato allora all’impresa privata interna ed esterna. L’inquietante presenza di gente come Deripaska, lascia aperto il dubbio che si tratti solo di un parziale rimescolamento di ceti capitalistici russi sempre interni al modello e alle caratteristiche proprie del ceto dirigente economico-finanziario russo degli ultimi decenni.
Non basta il riferimento, nella relazione, alle indicizzazioni che sono effettive, al mantenimento di una qualche forma di welfare e a misure di tutela dei ceti subalterni, quali i crediti agevolati, i sussidi, mutui a tassi bassi. Ne basta l’importante aumento (10%), operato nei mesi scorsi, di salari e pensioni medio-bassi per fronteggiare l’inflazione. Parte di tutto questo, e in misura certamente minore, lo vediamo anche in Occidente.
Non è visibile al momento, a giudicare dalle parole di Putin, una chiara volontà di costruire un’architettura economico-sociale “alla cinese”, con un ruolo importante deferito al capitale pubblico (e ai soggetti economici pubblici) e con la relativa capacità di orientamento e controllo, se e quando strettamente necessario, da parte del ceto politico nei confronti di un consistente e intraprendente ceto capitalistico.
Nel discorso di Putin al Forum, le aziende a partecipazione statale, per il futuro, sembrano relegate a un ruolo economicamente e politicamente non più rilevante di quello che occupano ora.
Ma esiste un progetto alternativo e di opposizione nella Russia post-bellica, escludendo, il dissenso dei ceti filo-occidentali delle grandi città legati, per rapporti materiali e culturali, alle multinazionali occidentali?
Non è dato sapere con chiarezza. Di certo il partito comunista di Gennadij Zjuganov ha mostrato da tempo subalternità rispetto al disegno e alla prassi politica dei partiti che hanno sostenuto i vari governi russi.
Concludo affermando che sarebbe un’occasione perduta, per la Russia e anche per le masse popolari dell’Occidente, se tutto o gran parte di quello che è successo e sta succedendo fuori dalla Russia e dentro la Russia si risolvesse alla fine in una operazione puramente geopolitica, oltre naturalmente che di difesa delle popolazioni vessate del Donbass e di resistenza all’aggressività della Nato per interposta Ucraina. E non favorisse i “cambiamenti strutturali” economico-sociali e politici (quantomeno verso un’economia mista del tipo cinese), con la comparsa di nuove soggettività, di nuove rivendicazioni e di nuova democrazia sociale, economica e politica.
Firenze, 22 giugno 2022
Raffaele Picarelli
“CINA. L’irresistibile ascesa.” Nuovo libro di Alberto Bradanini
L’eterotopia, il significato del comunismo cinese e la visione di Mao, la rivoluzione culturale, l’avvento di Deng Xiaoping, i complessi e delicati rapporti di Xi Jinping con gli Stati Uniti. Lo sguardo di Bradanini abbraccia l’evolversi della Repubblica Popolare sin dalla sua nascita nel 1949.
ILLUSTRATO CON FOTOGRAFIE DI ANDREA CAVAZZUTI
pp. 368 – €18

Il presente volume non è scritto per il mondo accademico, né si aggiunge ai tanti libri sulla Cina che elencano dati e tabelle sull’economia cinese. È un’opera ambiziosa e non effimera, che scava alle radici della civiltà cinese. Rappresenta uno strumento essenziale per comprendere politica ed economia della Cina contemporanea, ma anche il modo di pensare dei suoi abitanti.
Questo libro è un ausilio indispensabile per capire un paese immenso e ancora poco conosciuto nella sua complessità, utile per tutti coloro che si accostano alla Cina per curiosità intellettuale, ma anche per chi vi si reca per affari, studio, o per turismo culturale.
In esso vengono riportate dettagliatamente le cifre del miracolo economico cinese, ma il suo merito principale è quello di essere un viatico per comprendere la cultura e la mentalità della Cina, il modo di rapportarsi al mondo esterno dei suoi abitanti e il suo modo di intendere gli affari.
Nella descrizione del contesto cinese si avverte chiaramente il tatto di un esperto conoscitore. L’autore è stato infatti rappresentante d’Italia a Honk Kong e Pechino, osservando in prima persona la realtà e le contraddizioni di un paese che in pochi anni ha vissuto cambiamenti politici, economici e sociali stupefacenti.
Alberto Bradanini Laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di Roma, inizia la carriera diplomatica nel 1975. Tra i diversi incarichi ricoperti, dal 1996 al 1998 è stato Console generale d’Italia ad Hong Kong, dal 2008 al gennaio 2013 Ambasciatore d’Italia in Iran, e dal 2013 al maggio 2015 Ambasciatore d’Italia in Cina. È attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea.
Viale Manzoni, 39 – 00185 Roma • Tel. +39.06.58334070 • Mob. +39.389.7847802 • info@sandrotetieditore.it
http://www.sandrotetieditore.it
Cina: crescita economica, progresso e trasformazioni sociali. Gli effetti e le politiche di gestione del Covid.
di Andrea Vento
La tempestosa crescita cinese
La struttura economica cinese ha registrato, dalla sua fondazione ad oggi, un eccezionale sviluppo con una crescita del Pil che l’Istituto Nazionale di Statistica della Repubblica Popolare, a luglio 20191, ha quantificato, per il periodo compreso fra il 1949 e il 2018, ad un tasso medio annuo addirittura dell’8,1%.
A seguito dell’approvazione delle “Linee di riforma e apertura economica” che hanno avviato la transizione del sistema economico, a partire dal 1979 e per i due decenni successivi (grafico 1), la Cina ha vissuto una rapida, ma non sempre regolare, crescita con percentuali variabili tra il 4 e 14% annuo. Dopo il rallentamento del biennio 1998-99, a seguito della crisi finanziaria dei Paesi de sud-est asiatico, il tasso di crescita ha iniziato ad aumentare di nuovo sino ad un massimo del 14% nel 2007 alle soglie della crisi globale, per poi gradualmente ridursi sino a stabilizzarsi dopo il 2012 su valori di poco inferiori all‘8% e assestarsi nel quinquennio 2015-19 su incrementi compresi fra il 6 e il 7% (tabella 21).
Da uno sguardo sinottico sui primi 40 anni della fase post-maoista, emerge come, a seguito delle riforme, l’economia cinese sia cresciuta ad una media del 9,4% all’anno, un tasso superiore di oltre 3 volte rispetto al del 2,9% della media mondiale.
Grafico 1: anni 1984-2013. Diagramma lineare: variazione annua del pil in percentuale. Istogramma: crescita entità totale del Pil in reminmbi (o Yuan, con cui si identifica l’unità monetaria di base)

Una straordinaria espansione dell’economia certificata dalla crescita del Pil, il quale, sempre secondo il solito rapporto dell’Istituto Nazionale di Statistica cinese, dai soli 67,9 miliardi di yuan del 1952 ha raggiunto i 90.030 miliardi di yuan (circa 13.140 miliardi di dollari) nel 2018 (con un incremento di ben 1.325 volte), un valore pari al 16% del totale dell’economia mondiale; mentre il Pil pro capite nel 2019 ha superato per la prima volta 10.000, facendo attestare la Cina fra i paesi a sviluppo intermedio3.
Tabella 1: tassi di crescita annuali 2015-2019 rilevati in base a la “Nuova normalità”. Fonte: Banca Mondiale
| Tassi di crescita dell’economia cinese 2015-2019 | |
| anno | variazione % |
| 2015 | 6,9 |
| 2016 | 6,7 |
| 2017 | 6,8 |
| 2018 | 6,6 |
| 2019 | 6,1 |
Il forte surplus commerciale degli ultimi 15 anni (grafico 2), nonostante sia sotto attacco a seguito della guerra commerciale innescata da Trump, ha consentito alla Cina, ormai prima potenza commerciale mondiale dal 2013, di aver accumulato, sino al 2018 nelle proprie casse, ben 3.070 miliardi di dollari di riserve valutarie, segnando per il tredicesimo anno consecutivo il più alto valore a livello mondiale. La Cina è divenuto il primo partner commerciale, scalzando gli Usa, di Giappone (2004) India (2008) e Brasile (2009)
Grafico 2: andamento import-export Repubblica Popolare Cinese anni 1995 – 2017. Dati in miliardi di dollari provenienti da “THE OBSERVATORY OF ECONOMIC COMPLEXITY”
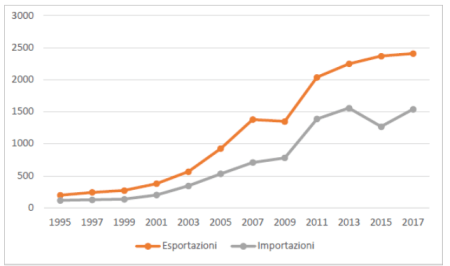
La “Nuova normalità”
Il delicato passaggio del rallentamento della crescita al di sotto del 10% degli ultimi quindici anni è stato accuratamente pianificato e gestito dalla dirigenza cinese attraverso una specifica politica economica, che approvata nel marzo 2015 dall’Assemblea Nazionale, ha assunto la denominazione di “Nuova normalità”. Quest’ultima prevede non solo la riduzione e l’assestamento dei tassi di crescita per gli anni successivi intorno al 7%, ma come annunciato dallo stesso Primo Ministro Li Keqiang, la Cina «deve conservare un equilibrio tra la necessità di assicurare una crescita costante e quella di promuovere aggiustamenti strutturali». «Metteremo in atto la strategia “Made in China 2025″ -ha proseguito Li Keqiang- cercando uno sviluppo basato sull’innovazione, perseguendo lo sviluppo verde e raddoppiando i nostri sforzi per migliorare la Cina, facendola diventare da un produttore di quantità, uno di qualità».
Gli obiettivi individuati dal governo mirano:
- alla trasformazione dell’apparato produttivo tramite l’espansione del settore Hi-Tech con il conseguente ridimensionamento del manifatturiero a basso costo e basso valore aggiunto,
- alla diminuzione dell’inquinamento
- all’innalzamento dei redditi dei ceti inferiori al fine di ridurre le disuguaglianze sociali,
- ad incrementare la domanda interna per compensare il rallentamento di quella internazionale.
La Cina ha cercato, quindi, di porre rimedio all’andamento incerto, e tendenzialmente in fase di rallentamento, dell’economia mondiale (tabella 2) cercando di aumentare i consumi nazionali e di creare un «mercato interno capace di essere volano dell’economia, per i prossimi anni a venire», come ha concluso il primo ministro Li.
Inizio 2020: il Covid 19 deflagra dall’epicentro di Wuhan
L’esplosione della pandemia ad inizio 2020 nella provincia centrale dell’Hubei e la successiva propagazione all’interno del Paese hanno inevitabilmente generato, a seguito delle stringenti misure adottate dal governo, immediati effetti negativi sull’economia cinese spingendola in recessione nel trimestre iniziale dell’anno (-9,7%); il primo da quando viene effettuata la rilevazione trimestrale dell’andamento economico dal 1992 (grafico 3).
L’efficacia delle politiche governative volte al contenimento della diffusione del virus ha, tuttavia, permesso all’economia cinese, la prima a livello mondiale a subirne gli effetti e a scivolare in pesante recessione nel primo trimestre dell’anno, di riprendere la sua traiettoria di crescita sin dal secondo, mentre le economie europee, nello stesso periodo, scivolavano in profondo rosso.
Il corposo rimbalzo del secondo trimestre (+11,6%) ha consentito all’economia cinese l’immediato recupero del terreno perso nel primo e, nella seconda metà dell’anno, di ritornare a livelli di crescita addirittura superiori a quelli antecedenti l’esplosione della pandemia.
In pratica, ad un solo mese di distanza dalla dichiarazione dello stato di pandemia mondiale da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità avvenuta l’11 marzo 2020, mentre i Paesi sviluppati iniziavano a sprofondare nel baratro della recessione, le autorità cinesi l’8 aprile già procedevano alla rimozione del durissimo lockdown introdotto il 23 gennaio a Wuhan e nell’intera provincia dell’Hubei.
Straordinario risultato senza dubbio riconducibile in primis alle misure di gestione della pandemia da parte delle autorità cinesi che l’articolo “China’s success full control of Covide-19”4, pubblicato dalla prestigiosa rivista medica The Lancet – Infectious Diseases (grafico 3), individua in:
- un sistema centralizzato di gestione delle epidemie
- misure restrittive particolarmente stringenti
- un sistema nazionale di tracciamento dei contatti
- capacità di adattare l’apparato industriale all’impennata della domanda di dispositivi di protezione individuale (dpi) come mascherine, camici e di altro materiale medico come i ventilatori polmonari
- la collaborazione attiva della popolazione nel rispettare le misure adottate dal governo
- sistematico controllo della trasmissione del virus sui territori e dei flussi di persone dall’estero
- scarsa presenza, solo il 3% del totale, di popolazione anziana in strutture di riposo.
Grafico 3: andamento dei contagi nella Rep. Popolare Cinese nei primi 11 mesi del 2020.
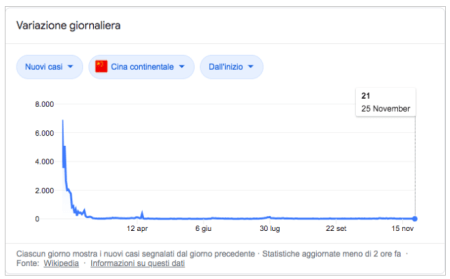
Conferma in tal senso arriva anche dal dr Gregory Poland, direttore del Vaccine Research Group della Mayo Clinic of Rochester (Usa), i quale ha individuato nella rapidità di risposta l’arma più efficace adottata dal governo, specificando che “In Cina hai una combinazione tra una popolazione che prende sul serio le infezioni respiratorie ed è disposta ad adottare interventi non farmaceutiche, con un governo che può imporre forti limitazioni alla libertà individuale che non sarebbe considerate accettabili nella maggior parte dei Paesi occidentali. L’impegno per il bene superore è radicato nella loro cultura; non c’è l’iperindividualismo che caratterizza gli Stati Uniti e che ha guidato gran parte della resistenza alle contromisure contro il Covid”.
Risultati eccezionali non solo per la gestione della prima fase pandemica ma soprattutto perché ha evitato le varie ondate successive che invece hanno investito la quasi totalità dei Paesi.
Grafico 4: variazione percentuale trimestrale del Pil della Repubblica Popolare Cinese (2018-2021)

2020: la pandemia si abbatte sull’economia mondiale
L’impatto della pandemia ha, invece, prodotto effetti devastanti sull’economia globale, spingendola a fine 2020, secondo la Banca Mondiale, in una delle peggiori recessioni dal 1870. L’eccezionalità della crisi innescata dalla pandemia viene confermata anche dal capo economista dell’Ocse, Laurence Boone, durante la presentazione dell’Outlook sull’economia mondiale il 16 settembre 2020 a Parigi: “il mondo sta scontando il più drammatico rallentamento dai tempi della Seconda Guerra Mondiale”5, indicando una riduzione del 5,5%, di poco superiore al 4,8% previsto dal Wto il 6 ottobre dello stesso anno (tab. 2). Recessione che in era di globalizzazione è stata inevitabilmente accompagnata da una riduzione ancor più brusca del commercio internazionale di beni, addirittura, stimata di entità doppia (-9,2%) rispetto al calo del prodotto lordo mondiale. Ciò a seguito anche della riorganizzazione delle catene globali del valore (Global Value Chains – GVC) improvvisamente rivelatesi fonte di fragilità e dipendenza dall’estero per le economie sviluppate. A seguito di ciò, le potenze industriali europee e, soprattutto, gli Stati Uniti, hanno cercato di riacquisire parziale “Autonomia strategica” (Fonte: Ocse 2020), quanto meno nei settori sensibili, imprimendo un nuovo impulso alle politiche di reshoring, che seppur restando fenomeno di dimensioni ridotte, hanno l’obiettivo strategico di mettere in sicurezza quanto meno le produzioni essenziali per l’interesse nazionale6.
Tabella 2: variazione annua % Pil e commercio di beni mondiale 2015-2021. Fonte: Wto – 6 ottobre 20207
Periodo | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 previsioni | 2021 previsioni |
| Prodotto Lordo Mondiale | 2,8 | 2,4 | 3,1 | 2,9 | 2,2 | -4,8 | 4,9 |
| Commercio Mondiale di beni | 2,3 | 1,6 | 4,6 | 3,0 | -0,1 | -9,2 | 7,2 |
Previsioni macroeconomiche indubbiamente drammatiche quelle delle due istituzioni internazionali, solo lievemente attenuate dai dati definitivi rilevati e diffusi dal Fmi per lo scorso anno, a seguito della sensibile ripresa dell’economia mondiale dell’ultima parte dell’anno. Il prodotto lordo mondiale subisce, infatti, un contraccolpo del – 4,6%, con i Paesi europei, i primi ad essere investiti dal Covid-19 dopo quelli asiatici, che registrano le situazioni più gravi: Regno Unito -9,9%, Italia -8,9%, Francia -8,3%, mentre la Germania si ferma ad un solo -4,8%. Tutti valori superiori sia alla media mondiale, sia al dato degli Stati Uniti (-3,5%) che confermano come l’Europa, e in particolare l’area dell’euro (-6,5%), abbia subito le ripercussioni economiche più gravi su scala globale (tab 3).
Nel contesto di questo panorama mondiale recessivo, spicca in senso inverso la situazione della Cina che registra nel 2020, sempre secondo il Fmi, un’espansione dell’economia pari al 2,3%, tasso che pur risultando il più basso degli ultimi 40 anni (grafico 1) consente, tuttavia, al gigante asiatico, da un lato, di annoverarsi come unico paese in crescita fra le principali 20 economie mondiali (G20) e, dall’altro, di alleviare la gravità della recessione globale. Una performance inferiore solo a quella del Vietnam, Paese con modello politico-economico simile a quello cinese, del Bangladesh (+3,8%) già in fase di forte crescita prima della pandemia e dell’Etiopia, uno degli stati africani più dinamici, che registra un eccezionale +6,1%.
L’immediata ripresa dell’economia cinese, oltre alle rigide ed efficaci misure di contenimento della pandemia adottate dal governo, è frutto dell’implementazione di incisive politiche economiche basate su tre linee di intervento: un cospicuo aumento della spesa pubblica corrente (+10,5%), l’eccezionale ripresa dell’export (+30%) e un sensibile incremento degli investimenti pubblici produttivi e infrastrutturali (+14,9%) che ha compensato la diminuzione degli investimenti privati8. In sintesi il governo ha attuato un aumento del disavanzo pubblico imponendo agli istituti bancari di rifinanziare le linee di credito e di posticipare le scadenze e alle imprese pubbliche di aumentare gli investimenti con immediate ricadute positive sia sulla diminuzione dei consumi familiari, fermatisi a -5,8%, che sulla ripresa economica.
Tabella 3: variazione % Pil 2020 e previsioni 2021
| Anno | Economia mondiale | Cina | Regno Unito | Italia | Fra | Ger | Usa | Area euro | Econ Svil |
| 2020 Dati definitivi | -4,6 | 2,2 | -9,9 | -8,9 | -8,3 | -4,8 | -3,5 | -6,5 | -4,6 |
| 2021 previsioni di luglio | 6,0 | 8,1 | 7,0 | 4,9 | 5,8 | 3,6 | 7,0 | 4,6 | 4,4 |
| Fonte: Wto – luglio 2021 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021 |
L’opposto andamento dell’economia cinese rispetto a quella mondiale e dei principali competitors, registrato nel 2020, ha inevitabilmente avuto riflessi sulla geoeconomia globale, nel cui contesto Pechino ha ampliato il proprio ruolo e il proprio peso aumentando dell’1% la quota di prodotto lordo mondiale, salendo al 18,3%, al cospetto degli Usa che restano stabili e dell’Ue che dal 15,4% del 2019 è sceso al 14,9%, un declino peraltro in atto da tempo, con il nostro Paese in prima fila sceso in solo anno da poco meno il 2% all’1,87%9.
Divergenti dinamiche di recupero post pandemico che hanno, inevitabilmente, avuto riflessi sulle traiettorie di crescita delle due economie che secondo il report del Centre for Economics and Business Research (Cebr)10 del 26 dicembre 2020, si incroceranno ben 5 anni prima rispetto alle previsioni pre Covid. In sostanza, nel caso le previsioni dell’autorevole centro di ricerca si riveleranno centrate, già nel 2028 la Repubblica Popolare Cinese si ergerà ai vertici della graduatoria delle potenze economiche mondiali, scalzando gli Stati Uniti.
Alla luce di tali dinamiche geoeconomiche che vanno interpretati alcuni recenti provvedimenti dell’amministrazione Biden tesi a ridimensionare la presenza militare Usa nello scenario Mediorientale, Afghanistan compreso, per aumentarla nello scacchiere Asia-Pacifico, rivitalizzando la politica obamiana del “Pivot to Asia” finalizzata al contenimento dell’espansione cinese nell’area.
Sviluppo economico e progresso sociale
La tumultuosa crescita cinese ha prodotto, per il Paese nel suo complesso, eccezionali progressi in campo economico, come abbiamo appena analizzato, con significativi riflessi positivi anche a livello sociale. Secondo la Banca Mondiale, da quando a fine 1978 Deng Xiao Ping ha fatto approvare “Linee di riforma e apertura economica”, circa 850 milioni di cinesi sarebbero usciti dalla povertà estrema, dei quali 770.000 residenti nelle aree rurali. Un’opera ciclopica mai realizzata prima nella storia dell’umanità che rappresenta il 70% del totale delle persone uscite dalla povertà nel periodo considerato a livello mondiale e che corrisponde alla popolazione dell’Ue a 27 (469 milioni) e degli Stati Uniti (329 milioni)11 messi insieme.
Risultati in linea con il recente progetto di “vitalizzazione delle campagne”, lanciato dal governo il 4 febbraio 2018, tramite il quale è stato prefissato l’obiettivo di far crescere l’economia delle aree rurali e ridurre, entro il 2034, lo squilibrio città/campagna, con lo scopo intermedio di eliminare completamente la povertà nel 2020, come previsto dall’ultimo ciclo di lotta alla povertà inaugurato nel 2012, quando i cinesi in povertà assoluta ammontavano a 98,99 milioni.
Eccezionali progressi che, nonostante la crisi recessione da Covid-19 del primo trimestre 2020, hanno consentito al presidente cinese Xi Jimping, in una cerimonia ufficiale a Pechino, di dichiarare, il 25 febbraio 2021, “vittoria totale” nella lotta alla povertà, a seguito dell’uscita dalla miseria degli ultimi milioni di persone ancora presenti nelle aree rurali12
Specifichiamo tuttavia che in condizione di povertà estrema attualmente in Cina si trova una persona con un reddito annuo inferiore ai 3.218 yuan, corrispondenti al cambio attuale a circa 1 euro e 10 centesimi al giorno13, un parametro, quindi, meno stringente rispetto alla soglia fissata dalla Banca Mondiale di 1.90 dollari al giorno (1,61 euro)14.
Le trasformazioni del corpo sociale cinese: i nuovi ricchi
La struttura sociale cinese, come abbiamo già accennato, dopo l’egualitarismo dell’era maoista, ha subito profonde trasformazioni con la formazione di una corposa classe media composta attualmente da 430 milioni di persone15 che, concentrate in prevalenza nelle aree urbane, insieme all’elite socio-economica composta dai nuovi ricchi, rappresentano i ceti economicamente in fase di espansione. Infatti, se la prima si è in pratica formata nel breve arco di 2 decenni, anche i secondi, i più facoltosi, sono in rapida crescita come testimoniato dal Billionaires Report 2018, dal quale emerge come miliardari, non i soli componenti di questa classe sociale, in Cina siano passati dai 16 del 2006 ai ben 373 nel 2017 e con un trend in accelerazione visto che proprio in quell’anno se ne sono registrati 89 di nuovi, esattamente il triplo rispetto agli Usa. I miliardari cinesi, circa un quinto del totale mondiale, hanno, inoltre, incrementato il loro patrimonio del 39% rispetto al 2016, facendolo salire a 1.120 miliardi di dollari16.
L’immediata ripresa economica post pandemica hanno innescato un’ulteriore accelerazione al trend sopra analizzato, come testimoniato dal report della Hurun Rich List 2020, l’equivalente cinese della rivista Forbes, del 21 ottobre 2020, il quale ha rilevato una sensibile crescita, rispetto all’anno precedente, del numero di miliardari cinesi e delle loro ricchezze. I miliardari, in un solo anno, aumentano, infatti, di 257 unità facendo salire il numero totale a 878 consentendo di superare addirittura quelli statunitensi (788) con i loro patrimoni che incrementano di ben 1.500 miliardi di $ facendo salire il valore dei loro asset a ben 4.000 miliardi di $. Il solo Jack Ma, cofondatore di Alibaba, incrementa il suo patrimonio di ben il 45%, confermandosi per il terzo anno consecutivo in testa alla graduatoria con un patrimonio di 59 miliardi di $.17
La classe media emergente
La classe media cinese emergente è contraddistinta da un’educazione di alto livello, è informata, abituata a viaggiare, orientata all’acquisto di prodotti tecnologici, all’utilizzo dei social network e allo shopping online e apprezza i prodotti occidentali e, in particolare, il made in Italy, pertanto rappresenta, soprattutto per la sua entità numerica, il ceto su cui il governo fa leva per l’espansione dei consumi interni. Il rapporto di McKinsey 2013, che fissava il reddito della classe media cinese tra i 9 mila e 34 mila dollari all’anno, aveva previsto che nel 2022 il 75% dei consumatori urbani della Repubblica popolare sarebbe appartenuto a tale fascia, confermando sia la sua crescita numerica, sia la sua concentrazione nelle aree urbane dell’area costiera, a più alto tasso di urbanizzazione e maggiormente progredita dal punto di vista economico.
Un ceto sociale, al pari dei nuovi ricchi, strettamente legato al Partito Comunista in quanto il processo di espansione dell’economia è stato, e resta tutt’ora, subordinato al successo delle politiche implementate dal governo. A smentire le previsioni di alcuni politici e analisti occidentali, in particolare statunitensi, in base alle quali la classe media una volta raggiunta la prosperità economica avrebbe iniziato ad avanzare richieste di riforme politiche in modo da arrivare a scardinare l’egemonia del Partito Comunista dall’interno, è stato lo stesso Quotidiano del popolo. L’organo ufficiale di stampa del Pcc, nel 2017 ha, infatti, affermato, che l’ascesa della classe media non rappresenta una sfida all’autorità del Partito, anzi è fondamentale per sostenerne la legittimità. L’articolo, andava oltre, specificando addirittura che la classe media era diventata una forza trainante nel mantenimento della stabilità interna e che i paesi che ne risultano sprovvisti, come quelli mediorientali e latinoamericani, affrontano crisi politiche e turbolenze sociali cicliche.
A conferma delle strette interrelazioni presenti fra la leadership politica e il ceto imprenditoriale cinese rileviamo le donazioni spontanee effettuate da alcuni dei nuovi ricchi a seguito del lancio della politica della “Prosperità condivisa” il 17 agosto u.s. tesa a ridurre gli squilibri e ad aumentare il tenore di vita dei ceti più bassi, chiamando a contribuire i soggetti che grazie allo sviluppo economico promosso dal Partito Comunista Cinese sono riusciti ad arricchirsi enormemente negli ultimi 2 decenni. A seguito delle dichiarazioni del presidente Xi Jimping rispetto alla finalità di “aggiustare i redditi eccessivamente alti” e di “rettificare la loro distribuzione” e promuovere la “prosperità condivisa”, invece che una levata di scudi da parte dei nuovi ricchi come sarebbe successo nella quasi totalità dei Paesi, si sono registrate una serie di corpose donazioni da parte dei nuovi ricchi a beneficio delle casse statali da impiegare nelle politiche reddituali perequative a favore dei meno abbienti. Attento alle sollecitazioni governative Jack Ma, i primi di settembre, ha tempestivamente annunciato una donazione spontanea al fondo perequativo di 15,5 miliardi di $ dando la stura a comportamenti analoghi da parte dei suoi pari gradi.
Conclusioni
Arricchirsi è glorioso, sosteneva Deng Xiaoping all’indomani dell’approvazione delle Riforme a fine 1978. Oggi con Xi Jimping le politiche stanno cambiando e forse non è casuale che il ritorno di centralità del pensiero di Mao, al quale il presidente in carica dichiara di volersi ispirare, venga accompagnato da significativi correttivi alle linee di politica economica: non è certo un ritorno all’egualitarismo dell’economia socialista e collettivista. Tuttavia, le ultime politiche economiche cinesi, tendenti alla prosperità di tutto il popolo, all’equità e alla pace sociale, rappresentano nuovi paradigmi che potrebbero aprire spazi di riflessione anche in Occidente.
Andrea Vento – 9 Ottobre 2021
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE
1 http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/dalla_cina/2019/07/02/in-70-anni-pil-cina-cresciuto-dell81-medio-lanno_816fb340-4d29-4a64-a499-4269d2b13351.html
2 https://www.ilsole24ore.com/art/cina-crescita-mai-cosi-bassa-1990-2019-solo-61percento-AC7hvcCB?refresh_ce=1
3 https://www.ilsole24ore.com/art/cina-crescita-mai-cosi-bassa-1990-2019-solo-61percento-AC7hvcCB
4 https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30800-8/fulltext
5 https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Ocse-Peggiore-crisi-dal-dopoguerra-Pil-Italia-10-5-2020-5-4-2021-9187bd81-ba9a-4e88-bc70-b22accaf0915.html
6 https://www.econopoly.ilsole24ore.com/2021/06/01/reshoring-globalizzazione-pandemia/
7 https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr862_e.htm
8 https://aspeniaonline.it/la-via-cinese-alla-ripresa-post-covid/
9https://www.bancafucino.it/sito-istituzionale/sala-stampa/fucino-social/la-pandemia-ha-accelerato-lavvicinamento-dei-paesi
12 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/notiziario_xinhua/2021/02/25/xi-dichiara-vittoria-totale-cinese-sulla-poverta_7dd927ff-ca18-4ea1-a881-415cf4515f30.html
13 https://www.internazionale.it/reportage/gabriele-battaglia/2020/08/10/cina-poverta
14 https://aspeniaonline.it/articolo_aspenia/quanto-pesa-e-cosa-vuole-la-classe-media-in-cina/
15 http://www.limesonline.com/rubrica/la-cina-inizia-anno-del-cane-con-la-lotta-alla-poverta
16 https://cinainitalia.com/2019/03/12/miliardari-cinesi/
17 https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/lusso/2020/10/21/in-cina-i-miliardari-battono-il-covid-piu-ricchi-che-mai_82f4648e-cfef-4284-9d12-3622f538bac6.html
PERCHE’ IL LABORATORIO DI FORT DETRICK DOVREBBE ESSERE INVESTIGATO PER TRACCIARE LE ORIGINI GLOBALI DI COVID-19
PERCHE’ E’ NECESSARIO INVESTIGARE I LABORATORI USA PER LE ORIGINI GLOBALI DI COVID-19
di Fan Lingzhi, Huang Lanlan, Zhang Hui (dal Global Times)
Fonte Articolo originale in inglese del 28 giugno 2021: https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227219.shtml
La teoria del lab-leak, secondo la quale il COVID-19 sarebbe fuoriuscito da un laboratorio, ha nuovamente suscitato clamore dall’inizio di quest’anno, mesi dopo che l’argomento era stato gettato nel cestino delle teorie della cospirazione da un numero schiacciante di scienziati.
Gli osservatori hanno scoperto che le cose si complicano solo quando l’origine del coronavirus – una questione scientifica già difficile – è impigliata in trucchi di manipolazione politica. Passando al setaccio più di 8.000 notizie relative alla teoria della fuga dal laboratorio, il Global Times ha scoperto che ben il 60% della copertura proveniva dai soli Stati Uniti.
Vale la pena notare che molti media del mondo occidentale guidato dagli Stati Uniti, che hanno pubblicizzato la teoria della fuga dai laboratori, sono disposti a concentrarsi solo sui laboratori cinesi, anche se sono stati accuratamente indagati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), mentre chiudono un occhio sulle istituzioni americane di ricerca biologica più sospette, come il famigerato US Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) a Fort Detrick, Maryland.
L’USAMRIID è stato temporaneamente chiuso nel 2019 dopo un’ispezione del Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Anche se questo misterioso laboratorio ha riportato la ragione della chiusura come “problemi infrastrutturali in corso con la decontaminazione delle acque reflue”, la spiegazione non era abbastanza persuasiva. Il Global Times ha scoperto che il fallimento del laboratorio nel controllare le tossine sembra aver allarmato le istituzioni legate al contrasto delle armi di distruzione di massa negli Stati Uniti.
Ricomparsa della teoria della fuga dal laboratorio
Uno studio congiunto sulle origini del COVID-19 da parte di esperti cinesi e dell’OMS a marzo ha respinto la teoria del complotto “lab-leak”. Più prove indicavano il fatto che il virus era probabilmente passato dai pipistrelli agli esseri umani attraverso un altro animale intermediario, ed era “estremamente improbabile” che fosse trapelato da un laboratorio, diceva il rapporto dello studio.
Ciononostante, la teoria della fuga dal laboratorio non è scomparsa; invece, soprattutto dall’inizio di maggio, è stata ampiamente promossa da alcuni politici e media statunitensi come una “scienza plausibile”. In un articolo pubblicato sul Bulletin of the Atomic Scientists il 5 maggio, senza alcuna prova, lo scrittore scientifico Nicholas Wade ha sostenuto che “i sostenitori della fuga dal laboratorio possono spiegare tutti i fatti disponibili sulla SARS2 considerevolmente più facilmente di quelli che favoriscono l’emergenza naturale.”
Giorni dopo, il Wall Street Journal ha riferito il 23 maggio che tre ricercatori del Wuhan Institute of Virology (WIV) “si sono ammalati abbastanza nel novembre 2019 da richiedere cure ospedaliere”, e avevano “sintomi coerenti sia con il Covid-19 che con le comuni malattie stagionali”. Il rapporto del WSJ ha citato un “rapporto dell’intelligence statunitense precedentemente non divulgato”.
Il 26 maggio, il presidente Biden ha dichiarato di aver ordinato alla comunità di intelligence degli Stati Uniti di “raddoppiare” i suoi sforzi per indagare sulle origini del COVID-19. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha persino affermato il 20 giugno che la Cina dovrà affrontare “l’isolamento nella comunità internazionale” se non collabora con un’ulteriore indagine sull’origine della pandemia COVID-19, ha riportato Bloomberg quel giorno.
La pressione dei politici e dei media sembra aver colpito alcuni autorevoli scienziati medici negli Stati Uniti, tra cui il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) statunitense, Anthony Fauci. L’11 maggio, dopo che Rand Paul, un repubblicano al Senato, ha accusato Fauci di aver aiutato il laboratorio di Wuhan a “creare” il virus, Fauci ha negato con forza l’accusa ma ha detto di essere “pienamente a favore di qualsiasi ulteriore indagine su ciò che è successo in Cina.”
Questo improvviso cambiamento di atteggiamento di alcuni esperti statunitensi è dovuto alla pressione politica che hanno ricevuto, ha detto un virologo cinese al Global Times. “Ai media occidentali piace fare agli esperti domande fuorvianti, come “è (la fuga di notizie del laboratorio) assolutamente impossibile?”” ha detto il virologo che ha chiesto l’anonimato.
È molto difficile per gli esperti rispondere a una domanda del genere, poiché la possibilità, anche se molto piccola, esiste ancora, ha detto il virologo. “Tutto quello che possono dire è “è possibile””, ha detto al Global Times. In realtà, la maggior parte degli esperti di solito aggiunge “ma è altamente improbabile” dopo “è possibile”, ma i media presentano solo la parte che conferma i loro pregiudizi, ha detto.
I grandi dati mostrano che gli Stati Uniti stanno spingendo la narrazione della teoria della fuga di laboratorio COVID-19. Tra gli 8.594 pezzi di notizie relative alla “fuga di laboratorio” che il database GDELT ha raccolto dal 2020, 5.079 erano dagli Stati Uniti, pari al 59 per cento. Dopo gli Stati Uniti c’erano il Regno Unito (611 pezzi) e l’Australia (597 pezzi). Quasi tutta la copertura ha preso di mira il laboratorio WIV.
Mentre gli Stati Uniti si concentrano esclusivamente sui laboratori cinesi, raramente prestano attenzione ai difetti dei propri laboratori nazionali, alcuni dei quali hanno anche innescato incidenti legati ai virus in passato. Secondo un articolo dell’agosto 2020 di ProPublica, una redazione indipendente che produce giornalismo investigativo, l’Università della Carolina del Nord a Chapel Hill ha segnalato 28 incidenti di laboratorio che coinvolgono organismi geneticamente modificati ai funzionari della sicurezza del National Institutes of Health tra gennaio 2015 e giugno 2020. “Sei degli incidenti hanno coinvolto vari tipi di coronavirus creati in laboratorio”, ha detto ProPublica nell’articolo. “Molti sono stati ingegnerizzati per consentire lo studio del virus nei topi”.
Stranamente, pochissimi media mainstream statunitensi hanno sollevato la questione se esiste la possibilità che il COVID-19 sia trapelato dai laboratori statunitensi, ha detto il virologo cinese. “Non osano chiederlo”, ha detto.
In un articolo pubblicato sul blog politico indipendente Moon of Alabama il 27 maggio, l’autore ha sottolineato che l’ipnosi di alcuni occidentali sulla cospirazione della fuga di Wuhan è simile al trucco che gli Stati Uniti hanno giocato per spingere la guerra in Iraq nel 2002 – gli Stati Uniti hanno affermato che “Saddam Hussein avrà presto un’arma nucleare”, che era “un’evidente sciocchezza”, ha detto l’autore.
“La teoria della ‘fuga di laboratorio’ è simile alla rivendicazione delle armi di distruzione di massa – una speculazione senza prove promossa a lungo da un’amministrazione di orientamento neoconservatore che era estremamente ostile al paese ‘colpevole’ in questione”, ha detto l’autore.
La teoria della fuga dal laboratorio, quindi, “non è solo una storia implausibile e senza prove di una fuga dal laboratorio della SARS-CoV-2”, ha notato l’autore. “È una campagna lanciata per dipingere la Cina come un nemico del genere umano”.
Preoccupazioni internazionali sui laboratori biologici statunitensi
Gli Stati Uniti hanno molti laboratori biologici in 25 paesi e regioni in Medio Oriente, Africa, Sud-Est asiatico e negli stati dell’ex Unione Sovietica, con 16 solo in Ucraina. Alcuni di questi laboratori hanno visto epidemie su larga scala di morbillo e altre pericolose malattie infettive, secondo i rapporti dei media.
La comunità internazionale ha spesso espresso preoccupazione per le attività di militarizzazione biologica degli Stati Uniti in altri paesi.
Nell’ottobre 2020, il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmitry Medvedev, ha detto che le attività di ricerca degli Stati Uniti nei laboratori biologici nei membri della Comunità degli Stati indipendenti hanno causato grave preoccupazione. Gli Stati Uniti non solo costruiscono laboratori biologici in questi paesi, ma cercano di farlo anche in altri luoghi del mondo. Tuttavia, la loro ricerca manca di trasparenza e va contro le regole della comunità internazionale e delle organizzazioni internazionali.
Anatoly Tsyganok, membro corrispondente dell’Accademia Russa di Scienze Militari e professore associato della Facoltà di Politica Mondiale all’Università Statale Lomonosov di Mosca, ha detto al Global Times che i test di armi biologiche e batteriologiche sul territorio degli Stati Uniti sono vietati dal Congresso degli Stati Uniti. Ha detto che l’esercito statunitense ha effettuato e sta ancora effettuando test di armi biologiche e batteriologiche in Georgia.
Questo viene fatto con il pretesto di fornire ai malati vari vaccini terapeutici condotti dall’esercito statunitense e da appaltatori privati americani presso il Richard Lugar Center for Public Health Research, ha detto Tsyganok. I test correlati sono stati esposti da vari media.
Nel dicembre 2015, 30 pazienti del centro di ricerca che erano in trattamento per l’epatite C sono morti. Ventiquattro di loro sono morti lo stesso giorno, e la loro causa di morte è stata elencata come “sconosciuta”, secondo Tsyganok e Russia news outlet.
I residenti dei quartieri intorno a questi laboratori lamentano spesso problemi di salute.
La giornalista bulgara Dilyana Gaytandzhieva ha pubblicato una storia sul centro Lugar all’inizio del 2018. Nelle sue interviste per il rapporto, la maggior parte dei residenti che vivevano vicino ai laboratori si lamentavano di mal di testa, nausea e pressione alta. Hanno anche detto che c’era del fumo nero proveniente dal laboratorio.
USA Today ha riferito che dal 2003, centinaia di incidenti che coinvolgono il contatto accidentale con agenti patogeni mortali si sono verificati nei bio-laboratori statunitensi in patria e all’estero. Questo può causare l’infezione dei contatti diretti, che possono poi diffondere il virus nelle comunità e iniziare un’epidemia.
Un membro dell’Accademia Russa delle Scienze, Armais Kamalov ha detto in un’intervista alla TASS all’inizio di giugno che lo sviluppo di virus geneticamente modificati come armi biologiche dovrebbe essere soggetto allo stesso divieto mondiale come il test di armi nucleari. Ha citato i laboratori statunitensi in Georgia e Armenia come riferimento.
“Ci sono molti laboratori, che oggi sono finanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Non è un segreto che sono in Georgia, Armenia e altre repubbliche. È sorprendente che l’accesso a questi laboratori sia off-limits, e non capiamo cosa stiano facendo lì”, ha detto.
Cosa era successo nel luglio 2019?
I terribili record di sicurezza dei laboratori biologici americani nel mondo mostrano una possibilità di fuga di un virus da un laboratorio americano. Molti indicano la chiusura del laboratorio di Fort Detrick nel luglio 2019.
Nel luglio 2019, sei mesi prima che gli Stati Uniti riportassero il primo caso COVID-19, il laboratorio dell’esercito a Fort Detrick che studia materiale infettivo mortale come Ebola e vaiolo è stato chiuso dopo che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emesso un ordine di cessazione. I funzionari del CDC hanno rifiutato di rilasciare ulteriori informazioni dopo aver citato “ragioni di sicurezza nazionale”.
L’USAMRIID di Fort Detrick ha detto nell’agosto 2019 che lo spegnimento era perché il centro non aveva “sistemi sufficienti in atto per decontaminare le acque reflue” dai suoi laboratori di massima sicurezza, ha riportato il New York Times.
Cosa è successo esattamente a Fort Detrick nell’estate del 2019? Alcuni media statunitensi si sono rivolti in precedenza al CDC per ottenere risposte, ma molti contenuti chiave nel rapporto erano stati redatti.
All’inizio di giugno, un utente di Twitter con sede in Virginia ha ottenuto i documenti del CDC sull’ispezione di Fort Detrick sotto il Freedom of Information Act (FOIA). Global Times ha scoperto che la maggior parte dei documenti erano e-mail tra i funzionari del CDC in vari dipartimenti e USAMRIID dal 2018 al 2019. Anche se alcune delle e-mail sono state coperte da una stazione televisiva affiliata alla ABC a Washington, il rapporto non ha catturato molta attenzione.
Le e-mail hanno rivelato diverse violazioni al laboratorio di Fort Detrick durante le ispezioni del CDC nel 2019. Quattro delle quali sono state etichettate come violazioni gravi.
Una di queste gravi violazioni, ha detto il CDC, era un ispettore che è entrato più volte in una stanza senza la protezione respiratoria richiesta mentre altre persone in quella stanza stavano eseguendo procedure con un primate non umano su un tavolo da necroscopia.
Questa deviazione dalle procedure di entità ha portato a un’esposizione respiratoria professionale ad aerosol di agenti selezionati, ha detto il CDC.
In un’altra grave violazione, il CDC ha detto che l’USAMRIID aveva “sistematicamente fallito nel garantire l’attuazione di procedure di biosicurezza e contenimento commisurate ai rischi associati al lavoro con agenti selezionati e tossine”.
Altre violazioni includono la mancanza di una corretta gestione dei rifiuti, dove i rifiuti non sono stati trasportati in un contenitore durevole a prova di perdite, che crea il potenziale per fuoriuscite o perdite.
I documenti del CDC mostrano che ha inviato una lettera di preoccupazione a USAMRIID, che ha portato a una chiusura temporanea del laboratorio di Fort Detrick nel 2019.
In una e-mail del 12 luglio 2019, il CDC ha detto che l’USAMRIID ha segnalato due violazioni del contenimento il 1 luglio e l’11 luglio 2019, e questo ha dimostrato un “fallimento di USAMRIID nell’implementare e mantenere procedure di contenimento sufficienti a contenere agenti selezionati o tossine generate da operazioni di laboratorio BSL-3 e BSL-4.”
“Con effetto immediato, USAMRIID deve cessare tutti i lavori che coinvolgono agenti selezionati e tossine nelle aree di laboratorio registrate fino a quando l’indagine sulle cause principali non è stata condotta per ogni incidente e i risultati sono stati presentati al FSAP per la revisione”, ha detto il CDC.
Il FSAP (Federal Select Agent Program) è composto congiuntamente dalla divisione dei Centers for Disease Control and Prevention di agenti e tossine selezionati e dalla divisione di agenti e tossine selezionati agricoli dell’Animal and Plant Health Inspection Service. Il programma supervisiona il possesso, l’uso e il trasferimento di agenti biologici selezionati e tossine, che hanno il potenziale di causare una grave minaccia alla salute pubblica, animale o vegetale o ai prodotti animali o vegetali. Esempi comuni di agenti e tossine selezionati includono gli organismi che causano antrace, vaiolo e peste bubbonica.
Tre giorni dopo, il Fort Detrick ha risposto all’e-mail dicendo che aveva presentato messaggi in risposta all’azione immediata, ma i messaggi sono stati deliberatamente oscurati.
Il messaggio è stato presentato da un direttore di Studi Strategici (Contro le armi di distruzione di massa) presso l’USAMRIID, il cui nome è stato anch’esso cancellato.
La dichiarazione pubblica di Fort Detrick rilasciata nell’agosto 2019 diceva che l’arresto era dovuto a problemi di decontaminazione delle acque reflue. Ma non è chiaro se la dichiarazione fosse coerente con i risultati dell’ispezione del CDC.
La gestione di tali laboratori di alto livello in generale deve essere molto rigorosa con ispezioni regolari. Diversi sistemi dovrebbero essere in grado di garantire che nessun rischio potenziale possa verificarsi, e il fallimento delle attrezzature e le perdite di acque reflue certamente non dovrebbero verificarsi, ha detto al Global Times uno scienziato cinese del team di tracciamento delle origini del virus OMS-Cina che ha richiesto l’anonimato.
I problemi delle acque reflue hanno rivelato grandi lacune nella gestione del laboratorio di Fort Detrick, e c’è da chiedersi cos’altro è trapelato con le acque reflue mal gestite.
“Alcuni agenti patogeni altamente patogeni nel laboratorio sono stati probabilmente rilasciati. E l’esercito americano non ha mai detto al pubblico quello che stava facendo”, ha detto lo scienziato.
È molto probabile che i ricercatori di Fort Detrick possano essere stati infettati accidentalmente ma non hanno mostrato sintomi evidenti. In questo modo potrebbero aver portato il virus al mondo esterno, ha detto lo scienziato.
“In assenza di sintomi evidenti, 9 dei 10 individui potrebbero non aver saputo di essere stati infettati ed è possibile che più del 90% delle vie di trasmissione fossero state perse quando il virus è stato finalmente rilevato. Questo è anche il motivo per cui il tracciamento delle origini del virus è difficile da condurre”, ha detto, notando che solo l’indagine sierologica su larga scala potrebbe trovare alcune delle prime infezioni.
Perché non aprire il laboratorio di Fort Detrick
Diversi virologi e analisti intervistati dal Global Times hanno esortato il laboratorio di Fort Detrick ad aprire le sue porte per un’indagine internazionale, poiché esperti internazionali hanno già visitato l’Istituto di virologia di Wuhan.
Molti politici e media occidentali hanno dato la colpa della pandemia a Wuhan, dicendo che Wuhan è stato il luogo in cui il virus è stato rilevato per la prima volta e da dove il virus è venuto, nonostante le prove crescenti che non è il caso.
In un recente esempio a giugno, uno studio di ricerca gestito dal National Institutes of Health’s All of Us Research Program ha trovato prove di infezioni da COVID-19 negli Stati Uniti già nel dicembre 2019, settimane prima della prima infezione documentata nel paese.
Wuhan ha registrato i primi sintomi di COVID-19 da un paziente l’8 dicembre 2019.
Quando gli è stato chiesto di fornire maggiori dettagli sullo studio, una persona dei media con il programma di ricerca All of Us ha detto al Global Times che il programma “non ha nulla da aggiungere” dalle informazioni che aveva già rilasciato.
Per quanto riguarda il motivo per cui il virus è stato rilevato per la prima volta a Wuhan, lo scienziato anonimo ha detto che il virus è difficile da rilevare in una fase iniziale, soprattutto in autunno e in inverno con più casi di raffreddore. E non avrebbe attirato l’attenzione finché un gran numero di persone non fosse stato infettato. Questo è quello che è successo nella densamente popolata Wuhan, ha detto lo scienziato.
Il sistema sanitario pubblico cinese è molto sensibile soprattutto dopo l’epidemia di SARS nel 2003, ma questo non è sempre il caso all’estero, soprattutto quando la densità della popolazione è bassa e il virus non si diffonde così velocemente, ha detto l’esperto.
“Il nuovo coronavirus è stato scoperto da tre società cinesi nello stesso momento. È molto semplice rilevare queste cose, e la Cina ha un sacco di tali aziende terze con una forte capacità di rilevamento medico”, ha detto.
Senza tornare ai campioni di siero precedenti altrove ora, sarà difficile trovare la fonte del virus. Gli studi retrospettivi che sono stati fatti in Cina non hanno trovato alcuna prova. È importante che il mondo lavori insieme ora per ordinare le prove e fare le prime indagini sierologiche dove necessario, ha detto.
Zeng Guang, ex capo epidemiologo del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha detto al Global Times che la fuga dal laboratorio è facile da identificare, poiché le infezioni sono destinate a mostrare segni, sia che si tratti di un problema operativo o di un’infezione del personale di laboratorio.
Gli esperti dell’OMS hanno valutato l’ipotesi della fuga dal laboratorio quando hanno visitato Wuhan e non hanno trovato prove, e la speculazione sulla sua possibilità in un laboratorio di Wuhan dovrebbe essere già finita. Nel frattempo, dovremmo mettere un punto interrogativo su altre ipotesi, come altri laboratori nel mondo, ha detto Zeng.
Zeng ha detto che gli Stati Uniti hanno paura dell’ispezione dell’OMS nello stesso modo in cui è stata fatta in Cina, ha detto Zeng.
Gli Stati Uniti, l’unico paese che ostacola la creazione di un meccanismo di verifica della Convenzione sulle armi biologiche (BWC), ha problemi sistematici, ha detto Zeng, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno paura che l’indagine sui suoi laboratori porterebbe a scavare più del suo sporco.
Xia Wenxin ha contribuito a questo articolo
(Traduzione automatica effettuata con Deep-Translator)
Articolo originale in inglese:
https://www.globaltimes.cn/page/202106/1227219.shtml
Trump, Fort Detrick e il Covid 19: Il colpevole silenzio degli Stati Uniti sulla vera origine del coronavirus
di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli
Tutta una serie di variegate informazioni e di fatti concreti, combinati strettamente tra loro a partire da alcune clamorose anomalie, provano e attestano oltre ogni dubbio che:
1. Il coronavirus ha iniziato a contagiare e devastare il mondo trovando il suo luogo di origine e di propagazione nella base militare e nel laboratorio batteriologico di Fort Detrick, collocato nello stato del Maryland degli Stati Uniti, fin dal luglio del 2019 e quindi più di tre mesi in anticipo rispetto ai casi riportati a Wuhan e in Cina;
2. Il governo Trump, gli apparati statali americani e l’amministrazione Biden in carica dal gennaio del 2021, hanno via via cercato, coscientemente e costantemente, di coprire e nascondere tale gravissimo evento di contaminazione durante il periodo compreso tra il luglio del 2019 e il presente, ossia per due lunghi e sanguinosi anni: una menzogna permanente e perfettamente consapevole di Washington che ha direttamente causato e prodotto il dilagare della paurosa strage di più di tre milioni di esseri umani, insanguinando dall’estate del 2019 quasi tutto il nostro pianeta e provocando circa 600.000 vittime innocenti nella stessa America.
Fin dal 1943 e senza soluzione di continuità uno dei principali siti militari statunitensi per la guerra batteriologica, Fort Detrick, registrò al suo interno una prima e innegabile “fuga” verso il mondo esterno del batterio che causa l’antrace (una gravissima infezione, con sintomi molto simili a quelli creati dalla polmonite) già il 18 settembre 2001, ossia solo una settimana dopo gli attentati dell’11 settembre.1
Dopo questo pessimo precedente, è sicuro e attestato senza ombra di dubbio persino da un articolo dell’insospettabile NewYorkTimesdel 5 agosto 2019 che durante la seconda metà di luglio del 2019 l’attività di ricerca batteriologica di Fort Detrick venne chiusa: quest’ultima serrò dunque i battenti nel luglio del 2019 in modo improvviso, rimanendo non operativa per molti mesi e riavviando completamente la sua attività solo a fine marzo 2020.2
Al di là delle spiegazioni ufficiali del Pentagono rispetto a tale prolungata serrata, relative a un problema delle acque reflue, si registra dunque un’anomalia made in USA, allo stesso tempo clamorosa e incontrovertibile, fuori discussione e inattaccabile: ma qual era la vera ragione della singolare, eclatante e improvvisa chiusura delle ricerche batteriologiche a Fort Detrick?
Un’embrionale risposta venne fornita quasi subito da un lucido articolo dell’insospettabile e anticomunista quotidiano inglese Indipendent, il quale già il 6 agosto del 2019 notò che
«al principale laboratorio di guerra batteriologica dell‘America era allora stato ordinato di interrompere tutte le ricerche sui più letali virus e agenti patogeni per il timore che le scorie tossiche potessero uscire dalla struttura. Sin dall’inizio della Guerra Fredda, Fort Detrick in Maryland è stato l’epicentro della ricerca di armi batteriologiche dell’Esercito USA. Il mese scorso [ossia il luglio 2019, ndr] il Centro per il Controllo e la Prevenzione di malattie (l’organismo governativo di salute pubblica) ha privato il laboratorio della sua licenza per gestire “agenti patogeni selezionati” altamente riservati che includono ebola, vaiolo e antrace. L’inusuale mossa è seguita ad una ispezione del CDC a Fort Detrick che ha scoperto gravi problemi nelle nuove procedure utilizzate per decontaminare gli scarti liquidi. Per anni la struttura ha fatto uso di un impianto di sterilizzazione a vapore per trattare l’acqua contaminata, ma lo scorso anno, in seguito a una tempesta che ha allagato e distrutto il macchinario, Fort Detrick ha iniziato a utilizzare un sistema chimico di decontaminazione. Nonostante ciò, gli ispettori del CDC hanno trovato che le nuove procedure non erano sufficienti e che entrambi i guasti meccanici fossero causa di perdite e che i ricercatori avrebbero fallito a seguire propriamente il regolamento. Come risultato l’organizzazione ha mandato un provvedimento di sospensione ordinando a Fort Detrick di sospendere tutte le ricerche sugli agenti selezionati».3
Il mistero della sostanziale chiusura della base di Fort Detrick è stato in ogni caso risolto in modo indiscutibile da una seconda e sicura anomalia, sempre avvenuta in terra statunitense e verificatasi guarda caso a ridosso della serrata estiva della base militare del Maryland: ossia la “misteriosa” epidemia di polmonite acuta che colpì gli Stati Uniti, a partire proprio dal luglio del 2019. Su Internet si poteva tranquillamente leggere, fin dall’inizio di settembre del 2019, pertanto almeno due mesi prima dei primordi dell’epidemia di coronavirus a Wuhan e in Cina, tutta una serie di articoli e notizie eclatanti come quelle che seguono e che riguardavano proprio l’America:
«Da quest’estate [del 2019, ndr] oltre 200 persone, perlopiù giovani, sono finite in ospedale in queste condizioni. Agli esami i polmoni appaiono come colpiti da un‘infezione molto aggressiva di cui i dottori non conoscono la causa. Gli Stati Uniti registrano altre due vittime (il totale sale così a tre) di una ancora misteriosa patologia polmonare legata allo svapo. Il secondo decesso – riferisce il New York Times – è avvenuto a luglio, un mese prima della persona che ha perso la vita in Illinois per lo stesso problema. Ma solo giovedì Ann Thomas, funzionario per la sanità dell‘Oregon e pediatra, ha reso nota la notizia. Thomas non ha voluto rivelare né il nome, né l‘età e il sesso della vittima, ma ha assicurato che la morte è stata causata dalla crisi respiratoria innescata dalla patologia legata allo svapo. “Appena arrivata in ospedale, la persona è stata ricoverata e attaccata al respiratore”. Dopo qualche settimana, i dottori hanno costatato che l‘infezione polmonare era arrivata a livelli irreversibili. La vittima aveva acquistato un prodotto per le sigarette elettroniche in un marjuana shop. Il terzo decesso è stato confermato in data 5 settembre dai funzionari sanitari dell’Indiana. Si tratta di “una persona di età superiore ai 18 anni”, ha dichiarato il Dipartimento della Salute dello Stato in una nota. Nello Stato, in particolare, sono in esame 30 casi di gravi lesioni polmonari legate allo svapo [l’inalazione tramite sigarette elettroniche, ndr]. Da quest’estate oltre 200 persone, perlopiù giovani, sono finite in ospedale in queste condizioni. Tutti sono svapatori. Vengono ricoverati per fiato corto, crisi respiratoria, diarrea, vertigini, vomito. Agli esami tomografici i polmoni appaiono come colpiti da un‘infezione molto aggressiva di cui i dottori non conoscono la causa».4
Dopo aver notato di sfuggita come agli inizi di settembre del 2019 proprio il Maryland, ossia lo stato federale nel quale è collocato Fort Detrick, stesse valutando se prendere delle misure per frenare l’uso delle peraltro inoffensive (in assenza di Covid-19) sigarette elettroniche, ritenute allora la causa della misteriosa “polmonite” iniziata negli USA nell’estate del 2019, va sottolineato che i sintomi della suddetta epidemia che colpì allora l’America, in concomitanza con la quasi simultanea chiusura della “biologica” Fort Detrick, furono identici alla malattia che in seguito venne identificata, e non certo da Washington, come coronavirus: del resto lo stesso Robert Redfield, in qualità di direttore del centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie, in seguito e all’inizio del 2020 ammise parzialmente che alcuni casi di Covid-19 si erano verificati all’interno degli Stati Uniti già nel corso del 2019, ma vennero diagnosticati come “influenza”, come riferì anche il giornale TheGuardian.5
Dopo la chiusura di Fort Detrick a fine luglio del 2019 e l’epidemia misteriosa di “polmonite” nella stessa estate, emerse comunque una terza singolarità in terra statunitense sempre in quel periodo: infatti le autorità governative e sanitarie del paese per alcuni mesi attribuirono, in modo illogico, le morti per le strane polmoniti che si stavano verificando negli Stati Uniti nell’estate del 2019 all’innocuo e ormai decennale consumo di sigarette elettroniche (innocuo, ovviamente, in assenza di coronavirus), creando una colossale e governativa fake news. Si trattò di un’assurdità incredibile visto che per dodici anni, dal lontano 2007, le sigarette elettroniche erano state utilizzate su larga scala da milioni e milioni di cittadini degli Stati Uniti: durante i lunghi mesi che separano il 2007 dal luglio del 2019 tale consumo non ha creato alcun problema sanitario serio, né soprattutto polmoniti gravi, mentre risultava chiaro che il presunto effetto nocivo delle sigarette elettroniche era, in modo incredibile, limitato e circoscritto solo agli USA e non coinvolgeva in alcun modo il resto del mondo, dove pure il fumo elettrico era diffuso da un decennio. Fin dal settembre del 2019 alcuni studi medici hanno mano a mano dimostrato l’assenza di qualunque collegamento diretto tra “svapare”, cioè inalare da sigarette elettroniche, e le “polmoniti” del 2019: ma se il governo Trump e le autorità statunitensi non parlarono in alcun modo di quello che era successo a Fort Detrick, viceversa esse fino all’ottobre 2019 lasciarono tranquillamente che per alcuni mesi si propagassero le false informazioni sull’inesistente legame tra la nuova e “misteriosa” (misteriosa, ma non certo a Fort Detrick) malattia polmonare e le sigarette elettroniche.6
Siamo in presenza di fatti eclatanti e innegabili, che a questo punto vanno collegati con un’ennesima anomalia avente per oggetto questa volta il mistero dei giochi militari di Wuhan: a tal proposito l’insospettabile, filoamericano e anticomunista quotidiano Il Messaggero ha pubblicato nel 2020 un articolo intitolato Primi casiai giochimondialimilitari diWuhan2019:
«Vuoi vedere che il coronavirus era nell‟aria di Wuhan già in ottobre, un mese in anticipo rispetto al primo caso ufficiale riscontrato sul suolo cinese e datato 17 novembre? Verso questa possibile conclusione potrebbero condurre alcune testimonianze di atleti recatasi nella località cinese, per prendere parte ai Giochi Mondiali militari, i quali sia in Cina sia al ritorno in patria hanno manifestato i sintomi di quella malattia, che alcuni mesi dopo, avrebbe scombussolato il mondo intero. Alla rassegna degli sportivi in divisa, celebratasi nel capoluogo della provincia di Hubei dal 18 al 27 ottobre, hanno preso parte 10mila atleti provenienti da un centinaio di paesi. Tra di loro c‘erano anche due pentatleti francesi, Valentin Belaud e Elodie Clouvel, che al quotidiano l‟Equipe, hanno raccontato di essersi ammalati ed essere stati costretti a saltare gli allenamenti in Cina, accusando problemi mai avuti in precedenza. In più la coppia, nel momento in cui ha comunicato il problema allo staff medico, ha appreso che anche altri membri della delegazione transalpina si erano ammalati. Pure sul fronte italiano, i racconti degli azzurri presenti in Cina condurrebbero alla stessa conclusione. Tra gli altri lo spadista Matteo Tagliariol, olimpionico a Pechino 2008, che a Wuhan ha gareggiato nella prova a squadre insieme a Paolo Pizzo e Lorenzo Buzzi, ha ricordato di essere stato malato per diversi giorni, soffrendo soprattutto di una fastidiosissima tosse, e che nel centro medico del villaggio le aspirine erano esaurite, a causa dell‘elevato numero di malati. Poi al rientro in Italia, il 37enne Tagliariol ha avuto la febbre e dopo la sua guarigione si sono ammalati pure la compagna, la fiorettista Martina Batini, e il figlio di due anni. “Ai mondiali militari di Wuhan ci siamo ammalati tutti, 6 su 6 nell’appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni. Tanto che al presidio medico avevano quasi finito le scorte di medicine”, ha detto Tagliariol».7
Sappiamo con assoluta certezza che i giochi militari mondiali di Wuhan, collegati ovviamente con l’arrivo in Cina di migliaia di militari occidentali e di centinaia di atleti USA, non avvennero nel giugno 2019, ma a partire dal 18 ottobre 2019: dunque a tre mesi di distanza e circa cento giorni dopo i primi casi negli Stati Uniti, verificatisi a partire dal luglio 2019, e tra l’altro sessanta giorni dopo i primi casi di coronavirus a Milano e in Lombardia. Vista la presenza innegabile del Covid-19 negli USA già durante l’estate del 2019, quindi, furono gli atleti statunitensi a esportare involontariamente il coronavirus in Cina a Wuhan, non il contrario, senza comunque che il governo degli Stati Uniti avvertisse in alcun modo le autorità cinesi dell’epidemia di “polmonite” in corso nella nazione americana. Di fronte a questo quadro risulta perfettamente chiaro perché i ricercatori dell’autorevole Organizzazione Mondiale della Sanità, un ente dell’ONU, al termine di una serie di ispezioni effettuate all’inizio del 2021 a Wuhan, abbiano definito chiaramente e senza mezzi termini “altamente improbabile” che il coronavirus sia fuoriuscito dal laboratorio di ricerche di Wuhan.8
La quinta anomalia ha per oggetto la particolare, inquietante e maligna “simulazione di scenario” pubblicato nell’ottobre del 2019 dal John Hopkins Center for Health Security assieme ad altre due organizzazioni statunitensi, relativa allo scoppio di una pandemia di “coronavirus immaginario”, originatasi in un ipotetico allevamento di maiali del Brasile: una simulazione a tavolino che stranamente si stava già trasformando in realtà, in terra statunitense.
«Eric Toner è uno scienziato americano del John Hopkins Center for Health Security, e a ottobre scorso aveva simulato una pandemia di coronavirus. Tre mesi fa, infatti, il centro di ricerca di New York ha condotto un esperimento insieme al World Economic Forum e la Bill and Melinda Gates Foundation, per dimostrare l‘importanza della partnership tra istituzioni pubbliche e enti privati nel far fronte a pandemie globali. Lo studio ha simulato una pandemia di coronavirus immaginario originato negli allevamenti di suini del Brasile e un‘espansione in quasi tutti i Paesi del mondo nell‘arco di 6 mesi. Secondo l‘impressionante simulazione, nell‘arco di 18 mesi 65 milioni di persone sarebbero morte. Come ha precisato il John Hopkins Center, l‘esperimento e i risultati relativi al numero di vittime non corrispondevano in nessun modo a previsione, ma a una semplice simulazione».9
Questa “semplice simulazione” venne pubblicata guarda caso nell’ottobre del 2019: ossia proprio dopo che negli USA era stata chiusa da circa tre mesi la base militare di Fort Detrick, dopo lo scoppio dell’epidemia di polmoniti e dopo l’allarme per il presunto effetto nocivo delle innocue sigarette elettroniche in terra americana. Un’ultima anomalia, che rafforza ancora di più la “teoria Fort Detrick”, ha per oggetto invece l’enorme numero di vittime purtroppo avvenute sempre negli Stati Uniti a causa dell‘“influenza” che colpì il paese dal novembre 2019 (quando a Wuhan stavano iniziando solo i primi sporadici casi…) fino al febbraio 2020, determinando la cifra impressionante di quasi ventimila morti.
Non a caso già nel febbraio 2020, in modo responsabile e onesto,
«il Prof. Edward Livingston ed i suoi colleghi, in questa infografica pubblicata il 26 Febbraio su JAMA, sottolineano come, sebbene vi sia una grande attenzione all‟epidemia della malattia di coronavirus 2019 (COVID-19), tuttavia questa condizione costituisce un problema rilevante in un‟area della Cina e sembra avere ramificazioni cliniche limitate al di fuori di quella regione. Sta di fatto che gli Stati Uniti stanno vivendo una grave stagione influenzale che ha già provocato più di 16.000 morti. L‘infografica pubblicata su JAMA mette a confronto i tassi di incidenza e mortalità per le 2 malattie virali delle vie respiratorie. Nel periodo sino al 24 Febbraio 2020, negli Stati Uniti, relativamente al COVID- 19, sono stati registrati 14 casi diagnosticati dal sistema sanitario statunitense, 39 casi tra i cittadini statunitensi rimpatriati. Non sono stati segnalati morti, né pazienti critici e non ci sono evidenze di trasmissione, negli Stati Uniti, in una ampia comunità. Analizzando parallelamente i dati sull‘influenza, negli Stati Uniti, al 15 Febbraio 2020, i CDC stimano che si siano ammalate almeno 29 milioni di persone, che siano state effettuate almeno 13 milioni di visite mediche, almeno 280.000 ospedalizzazioni e che i morti siano stati almeno 16.000, da sottolineare le 105 morti pediatriche correlate all‘influenza. Pertanto gli Autori ritengono che, sulla base di questi dati, da un punto di vista della sanità pubblica le persone dovrebbero focalizzare la loro attenzione sull‘influenza ed adottare le misure preventive che includono, nel caso dell‘influenza, anche la possibilità del vaccino, oltre a quelle più volte ricordate per tutti i virus respiratori».10
Ma non si trattava certo solo di “influenza”, come ha dimostrato la prima “pistola fumante” in questo particolare intrigo e giallo di portata planetaria: si tratta della scrupolosa attività dell’insospettabile Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha attestato e dimostrato nell’ottobre del 2020 come il coronavirus fosse senza alcun dubbio presente in Lombardia e alcune altre regioni di Italia fin dal settembre del 2019, ossia almeno due mesi prima dell’inizio dell’epidemia a Wuhan e in Cina.
«Il virus SarsCov2 circolava in Italia già a settembre 2019, dunque ben prima di quanto si è pensato finora. La conferma arriva da uno studio dell’Istituto dei tumori di Milano e dell’università di Siena, che ha come primo firmatario il direttore scientifico Giovanni Apolone, pubblicato sulla rivista Tumori Journal. Analizzando i campioni di 959 persone, tutte asintomatiche, che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020, l’11,6% (111 su 959) di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia».11
Si tratta di una notizia clamorosa, oltre che indiscutibile e sicura: essa dimostra che l’allora “misteriosa” epidemia polmonare, sviluppatasi negli Stati Uniti dal luglio del 2019, si era estesa sicuramente dall’America all’Italia trasferendosi di luogo e nazione all’interno del mondo occidentale, e non certo in quello asiatico…
A questo punto va fatta emergere una seconda superprova: uno studio accurato dell’insospettabile ente statunitense denominato “Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie” (CDC), pubblicato purtroppo molto in ritardo (solo alla fine del 2020), ha rilevato come ben 39 campioni di sangue, presi tra il 13 e il 16 dicembre del 2019 in California, Oregon e Washington, fossero risultati positivi agli anticorpi del coronavirus: dimostrando quindi in modo indiscutibile che la quarantina di persone coinvolte era stata infettata dal Covid-19 già nelle settimane precedenti allo scoppio su vasta scala dell’epidemia di Wuhan.12
Si può inoltre congiungere tale elemento indiscutibile a una terza e formidabile superprova, che fa luce definitivamente sul caso in oggetto. Infatti ormai è sicura l’identità del “paziente zero”, anzi dei numerosi pazienti zero del Covid di natura civile: gli sfortunati pensionati di una casa di riposo di Green Spring, in Virginia e nella contea di Fairfax, collocata per loro sfortuna vicino a Fort Belvoir, un ospedale destinato ai militari statunitensi che assiste anche i ricoverandi in arrivo da Fort Detrick.13
La sera dell’11 luglio del 2019, infatti, più di tre mesi prima dei giochi militari di Wuhan, l’insospettabile e anticomunista rete televisiva “ABC” raccontò che in quei giorni, almeno quattro mesi prima dei casi iniziali a Wuhan,
«“[…] una malattia mortale in Virginia ha portato due morti e dozzine di residenti infettati di una malattia respiratoria qui nella comunità di pensionamento di Green Spring. Negli ultimi 11 giorni, 54 persone si sono ammalate con sintomi che vanno da una brutta tosse alla polmonite, senza indizi chiave su come sia scoppiata la malattia improvvisa”. Passano due giorni e la strana epidemia compare anche in un‟altra casa di riposo li vicino. È sempre il tg [statunitense dell’ABC, ndr] a raccontarlo: “Un misterioso virus respiratorio ha colpito una seconda casa di riposo nella contea di Fairfax”. L‟unica cosa chiara al momento è che, due giorni dopo la seconda epidemia a poche decine di miglia di distanza, con un ordine del Cdc, il laboratorio di sicurezza biologica livello 4 di Usamriid, a Fort Detrick nel Maryland, viene chiuso per un incidente di biocontenimento. È sempre il tg a raccontare le paure degli abitanti di quella zona: “Gli abitanti che vivono vicino a Fort Detrick vogliono sapere perché il laboratorio top di Army Germ, uno dei più noti, è stato chiuso così velocemente”».
Era ed è tuttora un’ottima domanda, un eccellente interrogativo.
«A Fort Detrick infatti gli scienziati Usa gestiscono alcuni degli agenti biologici più sensibili e conducono ricerche mediche all‘interno di esso. Ricerche anche su cellule virali molto pericolose, come Ebola e Antrace. […] E allora non possiamo che porci una domanda: c‘è forse una correlazione tra la fuga di biocontenimento di Fort Detrick e le epidemie anomale dentro le due case di riposo di Green Spring? È sufficiente osservare la mappa per vedere che vicinissima alle due case di riposo c‘è Fort Belvoir, un ospedale per i militari che tra gli altri assiste anche quelli di Fort Detrick. Ma come sarebbe arrivato il contagio da Fort Belvoir alle due case di riposo? Il fatto è che proprio questo ospedale assiste anche i veterani di guerra delle forze armate americane, che vivono anche dentro le due case di riposo. Vi mostriamo alcune immagini, nelle quali si vedono i marines festeggiare nella casa di riposo di Burke i numerosi veterani della seconda guerra mondiale per l‘anniversario di fondazione del loro corpo. Può dunque esistere un filo che lega l‘incidente di biocontenimento di Fort Detrick, l‘ospedale militare di Fort Belvoir e le case di riposo in cui si manifesta l‘anomala epidemia di luglio?»14
Tra l’altro proprio il sito della contea virginiana di Fairfax, in data 26 luglio 2019, sottolineò che ben 63 residenti della casa di riposo di Green Spring erano stati sottoposti in loco a «numerosiesami», ma anche dopo di essi «nessun specifico agente patogeno era stato identificato come causadell‟epidemia».15 Se si considerano le altre due “pistole fumanti” e le sopracitate anomalie (le “pericolosissime” sigarette elettroniche made in USA, ecc.), il “filo” che lega Fort Detrick e il Covid è indiscutibile.
Tiriamo le conclusioni.
Tutti i fatti riportati escludono, in modo sicuro e categorico, che l’epidemia di coronavirus si sia sviluppata a partire dalla Cina e da Wuhan, dalla fine di ottobre del 2019; essa invece era virulenta e attiva in Virginia e negli Stati Uniti fin dal luglio del 2019, quindi almeno tre mesi prima dell’inizio della pandemia in Cina.
Come andarono realmente le cose, per la genesi della tragedia del Covid?
Fase uno: verso la fine di giugno del 2019 e a Fort Detrick, si verifica una contaminazione di personale militare statunitense attraverso il coronavirus contenuto nei laboratori della base.
Fase due: una parte del personale infettato viene portato all’ospedale militare di Fort Belvoir, in Virginia.
Fase tre: attorno al 4 luglio 2019, festa nazionale degli USA, involontariamente alcuni marines di Fort Belvoir contagiati dal Covid-19 portano e distribuiscono a piene mani la malattia nella casa di riposo di Green Spring, oltre che in giro per il Maryland e la Virginia.
Fase quattro: dopo un’incubazione di una settimana, scoppia purtroppo una prima epidemia nella casa di riposo di Green Spring con i suoi 263 residenti: due muoiono, i primi caduti dei futuri tre milioni di morti per la pandemia di coronavirus, mentre il Covid-19 raggiunge con la sua marcia mortale un’altra casa di riposo vicino a Green Spring.
Fase cinque: dopo alcuni giorni il Pentagono inizia a preoccuparsi, ordinando la chiusura di tutte le attività di ricerca batteriologica a Fort Detrick, a metà luglio.
Fase sei: dalla metà di luglio all’inizio di ottobre del 2019 l’epidemia via via si espande sia negli Stati Uniti che all’estero, arrivando sicuramente a Milano e in Lombardia all’inizio di settembre del 2019, come provato dall’Istituto dei Tumori di Milano.
Fase sette: le olimpiadi militari mondiali di Wuhan. A tal proposito l’insospettabile e anticomunista sito intitolato Le Iene ha riportato che
«le autorità cinesi hanno più volte sostenuto che l‘epidemia sarebbe arrivata a Wuhan con i militari dell‘esercito americano che partecipavano alle gare del “World Military Games 2019”, in programma dal 12 al 28 ottobre. Noi ovviamente non lo sappiamo, ma dal periodico delle forze armate americane scopriamo che alcuni militari di Fort Belvoir hanno partecipato a quei Giochi. Tra questi il sergente di prima classe Maatje Benassi e il capitano dell’esercito Justine Stremick, che serve come medico di medicina di emergenza dell’esercito a Fort Belvoir in Virginia. Quindi almeno due atleti dell‟ospedale militare situato vicino alle case di riposo dove c‟è stata l‟epidemia sospetta di luglio sarebbero andati a Wuhan per le olimpiadi di ottobre 2019».16
La “fase otto”, che seguì l’inizio di novembre del 2019 e che arriva fino a oggi, risulta purtroppo fin troppo ben conosciuta a livello mondiale…
Le conseguenze della tesi in oggetto dimostrata da numerosi fatti testardi sono fin troppo chiare. Chiediamo innanzitutto all’Organizzazione Mondiale della Sanità, ente dell’ONU che del resto ha già effettuato un’ispezione accurata a Wuhan in Cina verso l’inizio del 2021, di compiere celermente un’analoga e altrettanto approfondita inchiesta anche rispetto a Fort Detrick, all’ospedale militare di Fort Belvoir e alla casa di riposo di Green Spring in Virginia, al fine di far luce finalmente sulla reale origine dell’epidemia di coronavirus a partire dall’estate del 2019. Al mondo serve verità, non menzogne a stelle e strisce.
Può sembrare strano ma anche la precedente e famigerata epidemia di “spagnola”, una gravissima forma di influenza che uccise come minimo cinquanta milioni di persone tra il 1918 e il 1920, non nacque e non si sviluppò certo in Spagna, ma viceversa negli Stati Uniti e in Kansas all’inizio del 1918. Non solo: la cosiddetta epidemia “spagnola” inizialmente venne alla luce e si propagò da una base militare statunitense, anche se quella volta non si trattò di Fort Detrick bensì di Fort Reiley, collocato per l’appunto nel Kansas. Anche in quel caso le menzogne furono molte.
È stato notato, in modo lucido e veritiero, che «ogni epidemia ha la sua infodemia, un alone tossico di panzane e disinformazione. Sentite cosa scriveva il quotidiano americano The Washington Times il 6 ottobre 1918: “Anzitutto bisogna dire che il termine ‘influenza spagnola’ è chiaramente un errore, e che il nome dovrebbe essere ‘influenza tedesca’, perché l‘indagine prova che la malattia ha avuto inizio nelle trincee germaniche. Dopodiché ha compiuto un giro dell‘intero mondo civilizzato, nel corso del quale è esplosa con particolare virulenza in Spagna, a causa di certe condizioni locali”. Sono i giorni di picco dell‘infezione che farà 50, forse 100 milioni di morti in tutto il mondo, un numero cinque o dieci volte superiore alle vittime della Grande Guerra che sta per finire, e l‘anonimo articolista ha ragione a dire che la Spagna non c‘entra. Ma è altrettanto ingiusto buttare la croce addosso agli odiati crucchi. I primi casi, in primavera, non si sono registrati nelle trincee del Kaiser, ma proprio in America, per l‘esattezza a Fort Riley nel Kansas, in un campo militare di quasi centomila metri quadri, dove più di mille reclute sono rimaste contagiate. Da quando, nell‟aprile del 1917, gli Stati Uniti sono scesi in guerra, il loro esercito è salito di colpo da 190 mila uomini a più di due milioni. E in maggioranza sono ragazzi alle prime armi, come il soldatino Charlot di Shoulder Arms. Molti di loro vengono da zone rurali dove vivevano in stretto contatto con polli o maiali: niente di più facile che il virus sia arrivato da lì, e che abbia fatto il salto dagli animali all‘uomo proprio in qualche fattoria del Kansas. Non influenza spagnola, dunque, e nemmeno tedesca: semmai americana. Ma non contento di dare in pasto al pubblico questa fake news, il Washington Times ne lancia anche un‘altra, e ben più colossale: “Che i germi dell‘influenza siano stati segretamente disseminati in questo Paese da sommergibili tedeschi è un‘accusa difficile da provare, ma i loro attacchi coi gas contro gli equipaggi dei nostri fari e navi-faro sono validi indizi contro di loro”. L‘epidemia, insomma, non ha nulla di naturale. All‘origine di tutto ci sarebbe un complotto criminale, la guerra biologica ordita dai servizi segreti di Guglielmo II ai danni degli Stati Uniti e dei loro alleati europei. È curioso che a propagare questa bufala sia una testata con lo stesso nome (The Washington Times) di quella che un secolo dopo, allo scoppio del Coronavirus Covid-19, ha messo in giro la leggenda del microrganismo ingegnerizzato uscito da un laboratorio militare di Wuhan. Ieri gli elmetti chiodati, oggi gli untori cinesi. Nel 1918 non c‘erano Facebook e Whatsapp, e neppure il TgCom24 di Paolo Liguori, pronto a dare per certa la notizia, “confermata da fonte attendibilissima”. In compenso c‘era un conflitto mondiale, quel mostruoso mattatoio che abbiamo visto nel film di Sam Mendes, una corsa forsennata all‟annientamento reciproco dove tutto sembra ammesso, compreso il cloro per gasare le trincee opposte, ma anche una macchina dell‘odio che fabbrica a ciclo continuo le dicerie più assurde, ingigantite dalla cappa di censura sui mezzi di informazione. Un mese prima dell‘articolo sul Washington Times era stata un‟autorità come il colonnello Philip Doane, responsabile della sezione sanitaria della marina mercantile Usa, ad accreditare le tesi cospirazioniste: “Sarebbe molto facile per uno di questi agenti del Kaiser rilasciare germi dell‟influenza in un teatro o in qualche altro posto dove si radunano grandi assembramenti di persone. I tedeschi hanno iniziato le epidemie in Europa, e non c‘è motivo per cui debbano essere particolarmente gentili con l‘America”». 17
A volte la storia si ripete e a una vecchia tragedia se ne aggiunge una nuova, anche se accompagnata da menzogne abbastanza simili a quelle di un secolo fa.
* * * *
PETIZIONE ALL’OMS PER INDAGARE SULL’ORIGINE DEL CORONAVIRUS

Aderisci anche tu firmando la petizione su Change.org
Petizione popolare per chiedere all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) di aprire un’indagine su Fort Detrick (USA) riguardo l’origine del coronavirus.
Alla luce della ricostruzione complessiva svolta nell’articolo Trump, Fort Detrick e il Covid-19. Ilcolpevolesilenzio degliStati Unitisulla vera originedel coronavirus;
viste le informazioni ormai acquisite su un’epidemia di polmonite verificatasi all’inizio di luglio 2019 in una casa di riposo di Green Spring, Virginia (USA);
vista l’anomala chiusura dei laboratori batteriologici di Fort Detrick (USA), proprio nella seconda metà di luglio del 2019 e durata per alcuni mesi;
visto il ritrovamento del coronavirus in Italia, in Lombardia e in altre regioni, fin dall’inizio di settembre del 2019, ossia almeno due mesi prima della genesi dell’epidemia di Covid-19 a Wuhan in Cina;
visto il ritrovamento innegabile del coronavirus anche in un centinaio di cittadini statunitensi già all’inizio di dicembre del 2019;
chiediamo all’Organizzazione Mondiale della Sanità di compiere un’accurata indagine, come quella del resto già avviata a Wuhan all’inizio del 2021, riguardo a Fort Detrick, all’ospedale militare di Fort Belvoir e alla casa di riposo Green Spring, con l’obiettivo di appurare se il coronavirus possa essere stato originato nel territorio degli Stati Uniti d’America.
Aderisci anche tu firmando la petizione su Change.org
Primi Firmatari
Daniele Burgio, Massimo Leoni, Roberto Sidoli, studiosi di politica internazionale, estensori dell’articolo Trump, Fort Detrick e il Covid-19. Il colpevole silenzio degli Stati Uniti sulla veraoriginedel coronavirus
Nunzia Augeri, saggista, Milano
Laura Baldelli, docente di Letteratura e Storia, Ancona
Alessandro Belfiore, Comitato No Guerra NO Nato
Maurizio Belligoni, già Direttore Generale Agenzia Sanitaria Regione Marche; primario di psichiatra
Fulvio Bellini, ricercatore politico, Milano
Ascanio Bernardeschi, redazione del giornale comunista on-line “LaCittàFutura”
Giambattista Cadoppi, saggista, specialista di politica internazionale
Domenico Carofiglio, operaio, attivista FIOM Wirlphool Fabriano
Bruno Casati, Presidente Centro Culturale “Concetto Marchesi” di Milano
Luigi Cavalli, regista cinematografico (ultimo film, 2019, “Mon cochon et moi”, protagonista Gerard Depardieu)
Geraldina Colotti, giornalista, corrispondente in Europa di Resumen LatinoAmericano
Marcello Concialdi, docente ed editore, Torino
Luigi Curcetti, Esecutivo Regionale Marche Unità Sindacale di Base (USB)
Manlio Dinucci, geografo e saggista
Salvatore Distefano, docente di Filosofia e storico del movimento operaio, Catania
Lorenzo Fascì, avvocato, Reggio Calabria;
Salvatore Fedele, chirurgo e già responsabile dipartimento Emergenze ospedale Acqui Terme, Alessandria
Carlo Formenti, giornalista e saggista, già caporedattore di “Alfabeta” e ricercatore presso l’Università di Lecce
Federico Fioranelli, docente di Economia e Diritto
Rolando Giai-Levra, direttore di “Gramsci Oggi”
Fosco Giannini, già Senatore della Repubblica, direttore di “Cumpanis”
Alberto Lombardo, professore ordinario di Statistica Università di Palermo e direttore de “La Riscossa”
Mario Marcucci, docente a contratto di Tecnica Farmaceutica all’Università “La Sapienza di Roma”; già primario di Farmacia
Vladimiro Merlin, delegato RSU FLC- CGIL; già Consigliere Comunale Milano
Alfredo Novarini, già amministratore del P.C.I; membro del Centro Culturale Concetto Marchesi.
Alessandro Pascale, insegnante, saggista e direttore di Storiauniversale.it
Fabio Pasquinelli, avvocato, Osimo (Ancona)
Marco Pondrelli, direttore di “Marx21”
Giorgio Racchicini, docente di Letteratura e Storia, Fermo
Nicola Romana, docente di Diritto Dip. Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche all’Università di Palermo
Onofrio Romano, professore associato di sociologia generale all’Università di Bari
Marino Severini, “voce” e chitarra de La Gang;
Alberto Sgalla, docente di Diritto e scrittore;
Luca Stocchi, Presidente Centro Culturale “Cumpanis” Genova
Alessandro Testa, musicista e studioso di estetica musicale
Roberto Vallepiano, scrittore
Fabrizio Verde, direttore de “L’AntiDiplomatico”
Alessandro Visalli, architetto e dottore di ricerca in pianificazione territoriale, esperto scienze del territorio e ambiente
Alessandro Volponi, docente di filosofia, Fermo
Aderisci anche tu firmando la petizione su Change.org
FONTI:
I detriti del razzo cinese cadono sulla Terra come “accuratamente previsto
La maggior parte delle parti è bruciata durante il rientro, “pratica comune” delle potenze spaziali
di Fan Anqi e Cao Siqi (dal Global Time)
L’autorità spaziale cinese ha annunciato domenica che i resti del razzo vettore cinese Long March-5B Y2 sono rientrati nell’atmosfera terrestre, la maggior parte bruciando all’ingresso, con alcuni resti che cadono nel Mar Arabico.
Nel mezzo di un intenso confronto Cina-USA e di una concorrenza sempre più feroce nella tecnologia tra le due grandi potenze, alcuni americani si sono scervellati e hanno colto ogni occasione per esaltare la teoria della “minaccia cinese”, con l’ultimo episodio in cui hanno accusato la Cina di essere “irresponsabile” per aver lasciato i detriti dei razzi “senza controllo, causando minacce agli oggetti sulla Terra”, nonostante il fatto che è un modo comune globale per gestire i detriti dei razzi, praticato da tutte le potenze spaziali compresi gli stessi Stati Uniti.
Gli esperti aerospaziali cinesi hanno notato che si sentono “sorpresi” che alcune persone accettino una logica così assurda, dato che è senso comune nel campo della scienza. Gli analisti degli affari esteri hanno sottolineato che ciò riflette i doppi standard dell’Occidente nel tentativo di sabotare il piano di costruzione della stazione spaziale cinese, facendo emergere le loro intenzioni militari di tracciare l’hardware spaziale della Cina.
Completamente normale
I detriti del razzo vettore cinese Long March-5B Y2 sono rientrati nell’atmosfera terrestre alle 10:24 del mattino, ora di Pechino, domenica, con la maggior parte delle parti che si sono bruciate durante il processo, ha detto la China Manned Space Agency (CMSA). La posizione del rientro è 72,47 gradi di longitudine est e 2,65 gradi di latitudine nord, indicando il punto di impatto nel Mar Arabico a ovest delle Maldive.
Nonostante il chiarimento da parte degli addetti dell’industria spaziale cinese e del Ministero degli Esteri che la probabilità che i resti del razzo causassero danni era estremamente bassa, un certo numero di media occidentali, tra cui CNN e New York Times, così come il Pentagono e la NASA degli Stati Uniti, hanno affermato che i detriti stavano tornando sulla Terra in modo “incontrollato” e hanno criticato la Cina di essere “irresponsabile” per l’atterraggio nell’oceano.
“Le accuse erano false, senza fondamento”, ha detto Song Zhongping, un esperto aerospaziale e commentatore televisivo. “La cosiddetta traiettoria ‘incontrollata’ si riferisce alla perdita di propulsione, ma non significa affatto che la Cina abbia perso la traccia della sua traiettoria di volo e della sua posizione in tempo reale.”
Ogni movimento dei frammenti del razzo viene osservato da vicino dalla rete di monitoraggio spaziale della Cina, e le previsioni accurate sul suo sito di atterraggio sono state fatte di conseguenza e la rotta di volo avrebbe evitato aree densamente abitate, ha detto Song al Global Times di domenica.
Wang Ya’nan, redattore capo della rivista Aerospace Knowledge, ha detto che è “completamente normale” che i detriti del razzo tornino sulla Terra, ed è una pratica comune effettuata da tutti i partecipanti globali nel campo aerospaziale, compresi gli Stati Uniti.
“La caduta del relitto è all’interno della gamma normale secondo gli standard ampiamente accettati, con la maggior parte delle parti bruciate durante il rientro e alcune sono state bruciate in modo insufficiente a causa delle differenze nell’ambiente atmosferico”, ha detto Wang.
“Fatta eccezione per i razzi riutilizzabili SpaceX, tutti i resti del primo e del secondo stadio dei veicoli di lancio tradizionali ritornano sulla Terra in modo incontrollato. E tutti i paesi che conducono tale pratica tracciano i pezzi che cadono e calcolano le loro traiettorie come fa la Cina”, ha notato Wang.
La consegna in orbita del modulo centrale della stazione spaziale Tianhe ha dimostrato l’affidabilità e la controllabilità del razzo Long March 5B, ha aggiunto Wang.
Dopo il successo del lancio del razzo Long March-5B Y2, che ha mandato in orbita la prima sezione della stazione spaziale cinese – la cabina del modulo centrale Tianhe – la Cina ha dato il via a un’intensa fase di costruzione del progetto della prima stazione spaziale del paese, dove un fitto calendario di altri 10 lanci è stato fissato per i prossimi due anni. La stazione spaziale dovrebbe essere operativa entro il 2022.
Stimata essere l’unica stazione spaziale operativa in orbita che sarà aperta a partner stranieri dopo il pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale previsto nel 2024, alcuni paesi occidentali, soprattutto gli Stati Uniti, sono gelosi di quanto rapidamente la Cina stia crescendo nella tecnologia aerospaziale. “Pertanto, qualsiasi progresso nel settore aerospaziale toccherà un nervo scoperto nella comunità strategica degli Stati Uniti”, ha detto domenica al Global Times Li Haidong, professore presso l’Istituto di Relazioni Internazionali della China Foreign Affairs University.
Gli Stati Uniti hanno continuato a pressare la Cina nel campo della scienza e della tecnologia dopo che il presidente americano Joe Biden è entrato in carica. Ha cercato di usare la questione dei detriti del razzo per macchiare l’immagine della Cina nel mondo, accusando il paese di danneggiare la pace mondiale, e d’altra parte, ha tentato di giocare la teoria della “minaccia cinese” dal momento che non tutti i paesi possono sviluppare razzi Long March, ha detto Li.
I detriti spaziali sono un problema affrontato da tutti i paesi nel processo di sviluppo dello spazio. Lo spazio ha bisogno della protezione di tutti i paesi, proprio come la Terra. Tuttavia, è una questione scientifica e tecnologica e non dovrebbe essere politicizzata, ha sottolineato Li.
Diversi addetti ai lavori dell’industria spaziale cinese, raggiunti dal Global Times di domenica, hanno rivelato che la Cina ha fatto i suoi compiti durante la fase iniziale di progettazione del razzo sulla posizione di decollo, la pianificazione della traiettoria e i relativi preparativi tecnici, che hanno tutti preso in considerazione la caduta dei detriti del razzo.
Intenzioni militari
Prima che i detriti rientrassero nell’atmosfera terrestre, l’esercito degli Stati Uniti e alcune agenzie dell’UE hanno seguito da vicino i detriti e hanno previsto il tempo e la posizione di atterraggio. Gli esperti hanno notato che l’analisi predittiva occidentale del relitto dello stadio finale del razzo vettore Long March-5B Y2 è una sorta di allenamento anti-missile.
“Anche se lo stadio superiore di questo razzo non è un vero missile, la previsione della sua traiettoria di volo e i parametri delle prestazioni di rientro possono essere utilizzati come esercizio per prevedere i parametri di rientro di una vera testata missilistica. È un riferimento per le loro future operazioni anti-missile”, ha detto Huang Zhicheng, un esperto dell’industria spaziale.
Huang ha notato che il trattamento dei detriti dei razzi in tutto il mondo è fondamentalmente allo stesso livello. Il problema principale è che i detriti dello stadio superiore del razzo possono causare una piccola quantità di detriti, ma la probabilità di causare danni è molto piccola. Tuttavia, questo problema non è stato risolto definitivamente da nessun paese.
‘Cometa’ o ‘grave minaccia’?
In netto contrasto con i rapporti dei media sui detriti del razzo cinese, i resti in fiamme del secondo stadio del razzo statunitense SpaceX Falcon 9, che si è schiantato in una fattoria nello stato di Washington a marzo, sono stati descritti da media come Associated Press come “lasciando scie simili a comete” mentre il vascello attraversava il cielo del nord-ovest del Pacifico.
Le diverse descrizioni dei due razzi riflettono i doppi standard adottati da alcune forze occidentali nel modo in cui viene trattata la Cina, ha detto Song, in quanto “non sono davvero preoccupati di causare danni alle persone, ma dal momento che si tratta di un razzo cinese, hanno politicizzato la questione, mettendo un’etichetta su di esso e poi pubblicizzando l’evento.”
Xing Jianwei, vice capo progettista del razzo vettore Long March 2C, ha detto ai media che la Cina sta sviluppando la capacità di controllare la carenatura del razzo (quando il cono anteriore che protegge il carico utile viene gettato nello spazio) dopo la separazione in modo che l’atteggiamento del suo rientro sulla Terra possa essere controllato.
Durante i quasi 60 anni di attività spaziale, non sono stati riportati casi di detriti di razzi che abbiano causato vittime umane. I rischi per tutti i detriti di razzi sono abbastanza simili, quindi, è davvero poco onesto intellettualmente sostenere che i razzi cinesi hanno un rischio particolarmente elevato, hanno detto gli analisti.
“Ora dubito davvero del senso comune della scienza nella società occidentale, dal momento che assumono tale logica”, ha notato Wang Yanan.
Traduzione: Cambiailmondo
Povero Rampini, ora che “Biden copia la Cina”
di Dante Barontini (da Contropiano)
Dopo Ernesto Galli Della Loggia, non poteva mancare il famoso traduttore Federico Rampini nella per ora breve lista degli opinionisti (fare informazione è un altro mestiere) che hanno ricevuto l’input “si cambia registro”.
Solo che non cerca di concettualizzare troppo, non si fida a toccare i “massimi sistemi”, e dunque si limita a fare il compitino anti-cinese. Purtroppo per lui – anche se finge di non accorgersene – così facendo si dà la zappa sui piedi e, soprattutto, rende un pessimo servizio ai suo datori di lavoro (il gruppo Gedi, parte della galassia Stellantis, che incorpora ora Fiat-Citroen-Peugeot-Chrysler; insomma una multinazionale davvero “euro-atlantica”).
Divertiamoci un po’.
Nella sua articolessa di oggi il buon Rampini deve segnalare che gli Usa stanno ripartendo alla grande, come e anzi più della Cina (che Pechino sia diventato ora il competitor principale è una decisione yankee, in perfetta continuità tra Triìum e Biden). E dunque comincia sparando su Xi Jinping, pur riconoscendo – sono dati ufficiali, addirittura un po’ più bassi delle previsioni degli analisti occident Joe Biden sta copiando Xi Jinping ali – l’enormità della crescita cinese nel primo trimestre 2021 (+18,3%).
Anche la ragione di questa fenomenale risalita non può essere ignorata: la gestione della pandemia è stata decisamente diversa tra Occidente ed Oriente. E i risultati si vedono a occhio nudo.
La “spiegazione” di Rampini è però esilarante. “Il ‘metodo Xi Jinping’ applicato ai lockdown insegna: perfino un regime autoritario non ha osato infliggere troppo a lungo le restrizioni estreme. La chiusura di Wuhan, con metodi inaccettabili in qualsiasi paese democratico, è durata però 76 giorni, un’inezia rispetto agli interminabili lockdown occidentali.
L’autocrate Xi Jinping ha mostrato di conoscere i limiti del proprio potere. La sua terapia durissima ma corta, è il segreto della turbo-ripresa cinese.”
Se queste parole avessero un senso, bisognerebbe dire che “un regime autoritario” ha avuto paura della propria popolazione, mentre quelli “democratici” dell’Occidente se ne sono altamente fregati. Ma sistemi politici che “temono” la propria gente – qualunque cosa si intenda per “temere” – si mostrano decisamente più rispettosi di quelli che se ne fregano.
E non parliamo poi – e infatti Rampini tace su questo “piccolo dettaglio” – degli effetti di quella gestione in termini di vite umane: 567.000 morti negli Usa – con quasi 32 milioni di contagiati su una popolazione di 318 milioni di persone – contro i 4.845 morti e i 102.000 contagiati della Cina, che 1,4 miliardi abitanti. Oltre un milione di morti nell’Unione Europea, con 446 milioni di abitanti.
Tirando le somme: i regimi “democratici e liberali” hanno gestito le cose in modo da provocare strage dei propri cittadini, mentre il “regime autoritario” si è preoccupato – per “paura”, naturalmente – di minimizzare le perdite adottando le misure che ogni scienziato serio inutilmente predica dalle nostre parti. Eppure il primo dei diritti umani è proprio quello alla vita, no?
Dettaglio secondario: confinando l’epidemia a relativamente pochi casi, anche la capacità produttiva cinese ne ha tratto decisamente beneficio, anticipando di mesi la “ripresa” che qui è ancora al livello delle speranze.
Davvero vantaggiosa, insomma, la “democrazia liberale” per chi vive da queste parti.
Ma Rampini scrive l’articolo per far vedere che sa di economia, anche. E quindi deve girare i dati oggettivi in una torsione particolarmente ridicola: “Mentre l’America e l’Europa erano paralizzate, le fabbriche cinesi avevano ricominciato a produrre per noi già l’estate scorsa. Gli ingorghi che da mesi affliggono il traffico navale e i porti di tutto il mondo sono rivelatori. Uno dei motori del boom cinese, ancora una volta siamo noi: i consumatori occidentali. Nel primo trimestre le esportazioni cinesi sono aumentate del 39%.”
Il dato fornito da Rampini è in primo luogo sbagliato (49%, non 39), in secondo luogo parziale. Ogni redattore economico – ma anche chiunque faccia la spesa – sa che bisogna tener d’occhio non solo le uscite (esportazioni, in questo caso), ma anche le entrate, altrimenti non si capisce granché. Le importazioni cinesi nel primo trimestre sono a loro volta cresciute, e del 28%.
Dunque la ripresa cinese non è orientata solo dalle esportazioni (non lo era più già da qualche anno), ma complessiva. Certo, con l’Occidente inchiodato nei finti lockdown stop and go, si erano creati vuoti di mercato che sono stati immediatamente riempiti (e non solo di mascherine…).
Il discorso sarebbe lungo, i dati li abbiamo forniti molte vole e a quelli vi rimandiamo per non tediarvi.
Sorvoliamo anche su altre solenni sciocchezze (“Xi Jinping non è ancora riuscito a realizzare la conversione del modello di sviluppo cinese allo stadio di un’economia avanzata dove prevale il traino dei consumi nazionali”, come se qui in Europa non fossimo schiacciati da 30 anni di deflazione salariale e modello “export oriented” di matrice teutonica).
La “notizia” che ci dà Rampini – un po’ in ritardo – è che “Joe Biden sta copiando Xi Jinping”, e che proprio per questo “L’America è lanciata verso un aggancio-sorpasso clamoroso. A fine anno secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale la crescita americana potrebbe superare quella cinese.”
Prima osservazione: se gli Usa ora copiano la Cina – sia pur limitatamente alla decisione di investimenti pubblici sostanziosi – vuol dire che il modello cinese non è poi così male; o comunque che il neoliberismo dominante fin dai tempi di Reagan sta tirando le cuoia, una crisi dopo l’altra.
Su questi altri “piccoli dettagli”… silenzio, naturalmente. I bilanci negativi si sposano male con il trionfalismo “amerikano” che Rampins deve promuovere.
Seconda osservazione: che “a crescita americana potrebbe superare quella cinese” è una previsione-speranza del Fmi, non un dato di fatto. Molto dipende sia dal via libero del Senato (al 50% trumpiano) al secondo piano di investimenti pubblici da 2.000 miliardi di dollari, oltre che dalla risposta del sistema economico ed industriale Usa, non proprio in buona salute negli ultimi tempi.
Terza osservazione: se “d’ora in avanti non vuol essere meno generoso di Xi Jinping nel finanziare la ricerca, nel sostenere le tecnologie “di frontiera” come i semiconduttori e le telecom 5G, le energie rinnovabili e l’auto elettrica”. Di più: spende in deficit cifre mostruose (altra inesattezza: i cinesi non ne hanno bisogno, perché sono pieni di liquidità), seppellendo il primo comandamento del neoliberismo stile Chicago Boys o BundesBank.
Silenzio di tomba su questo “contrordine!” che sta circolando nelle cancellerie occidentali…
Che gli Usa riprenderanno a crescere quest’anno, anche sul piano industriale, è certamente vero. La “botta” subita nel 2020 è stata forte, e la vaccinazione di massa – trattenendo negli Usa il grosso della produzione di Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson – rende a breve di nuovo possibile la riapertura di tutte le attività (qui si cerca di farlo senza le vaccinazioni, alla speraindio). Sull’Europa – e le illusioni che Rampini nutre – c’è poco da dire, visto che finora non un solo euro è stato stanziato davvero per avviare un qualsiasi tipo di Recovery.
Ma da un prestigioso e ultra-retribuito inviato internazionale ci si aspetterebbe un po’ più di precisione sui dati, qualche insulto gratuito e qualche panzana propagandistica in meno, un briciolo di riflessione sulle conseguenze di quel dice.
E parecchi silenzi in meno.
*****
Ripartono le locomotive
Federico Rampini – da La Repubblica
Per qualcuno la pandemia è un ricordo distante, un’immagine che rimpicciolisce nello specchietto retrovisore. La Cina ha cancellato tutti i danni, oggi è più ricca di quanto fosse nell’era pre Covid. La crescita dell’economia cinese nel primo trimestre di quest’anno, +18,3%, segna un record ventennale anche se in parte è dovuto al rimbalzo dopo la paralisi dei lockdown. La recessione del 2020 è stata brevissima in Cina.
Il “metodo Xi Jinping” applicato ai lockdown insegna: perfino un regime autoritario non ha osato infliggere troppo a lungo le restrizioni estreme. La chiusura di Wuhan, con metodi inaccettabili in qualsiasi paese democratico, è durata però 76 giorni, un’inezia rispetto agli interminabili lockdown occidentali.
L’autocrate Xi Jinping ha mostrato di conoscere i limiti del proprio potere. La sua terapia durissima ma corta, è il segreto della turbo-ripresa cinese.
Mentre l’America e l’Europa erano paralizzate, le fabbriche cinesi avevano ricominciato a produrre per noi già l’estate scorsa. Gli ingorghi che da mesi affliggono il traffico navale e i porti di tutto il mondo sono rivelatori.
Uno dei motori del boom cinese, ancora una volta siamo noi: i consumatori occidentali. Nel primo trimestre le esportazioni cinesi sono aumentate del 39%.
Nella formidabile performance del dragone cinese ci sono delle fragilità. La Repubblica Popolare si conferma troppo dipendente dalle esportazioni, in una fase in cui il protezionismo non è tramontato. Anzi, una delle rivelazioni della pandemia riguarda il pericolo di affidarsi a una logistica industriale troppo globale e dilatata, esposta a improvvise chiusure di frontiere (nei medicinali ma non solo)
Il mondo post Covid sì riorganizza con un’attenzione alla sicurezza delle catene produttive, che molti Stati cercano di riportare dentro i propri confini. Xi Jinping non è ancora riuscito a realizzare la conversione del modello di sviluppo cinese allo stadio di un’economia avanzata dove prevale il traino dei consumi nazionali.
L’autogol nella diplomazia sanitaria, dopo la pasticciata (e poi smentita) ammissione che i vaccini made in China sono poco efficaci, rivela i limiti di un sistema allergico alla trasparenza.
Il vero successo della Cina però sì misura a Washington. L’America è lanciata verso un aggancio-sorpasso clamoroso. A fine anno secondo le previsioni del Fondo monetario internazionale la crescita americana potrebbe superare quella cinese.
Anche gli Stati Uniti hanno avuto una recessione più breve e meno cruenta del previsto; ora hanno la loro turbo-ripresa e finiranno per cancellare i danni sociali dei lockdown prima del previsto.
Ma in parte il boom americano ha una spiegazione sorprendente: Joe Biden sta copiando Xi Jinping. Già aveva cominciato Donald Trump, con un massiccio ricorso a manovre di spesa pubblica in deficit: l’anno scorso il deficit federale era balzato al 15% del Pil.
Biden continua sulla scia del suo predecessore, ha varato 1.900 miliardi di dollari di aiuti alle famiglie a cui vuol far seguire 2.000 miliardi di investimenti in infrastrutture. Pur in un anno di fortissima ripresa che vede risalire il gettito fiscale, il deficit pubblico sarà superiore al 10% del Pil.
È il modello che Pechino applicò nel 2008-2009: all’epoca dell’ultima crisi globale l’intervento statale consentì alla Cina di essere l’unica grande economia risparmiata dalla recessione.
L’altra lezione cinese che Biden sta copiando riguarda la politica industriale: d’ora in avanti non vuol essere meno generoso di Xi Jinping nel finanziare la ricerca, nel sostenere le tecnologie “di frontiera” come i semiconduttori e le telecom 5G, le energie rinnovabili e l’auto elettrica.
Nella gara tra le due superpotenze questa è la vera novità: l’America sta inseguendo un modello cinese, dopo averlo sottovalutato troppo a lungo.
L’Europa è in ritardo su tutti i fronti, ma le riprese gemelle delle due locomotive cinese e americana sono una buona notizia per tutti. Per scegliere un micro-esempio fra tanti: entro pochi anni i consumatori cinesi compreranno la metà di tutti i prodotti di lusso venduti nel mondo, saranno quindi un mercato sempre più trainante per il made in Italy.
Ma un monito viene dal recente infortunio di molte marche occidentali della moda che hanno osato boicottare il cotone dello Xinjiang per condannare gli abusi che Pechino infligge ai diritti umani in quella regione: è partita una massiccia campagna di rappresaglie.
Il nazionalismo cinese non perdona; usa il commercio estero come un’arma strategica di micidiale efficacia. Sempre più spesso, anche nella sfera economica l’Europa sarà messa di fronte a scelte difficili, dovrà decidere da che parte stare, e gli spazi per la neutralità si restringeranno perfino per chi pensa solo a vendere i propri prodotti.
Londra e Ankara: un’intesa commerciale e strategica
di Maurizio Vezzosi
Tra i numerosi accordi bilaterali e multilaterali sottoscritti dal Regno Unito sulla scorta dell’uscita dall’Unione Europea spicca quello firmato con la Turchia: un accordo di libero scambio tra le cui maglie traspare il rafforzamento della strategia antirussa, anti-iraniana e anticinese post-Brexit di Londra.
Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha descritto l’accordo come il «il più importante accordo commerciale» dopo quello firmato tra la Turchia e l’Unione Europea nel 1995. Dalla prospettiva turca esso incentiverà l’esportazione di prodotti alimentari, meccanici – specie per l’indotto automobilistico – chimici e tessili verso la Gran Bretagna. Per la Turchia Londra rappresenta infatti il secondo principale sbocco commerciale per le proprie esportazioni dopo la Germania. Stando alle stime inglesi, il volume d’affari tra Gran Bretagna e Turchia del 2019 ha superato il valore di 25 miliardi di sterline. Alcuni mesi fa, inoltre, Gran Bretagna e Turchia hanno svolto le prime esercitazioni aeree congiunte della loro storia e a distanza di poche settimane hanno reso operativa un’unione doganale.
Le pulsioni della Gran Bretagna post-Brexit sembrano ambire al rinnovamento del proprio protagonismo nello scenario internazionale e militare: così suggerisce, del resto, il cospicuo aumento della spesa militare voluto dal primo ministro Boris Johnson, pari a circa 20 miliardi di euro. Oltre a ciò, dalle prime mosse britanniche traspare chiaramente l’intento di realizzare un riposizionamento strategico a fianco di Washington. Certamente le turbolenze che stanno attraversando gli Stati Uniti potrebbero complicare la realizzazione di questo processo, ma paradossalmente potrebbero anche favorirlo.
Se l’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca potrà avere un effetto ‒ almeno formale ‒ sui rapporti tra Stati Uniti e Turchia, la costruzione di un’intesa strategica tra Londra e Ankara crea i presupposti per surrogare il ‒ parziale ‒ ripiegamento strategico di Washington dal Vicino Oriente. Nella pratica, eventuali sanzioni ‒ simboliche – mosse dagli Stati Uniti nei confronti di Ankara o – altrettanto simboliche – sospensioni di forniture militari provenienti da Washington sarebbero ampiamente compensate dalle forniture britanniche, esistenti o futuribili.
Le sanzioni verso Turchia formalmente paventate dalla Gran Bretagna per le trivellazioni di Ankara in acque territoriali cipriote, d’altro canto, consistono per il momento in un pacato invito ad abbassare i toni. In questo quadro, dove sono almeno 3.500 i militari nelle basi militari britanniche di Akrotiri e Dhekelia (Cipro), la Turchia diviene uno degli assi portanti della strategia britannica nel Vicino Oriente: una strategia che in ogni caso dovrà avere cura di non compromettere l’asse con Atene.
Quello che l’atteggiamento della Gran Bretagna lascia per il momento presumere è l’embrione di una strategia volta a rinnovare il ruolo britannico nel Mediterraneo orientale e nel Vicino Oriente basata sulla mediazione dei contrasti di alcuni attori fondamentali dell’area ‒ come quelli greco-turchi e turco-egiziani – e sul contenimento di Teheran.
Londra ed Ankara hanno già in programma una “fase due” che prevede “un’area di libero scambio più comprensiva ed ambiziosa”. A chiarire il risvolto strategico dell’accordo di libero scambio tra Gran Bretagna e Turchia è stato lo stesso l’ambasciatore britannico ad Ankara Dominick Chilcott, il quale ha anche confermato la valenza anticinese dell’intesa turco-britannica: «Uno dei grandi problemi strategici dei nostri tempi riguarda la necessità di calibrare le relazioni con la Cina. La pandemia, nei suoi primi mesi, ha fatto emergere la vulnerabilità di essere dipendenti dalla manifattura cinese per alcuni prodotti chiave, come i dispositivi di protezione. La Gran Bretagna, come molti altri Paesi, ha bisogno di individuare altri Paesi da cui approvvigionarsi, e questo, insieme alla nuova area di libero scambio [con la Turchia] crea un’opportunità per la Turchia e per il commercio turco-britannico. Spero anche che nel settore della difesa la collaborazione tra aziende britanniche e turche possa crescere: si tratterebbe di un fatto naturale per due Paesi NATO, ed ovviamente con un significato strategico». A questo l’ambasciatore britannico ha aggiunto di considerare quella di Ankara «l’unica democrazia stabile del Vicino Oriente».
Dalla prospettiva britannica l’area di libero scambio con la Turchia permetterà di contenere la dipendenza di Londra dalle merci cinesi, che attualmente corrispondono a circa il 10% dell’intero valore annuale delle importazioni britanniche ‒ circa 60 miliardi di euro su un totale di quasi 600 – con un interscambio complessivo che nel 2020 ha superato gli 85 miliardi di euro ed una bilancia commerciale nettamente favorevole a Pechino. Pur risultando evidentemente incompatibile con la strategia anticinese adottata da Londra, nel passato recente l’idea di un’area di libero scambio commerciale tra Londra e Pechino godeva in Gran Bretagna di una certa attenzione. Nel 2018 era stato lo stesso ministro degli Esteri cinese Wang Yi a proporre al suo omologo britannico Jeremy Hunt l’idea di un’area di libero scambio tra Londra e Pechino: malgrado ciò, l’atteggiamento britannico del presente sembra non tollerare una Cina prospera e in forze.
Oltre che nel Vicino Oriente, l’intesa strategica tra Gran Bretagna e Turchia non mancherà di avere importanti risvolti anche in Africa, dove la tradizionale presenza britannica si trova a fare i conti con il protagonismo russo e cinese: un protagonismo che Londra punta evidentemente a contrastare facendo leva sulla presenza turca nel continente africano.
Rispetto a Mosca, infine, la “scommessa turca” della Gran Bretagna sembra volersi ispirare alla larga coalizione che affrontò l’Impero zarista nella guerra di Crimea combattuta tra il 1853 ed il 1856. Nel presente, del resto, Ankara e Londra si trovano spalla a spalla anche in Ucraina, fornendo da sette anni assistenza ‒ istruttori, mercenari, armi e droni ‒ all’esercito di Kiev contro gli insorti del Donbass sostenuti da Mosca. Malgrado tutte le azioni messe in campo e le ambizioni di Lord Johnson, la gloria di Lord Palmerston potrebbe di per sé non garantire i fasti del passato alla nuova Gran Bretagna post-Brexit.
FONTE: https://www.treccani.it/magazine/atlante/geopolitica/Londra_e_Ankara.html
Il giallo del pipistrello. E non solo. Le “non-conclusioni” della missione scientifica a Wuhan.
 di Marinella Correggia
di Marinella Correggia
Un’unica certezza: non è stato il maggiordomo. E se colpevole (senza colpa) fosse stato il pipistrello, non avrebbe agito da solo. Continua il giallo delle origini virali. Il Sars-CoV-2, imputato per la pandemia di Covid-19, come e perché ha fatto il salto di specie dall’ospite animale? E il teatro del crimine – il luogo della trasmissione alla popolazione umana -, è stato davvero, nel dicembre 2019, l’ormai tristemente famoso mercato ittico di Huanan a Wuhan, la città primo epicentro al mondo? E ci sono altre ipotesi?
Non è arrivato a una conclusione nemmeno il team di esperti internazionali dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) che ha lavorato per un mese in Cina insieme a 17 colleghi locali, rivedendo studi, conducendo interviste, effettuando sopralluoghi. Insomma, cerchiamo ancora, è stata la promessa ripetuta nella conferenza stampa del 9 febbraio, a Wuhan. Finora è stata esclusa una sola delle ipotesi in campo. E il panorama delle indagini si è allargato al mondo intero.
Quattro ipotesi da studiare meglio; anzi tre (esclusa la fuga dal laboratorio). Obiettivi della missione erano da un lato verificare il luogo e la data di partenza dell’epidemia – e secondo varie ricerche cliniche condotte dai cinesi, non ci sarebbe evidenza di una trasmissione comunitaria nella città prima del dicembre 2019. Dall’altro di trattava di capire con quali modalità il virus si sia introdotto nella popolazione umana e abbia potuto circolare e in quali luoghi – considerando che nel dicembre 2019 il mercato di Huanan non è stato l’unico focolaio a Wuhan e che allo stato delle informazioni, e che la via esatta della diffusione del virus nel mercato non è stata individuata.
Il capo della missione dell’Oms a Wuhan, il danese Peter Ben Embarek ha spiegato in conferenza stampa: «Il lavoro sul campo non ha stravolto le percezioni che avevamo ma ci ha dato molti elementi. Abbiamo lavorato su quattro ipotesi chiave circa l’introduzione del virus Sars-CoV-2 nella popolazione umana e per ciascuna abbiamo valutato sistematicamente i pro e contro in modo razionale per futuri studi. Primo: salto di specie diretto da un serbatoio animale alla popolazione umana. Secondo: introduzione del virus mediante un’altra specie, ospite intermedia, potenzialmente più vicina agli umani, nella quale il virus si sarebbe meglio adattato e avrebbe potuto circolare per poi saltare agli umani. Terzo: la catena alimentare, in particolare prodotti alimentari congelati che agivano come superficie per la trasmissione agli umani e tutte le trasmissioni legate al cibo. Quarto: la possibilità di un rilascio accidentale da un laboratorio». Ha proseguito Ben Embarek: «La seconda ipotesi è la più probabile e sarà la pista per future ricerche, in collegamento con l’ipotesi della trasmissione attraverso le catene del freddo».
Invece l’ultima ipotesi di introduzione nella popolazione umana – l’incidente della fuoriuscita da un laboratorio virologico non sarà più studiata: è ritenuta «altamente improbabile» in quanto «benché gli incidenti possano accadere, un simile virus non era stato oggetto di nessuna pubblicazione da parte di ricercatori; e i vari laboratori visitati, incluso quello di virologia, sono molto sicuri».
Comunque «tutto il lavoro compiuto continua a ritenere le popolazioni di pipistrelli il serbatoio naturale di questo virus e di virus simili. Ma la città di Wuhan non è vicina ad ambienti ricchi di pipistrelli, quindi la prima ipotesi, il salto diretto, è improbabile. Occorre trovare quale altra specie animale possa aver introdotto il virus, particolarmente nel mercato di Huanan».
Per Lian Wannian, capo del team cinese che ha collaborato con la missione, «coronavirus geneticamente collegati al Sars-CoV-2 sono stati identificati in diversi animali, fra cui pipistrelli detti “ferro di cavallo” e pangolini. Tuttavia campioni prelevati nello Hubei non hanno trovato evidenze di virus relativi al Sars-CoV-2 e campioni su animali selvatici in diverse parti della Cina finora non hanno trovato la presenza di Sars CoV-2». Come conseguenza dell’ipotesi, comunque (e per fortuna), il povero mammifero con le scaglie, in precedenza commercializzato seppure in modo illegale, è stato promosso al livello di protezione del panda.
Sempre per Lian Wannian, inoltre, «visoni, mustelidi, felidi e altre specie sono altamente suscettibili all’infezione e questo suggerisce che potrebbero essere un serbatoio ma non ci sono abbastanza dati». Milioni di visoni allevati soprattutto in Danimarca sono stati macellati – nelle tipiche scene infernali che accompagnano spesso le epidemie zoonotiche – perché negli allevamenti si è scoperta una trasmissione del virus da lavoratori ad animali e viceversa. Tanto che il sito ecologista Reporterre ha dedicato un’inchiesta https://reporterre.net/Les-elevages-de-visons-en-Chine-a-l-origine-du-Covid-19-Les-indices-s-accumulent alla possibilità che il salto del virus Sars-CoV-2 dal pipistrello, suo serbatoio naturale, all’umano, sia passato per quegli animali da pelliccia – e non per il pangolino.
Entrami i capi delegazione hanno ribadito che «grandi quantità di test relativi al Sars-Cov-2 sono stati condotti su molte specie animali, domestiche e selvatiche, anche nel resto del paese, ma non si è riusciti a trovare una specie animale potenziale serbatoio. Quindi non sembra che ci fosse ampia circolazione, nel 2019 e oggi, del virus in specie animali».
Giallo anche sull’ipotesi tre. Gli stand del mercato vendevano (prima della chiusura) soprattutto animali congelati, in particolare ittici, ma anche prodotti – e animali vivi – provenienti da allevamenti di specie di origine selvatica. Sono stati identificati venditori, fornitori e fattorie da diverse aree della Cina e anche dall’estero. Si continuerà su questa pista, ha spiegato il capo delegazione, compresa quella della catena di approvvigionamento di prodotti animali congelati.
Anche per Lian Wannian «nel mercato di Huanan, prima della chiusura, è stata rilevata la presenza di superfici altamente contaminate, compatibili con la presenza di persone infette o prodotti animali contaminati della catena del freddo». La possibilità di sopravvivenza del virus anche in condizioni di refrigerazione è da verificare. L’ipotesi di una importazione del virus da altri paesi, con la catena del freddo, è stata evocata già mesi fa da Pechino.
E adesso indagini a tutto campo anche nel resto del mondo
Fra le raccomandazioni del team, c’è quella di valutare se il virus fosse già presente in altri luoghi e paesi. La prospettiva è dunque di una ricerca internazionale. Alla domanda se il virus possa essere arrivato da altri paesi a Wuhan per esempio con viaggiatori asintomatici, Marion Koopmans, virologa olandese membro del team, ha citato la ricerca in Italia
(https://www.iss.it/primo-piano/-/asset_publisher/o4oGR9qmvUz9/content/cs-n%25C2%25B039-2020-studio-iss-su-acque-di-scarico-a-milano-e-torino-sars-cov-2-presente-gi%25C3%25A0-a-dicembre), indicando però che occorrono conferme. Sia Ben Embarek che Lian Wannian hanno precisato che adesso le ricerche devono continuare in tutto il mondo. Il danese ha precisato: «»In ogni caso occorre un approccio senza frontiere. Sulle popolazioni di pipistrelli, la Cina ha già testato molto ma nella sub regione si è fatto molto meno. Inoltre il passaggio alle persone può aver coinvolto viaggi e passaggio di frontiere fino a Wuhan. Occorre dunque verificare se in quella fase temporale ci fossero individui infetti anche in altri paesi.
Nel mistero fitto, il Centro cinese per il controllo delle malattie e la prevenzione ha dichiarato agli inizi del 2021 che «potrebbe servire molto tempo per trovare il virus. Potrebbe anche sparire prima che venga individuata l’origine».
In ogni caso, è tempo di cambiare radicalmente i rapporti fra il mondo umano e quello animale. Selvatico e allevato.
RCEP, il più grande blocco commerciale del mondo: come la Cina sta mettendo all’angolo gli USA
La Cina firma con 14 Paesi il più grande patto commerciale del pianeta. Ci sono i 10 Paesi ASEAN insieme a Corea del Sud, Giappone, Australia e Nuova Zelanda
(Asiablog.it) — Dopo ben otto anni di negoziazioni, la Cina è riuscita a concludere l’accordo commerciale più grande del mondo, il quale la lega con altre 14 economie orientali e non solo. La firma del Partenariato Economico Globale Regionale (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) è arrivata domenica 15 novembre, al termine del vertice dell”Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), che vedeva il Vietnam come Paese ospitante.
Sforzo egemonico
La Rcep si affianca all’altro enorme sforzo egemonico prodotto dalla Cina in questi anni: i mega investimenti infrastrutturali della Nuova Via della Seta, che comincia però a mostrare sempre più evidenti segni di fatica e disincanto da parte dei Paesi partner. Al di là dei contenuti su dazi e commercio, la Rcep, come già la Via della Seta, ha valore politico: nella competizione sempre più aspra con gli Stati Uniti, Pechino ha portato avanti con pazienza e determinazione la propria diplomazia e ha costruito, almeno sulla carta, un blocco d’interesse e di influenza che abbraccia tradizionali alleati di Washington.
Oltre ai dieci Stati membri dell’Asean (Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia, Vietnam), dell’intesa fanno parte Australia, Nuova Zelanda e soprattutto Giappone e Corea del Sud. Uno schiaffo per l’Amministrazione di Donald Trump.
Nelle intenzioni di Pechino, avrebbe dovuto partecipare anche l’India, che si è sfilata non troppo a sorpresa l’anno scorso, sempre più irritata dall’espansionismo economico dell’ingombrante vicino. Le tensioni tra i due Paesi si sono riversate sul confine conteso sull’Himalaya, dove le schermaglie tra gli opposti eserciti sono salite di livello negli ultimi mesi.
I numeri della Rcep
Anche senza l’India, i numeri della Rcep sono impressionanti. La regione interessata produce il 30% del Pil mondiale e ospita quasi 2,3 miliardi di persone. L’accordo punta a ridurre progressivamente i dazi e a facilitare investimenti e scambi tra i Paesi membri (creando regole d’origine comuni). Il risultato sarà il rafforzamento delle catene di approvvigionamento regionali, sotto regia cinese. Aspetto sul quale Pechino, unica grande economia a salvarsi dalla recessione nell’anno del Covid-19, punta sempre di più, per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti.
I membri della Rcep hanno già vari accordi bilaterali o multilaterali tra loro, sui quali poggia la nuova intesa. Ci sono regole anche sulla proprietà intellettuale, mentre poca attenzione viene posta su diritti del lavoro e ambiente.
Il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) è stato siglato ad Hanoi lo scorso 15 novembre, dopo otto anni di negoziati, e include le 10 economie dell’Asean (Indonesia, Malaysia, Singapore, Filippine, Vietnam, Thailandia, Laos, Cambogia, Myanmar e Brunei) oltre a Cina, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda e Australia. Oltre agli USA, l’altro grande assente è l’India, ritiratasi dal negoziato nel 2019.
Il vuoto lasciato da Trump
Per Pechino è un chiaro successo: la sua offensiva diplomatica ha potuto svilupparsi nel vuoto lasciato dall’Amministrazione Trump, che ha ripudiato il progetto parallelo e alternativo lanciato da Barack Obama, la Trans-Pacific Partnership (poi firmata in forma leggera dagli altri Paesi coinvolti). Per molti versi, la Rcep rappresentava proprio la risposta alla Tpp, che escludeva la Cina e puntava a contenerla.
Con la dottrina America First, Trump ha invece rigettato il multilateralismo e reimpostato su basi mercantilistiche anche le relazioni con i tradizionali alleati, scavando un fossato di irritazione, diffidenza e dazi. Salvo poi dover rincorrere la Cina con forniture di armamenti (per esempio a Taiwan), per dare sostanza alla propria presenza politica e militare nella regione.
Secondo William Reinsch, funzionario commerciale dell’Amministrazione Clinton e consulente del Centro per gli studi strategici e internazionali di Washington, «se gli Stati Uniti continueranno a ignorare o intimidire i Paesi della regione, il pendolo dell’influenza oscillerà verso la Cina. Se invece Biden ha un piano credibile per ripristinare la presenza e l’influenza degli Usa, allora il pendolo potrebbe tornare dalla nostra parte».
L’annuncio della Rcep è arrivato mentre a Washington va in scena la più contestata e rocambolesca transizione della sua storia.
FONTE: http://www.asiablog.it/2020/11/24/rcep-cina-stati-uniti/#more-47471
Cosa succede a Hong Kong? Intervista Video a Francesco Maringiò
Con l’aiuto di Francesco Maringio’, esperto di Cina, chiariamo quello che sta succedendo a Hong Kong.
Intervista di Pietro Lunetto
FONTE: https://emigrazione-notizie.org/?p=32006
CUBA E CINA: UNA LEZIONE DI UMANITA’.
 di Anika Persiani
di Anika Persiani
(21/03/2020) – Domani sbarcheranno a Malpensa 52 medici cubani, accompagnati da coordinatori e traduttori.
Mentre tutti i nostri paesi “amici” ci hanno chiuso la porta in faccia, ci hanno derisi, ci hanno trattati come “sporchi e maledetti”, ci hanno lasciati affogare in questa orribile pandemia che con una presa di coscienza ed un aiuto europeo dal primo giorno si sarebbe potuta fermare, domani arriveranno “i cubani”.
Donne e uomini che, per umanità, stanno lasciando le loro famiglie, i loro cari, i loro amici, nell’incertezza di non rivederli mai più. Continua a leggere
Pandemia: La Casa Bianca e FMI i primi infetti
 di Atilio A. Boron
di Atilio A. Boron
Guerre, crisi economiche, disastri naturali e pandemie sono eventi catastrofici che fanno emergere il peggio e il meglio nelle persone – sia nei leader che nella gente comune – e anche negli attori sociali e nelle istituzioni. È in circostanze così avverse che le belle parole svaniscono nel nulla e danno luogo ad azioni e comportamenti concreti. Giorni fa e trattenendo a malapena le lacrime, il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha denunciato davanti alle telecamere il grande inganno della “solidarietà europea”. Non esiste una cosa del genere, ha detto Vucic, è una favola per bambini, carta straccia. Ha poi ringraziato la Repubblica Popolare Cinese per la sua collaborazione. E aveva ragione nella sua denuncia. Dall’America Latina abbiamo a lungo avvertito che l’Unione Europea era un sottile raggiro, pensato per avvantaggiare la Germania più di ogni altra cosa attraverso il controllo della Banca Centrale Europea (BCE) e con l’Euro per assoggettare i paesi dell’Eurozona ai capricci – o agli interessi – di Berlino. L’esitante reazione iniziale della BCE all’eccezionale richiesta di aiuto dell’Italia per affrontare la pandemia che sta devastando la penisola ha mostrato per alcune ore ciò che il leader serbo aveva denunciato. Un scandaloso “ognuno per sé”, che smonta la retorica sdolcinata de “l’Europa dei cittadini” e “Europa una e multipla” e altre simili balle. Una favola per bambini, come diceva Vucic. Continua a leggere
Italia Cina – Collaborazione Scientifica e Tecnologica: Piano d’Azione verso il 2025
 Uno studio sulla cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina, indirizzato a industrie, università ed enti di ricerca, che presenta le tematiche su cui concentrare gli sforzi del prossimo quinquennio.
Uno studio sulla cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina, indirizzato a industrie, università ed enti di ricerca, che presenta le tematiche su cui concentrare gli sforzi del prossimo quinquennio.
ll documento – che rinnova l’impegno del Maeci nell’azione di coordinamento della cooperazione bilaterale con la Cina – è stato realizzato con il contribuito degli Addetti scientifici italiani accreditati nella Repubblica popolare cinese e dei partecipanti al Tavolo tecnico per la cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina, coordinato dalla Farnesina.
Si punta a stimolare nuove iniziative di cooperazione bilaterale in un’ottica di collegamento tra ricerca, alta formazione e industria nei seguenti settori: 1) fisica, geofisica e spazio; 2) materiali avanzati; 3) ambiente e energia; 4) urbanizzazione sostenibile; 5) nuove tecnologie per il patrimonio culturale; 6) agricoltura; 7) scienze della vita, salute e benessere; 8) fabbrica intelligente.
SCARICA IL DOCUMENTO
Il coronavirus è il disastro perfetto per il capitalismo dei disastri
 L’attivista, figura di riferimento del movimento di Seattle, spiega come governi ed elite globali sfrutteranno la pandemia per portare avanti le priorità del libero mercato . Un’intervista tradotta dall’edizione dall’edizione statunitense del magazine Vice
L’attivista, figura di riferimento del movimento di Seattle, spiega come governi ed elite globali sfrutteranno la pandemia per portare avanti le priorità del libero mercato . Un’intervista tradotta dall’edizione dall’edizione statunitense del magazine Vice
Il coronavirus è ufficialmente una pandemia globale che finora ha infettato un numero di persone dieci volte superiore a quello che venne colpito dalla Sars. Negli Stati Uniti scuole, sistemi universitari, musei e teatri stanno chiudendo e presto potrebbero farlo anche intere città. Gli esperti avvertono che alcune persone che sospettano di aver contratto la malattia, anche nota come Covid-19, stanno proseguendo le loro attività quotidiane o perché sul lavoro non hanno accesso a permessi retribuiti o per via delle falle sistemiche del nostro sistema sanitario privatizzato. Molti di noi non sono sicuri di cosa fare o di chi ascoltare. Continua a leggere
Algoritmi facebook e libertà di ragionare
 Ci segnalano che il rilancio su Facebook della notizia pubblicata anche dal nostro sito che il portavoce del Ministero degli Esteri cinese abbia chiesto trasparenza di informazione agli USA sulla possibile presenza del virus COVID-19 in USA già nel novembre 2019 (VEDI NOTIZIE QUI) e (QUI), abbia prodotto come ammonimento il seguente messaggio.
Ci segnalano che il rilancio su Facebook della notizia pubblicata anche dal nostro sito che il portavoce del Ministero degli Esteri cinese abbia chiesto trasparenza di informazione agli USA sulla possibile presenza del virus COVID-19 in USA già nel novembre 2019 (VEDI NOTIZIE QUI) e (QUI), abbia prodotto come ammonimento il seguente messaggio.
USA TODAY, partner di Facebook nel Fact checking di notizie sul social network avrebbe verificato che la notizia è falsa: Secondo USA TODAY, “il Coronavirus si è originato in Cina e in nessun altro luogo”.
Seguono indicazioni e link cui attenersi nella pubblicazione di post su Facebook.
Si potrebbe dire che Facebook se la canta e se la suona. Continua a leggere






