cambiailmondo
Geopolitica
L’ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali – parte III

Processo di dedollarizzazione II
L’utilizzo delle principali valute: la supremazia decadente del Dollaro
Nell’intento di inquadrare all’interno di una cornice oggettiva la situazione della moneta statunitense, sia in relazione ai prematuri slanci verso l’imminente disarcionamento del Dollaro dal ruolo di asse portante del Sim (Sistema monetario internazionale), sia rispetto alle affermazioni di inattaccabilità della sua egemonia globale, procediamo ad analizzare il panorama valutario internazionale alla luce delle varie funzioni rivestite dalle principali monete.
Nel campo delle operazioni internazionali effettuate tramite coppie di valute attraverso il Forex1, secondo l’ultima inchiesta triennale della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bri), che considera l’interscambio da entrambi i lati, quindi su base 200, nel 2022 il Dollaro restava saldamente al vertice con l’88,5 delle operazioni in valuta estera (grafico 1), quota rimasta invariata dal 19892
Grafico 1: ruolo degli Usa e del Dollaro a livello mondiale. Periodo: 2° quadrimestre 2022

Ad ampia distanza seguivano l’Euro col 32 e la coppia Yen – Sterlina entrambi col 17, mentre lo Yuan, seppur in espansione rispetto allo 0 del 2007 arrivava a ricoprire solo il 7 del totale, sempre nel secondo semestre 2022 (grafico 2).
Grafico 2: quota di transazioni in Yuan nell’ambito del Forex fra 2007 e 2022. Fonte: Bri

Le sanzioni alla Russia spingono i Brics verso la dedollarizzanione delle transazioni
Le transazioni internazionali hanno tuttavia subito una brusca accelerazione verso la dedollarizzazione dall’inizio del 2022, soprattutto per quelle riguardanti i paesi del Brics, a seguito delle varie tranche di misure restrittive adottate contro la Russia. In particolare, ma non solo, ciò ha interessato principalmente l’interscambio fra Mosca e Pechino, il quale nel corso del 2023, in contemporanea con un cospicuo aumento del 26,4% del valore dei commerci, giunti al record assoluto di 240 miliardi di $, in base ai dati dell’Amministrazione generale delle dogane di Pechino3, ha registrato anche una rapida impennata delle transazioni in Yuan. Infatti, secondo quanto dichiarato dalla governatrice della Banca centrale russa, Elvira Nabiullina, la quota di esportazioni russe effettuate tramite la divisa cinese è passata dal 0,4% di due anni or sono al 34,5% di inizio 2024, mentre per ciò che concerne le importazioni, nello stesso arco di tempo, è salita dal 4,3% al 36,4%.
Quindi in soli due anni la moneta cinese è divenuta la più utilizzata dalla Russia nelle transazioni estere, con inevitabili riflessi sulla composizione delle riserve valutarie di Mosca, come ha esplicitamente affermato la governatrice stessa: “Fino al 2022, nelle nostre riserve c’era una quota significativa di Dollari ed Euro. Ciò era dovuto al fatto che i contratti di commercio estero erano in gran parte stipulati in queste valute. Ora, l’attività economica estera sta passando molto attivamente all’uso di altre divise, principalmente lo Yuan”4.
In pratica le sanzioni occidentali hanno determinato un doppio, seppur diversificato effetto boomerang a danno degli stessi committenti: i paesi europei nel suo complesso sono risultati penalizzati negli scambi commerciali sia con Mosca che con Pechino nel 2023, mentre gli Usa hanno principalmente subito una flessione nell’utilizzo della propria moneta nelle transazioni internazionali.
La ridefinizione della geografia dei commerci mondiali e dell’utilizzo delle valute, risultano tuttavia tendenze in atto su scala globale che vanno ben oltre i confini delle relazioni economiche fra Mosca e Pechino.
Negli ultimi due anni, infatti, gli scambi commerciali relativi a prodotti energetici raffinati, gas e petrolio sono stati effettuato in misura crescente con valute alternative al Dollaro. Un processo in rapida evoluzione sotto la spinta delle sanzioni e della determinazione dei Brics di perseguire una ridefinizione degli equilibri geoecenomici globali che ha portato nel 2023 a circa il 20% la quota del commercio globale di petrolio, la commodity più scambiata5, ad essere oggetto di transazioni in altre monete, compresi i Dirham emiratini e le Rupie indiane. New Delhi, infatti, grazie ad un accordo con Abu Dhabi finalizzato a regolare le loro transazioni in Rupie, principalmente petrolio, è divenuta nel 2023, secondo Mario Lettieri e Paolo Raimondi6, la seconda partner commerciale degli Emirati, con un interscambio totale in graduale avvicinamento ai 100 miliardi di $, e sta lavorando ad un’intesa con l’Arabia Saudita per regolare gli acquisti di petrolio in Rupie, oltre a stringere accordi con altri paesi per transazioni in valute nazionali. Ciò al netto del fatto che Riad dopo aver espletato tutti i passaggi formali per l’adesione al Brics prevista per il 1 gennaio 2024 insieme ad Iran, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Etiopia e Argentina, dopo il ritiro di quest’ultima ad opera di Milei il 29 dicembre 2023, non ha ancora ufficializzato l’ingresso nel blocco, restando in una fase di empasse7. Posizione attendista, in merito alla quale la leadership saudita dovrà sciogliere la riserva entro il prossimo vertice del Brics+8, previsto per ottobre a Kazan in Russia, garantendo o meno al propria presenza.
Sostanzialmente analoga la situazione per ciò che concerne l’utilizzo del Dollaro nell’ambito dell’intero interscambio commerciale fra soli paesi del Brics, nel cui contesto durante il 2023 il biglietto verde è stato ridimensionato ad appena il 28,7% del totale.
Una quota che con il recente ingresso nel Brics degli Emirati Arabi Uniti e dell’Iran, nel 2022 rispettivamente settimo e ottavo produttori mondiali di petrolio9, andrà con ogni probabilità incrementandosi nell’anno in corso, anche alla luce del fatto che i primi stanno tessendo la tela diplomatica con altri 15 paesi per promuovere gli scambi in monete nazionali e il secondo ne ha estrema necessità essendo stato soggetto a pesanti sanzioni da Trump a partire dall’agosto 2018, facendo carta straccia dell’accordo sul nucleare (Jcpoa) raggiunto da Obama con i vertici della Repubblica Islamica nel luglio del 2015, nell’ambito del quadro diplomatico detto P5+1 vale a dire Stati Uniti, Cina, Russia, Regno Unito, Francia e Germania 10.
La situazione valutaria relativa alle riserve monetarie e al mercato dei titoli di stato
Rispetto all’utilizzo delle monete in qualità di riserve valutarie, al cospetto di una situazione sostanzialmente analoga di attuale supremazia del biglietto verde, diversa risulta invece la dinamica registrata nel corso dell’ultimo ventennio, durante il quale il Dollaro ha subito un marcato ridimensionamento passando dal 72% del 2000 al 58,4% del 2023 (grafico 3), tuttavia a favore di monete di propri alleati geopolitici come il Dollaro australiano e quello canadese.
Grafico 3: quota di riserve delle Banche centrali in dollari 1995-2023. Fonte :Fmi

Viceversa, lo Yuan è salito da 0% di inizio millennio, quando la Cina non era ancora membro del Wto, al 2,6% dello scorso anno, una quota che seppur in leggera crescita appare ancora decisamente bassa per poter pensare di scalfire l’egemonia del biglietto verde (grafico 4). L’espansione della valuta cinese in questo campo risulta penalizzata, oltre che dalla sua mancata totale internazionalizzazione, dal fatto che per qualsiasi paese risulta problematico detenere riserve in valute diverse rispetto a quella in cui è stato denominato il proprio debito sovrano.
Grafico 4: quote delle 7 valute detenute come riserve monetarie delle Banche centrali fra 2016 e 2022. Dollaro in viola, Euro in verde chiaro, Sterlina inglese in verde scuro, Yen giapponese in grigio, Yuan cinese in nero, Dollaro australiano in rosso e dollaro canadese in giallo. Fonte: 11

Gli investimenti sul Dollaro sono ancora percepiti come un rifugio sicuro per i capitali anche per quanto riguarda il mercato dei Titoli di stato, nel cui contesto si registra ancora un netto predominio del biglietto verde grazie ai 23.000 miliardi di $ di Titoli del Tesoro Usa, un valore 11 volte superiore ai 2.000 $ di quello tedesco12.
Il ruolo preminente del Dollaro, in questo campo è supportato anche dall’imponente debito federale degli Stati Uniti che ad inizio 2024 ha raggiunto la stratosferica cifra di 34.000 miliardi di dollari, pari al 123,3% del Pil13, del quale, tuttavia, solo il 24% corrispondente a circa 8.100 miliardi di $ (grafico 5 – istogramma) è in mano a soggetti stranieri, sia governi che investitori privati.
Nonostante il disimpegno della Cina che, per motivi geopolitici e per ritorsione verso la guerra commerciale di Trump, ha alleggerito la propria posizione sui Treasury bond14 dal 15% del 2010 al 10% del 2023, e del Giappone sceso, da oltre il 35% del 2005 al 15% dello scorso anno (grafico 5 – diagramma), la disponibilità estera dei titoli di stato statunitensi, è cresciuta nel 2023 di 427 miliardi di dollari a beneficio di altri attori come Regno Unito, Canada, India e Francia15 (grafico 6).
Grafico 5: diagramma lineare quota di debito pubblico Usa detenuto da Giappone e Cina 2000-2023 (valori a destra). Istogramma: entità di debito pubblico in mani straniere (valori a sinistra)

Grafico 6: possessori internazionali di titoli di stato Usa confronto gennaio 2018 – marzo 2023

Il ruolo egemone dello Swift fra le piattaforme di pagamenti internazionali
Lo Swift, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunican (società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali), costituisce un sistema di pagamenti interbancari internazionali che, attraverso l’attribuzione di un codice ad ogni istituto bancario, consente di facilitare le transazioni finanziarie su piazze estere.
La piattaforma finanziaria in questione risulta controllata dalle Banche centrali di Belgio, dove ha la sede, Francia, Stati Uniti, Canada, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Giappone e Regno Unito ed ha lo scopo di consentire il pagamento diretto anche nel caso in cui i due soggetti coinvolti nella transazione non siano clienti dello stesso istituto bancario.
In base a quanto riportato nel sito ufficiale dello Swift16 attualmente vi sono collegate 11.600 istituzioni bancarie appartenenti a oltre 200 fra paesi e territori ed indubbiamente costituisce la piattaforma dominante nel sistema finanziario internazionale per il trasferimento di fondi.
La ripartizione geografica delle transazioni relativa al mese di gennaio del 2022, l’ultimo prima dell’escalation del conflitto in Ucraina e delle sanzioni occidentali ai danni di Mosca, presentava il seguente quadro: il 45,5% riguardavano Europa, Medio Oriente e Africa, il 40% Americhe e Regno Unito e il 14,5% Asia e Pacifico17.
A conferma della crescita del proprio ruolo nel contesto economico-finanziario internazionale, anche la Cina, ha proceduto alla strutturazione di una propria piattaforma denominata Cips, acronimo di Cross-Border Interbank Payment System (sistema di pagamento interbancario di pagamento) incentrata sullo Yuan e gestita dalla Banca centrale cinese, la People’s Bank of China (Bpc), la quale, tuttavia, nel 2020, secondo Lettieri e Benvenuti, non arrivava a coprire nemmeno lo 0,5% del volume delle transazioni internazionali18. Alla piattaforma cinese ad inizio 2022 aderivano 1.280 banche appartenenti a 103 paesi, fra le quali istituti europei, statunitensi, giapponesi, russi e africani e nel 2016 ha sottoscritto un accordo con lo Swift in modo potervi operare anche i soggetti che non hanno aderito al Cips.
Anche la Russia ha un proprio sistema di pagamenti il Spfs, acronimo di System for Transfert of Financial Messages (sistema per il trasferimento di messaggi finanziari) ma a differenza del Cips cinese viene utilizzato soprattutto per i regolamenti interni oltre che da alcune banche con sedi in Germania e Svizzera oltre a quelle di paesi dello spazio ex sovietico come Bielorussia, Armenia, Kazakistan e Kirghizistan, per un totale di 400 istituti di credito sempre ad inizio 2022.
L’utilizzo dello Swift come arma geopolitica
Risultando un sistema di pagamento sotto controllo esclusivamente occidentale, lo Swift con l’acuirsi delle tensioni internazionali è stato trasformato da semplice strumento finanziario, in parallelo col ruolo del Dollaro19, in un’arma di natura geopolitica in considerazione del fatto che le istituzioni bancarie che ne vengono escluse accusano gravi problematiche nell’attuare trasferimenti di fondi all’estero.
Il potere di comminare l’esclusione di determinate istituzioni bancarie dallo Swift è riservato agli istituti finanziari e alle autorità nazionali che le supervisionano. Ed stato proprio nell’ambito dei vari pacchetti sanzionatori imposti unilateralmente alla Russia senza approvazione dell’Onu a partire dal 23 febbraio 202220, che la terza tranche entrata in vigore il 2 marzo successivo, su input dei governi di Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea, ha disposto l’esclusione di 7 banche russe dallo Swift21. Mentre nel sesto pacchetto, approvato il 3 giugno, stessa sorte è stata riservata anche alla principale banca russa, la Sberbank, in parte di proprietà del colosso del gas Gazprom, alla Credit Bank of Moscow e alla Russian Agricultural Bank22. Tuttavia, i governi dei paesi membri dell’Ue non hanno escluso la terza banca russa, Gazprombank, in quanto viene utilizzata da Mosca per le transazioni energetiche e, per quel che ci riguarda, in particolare del gas dal quale dipendeva fino ad inizio 2022 oltre 40% del’totale dell’import dell’Ue23 e che nel 2023 ha continuato a coprire il 15% l’approvvigionamento estero comunitario24. Con l’inquietante paradosso che mentre abbiamo diminuito l’import di gas russo via conduttura acquistato con contratti pluriennali a basso costo, a causa delle sanzioni e del sabotaggio dei gasdotti del baltico, nei primi sette mesi del 2023 l’Ue, rispetto al corrispondente periodo del 2021, ha incrementato di ben il 40% (da 15 mln a 22 mln di mc) l’import da Mosca del sensibilmente più costoso GNL25.
A seguito della frattura geoeconomica apertasi fra Russia e paesi occidentali a causa dalle varie tranche di provvedimenti restrittivi, arrivati alla tredicesima il 23 febbraio 2024, e dal Piano REPowerEU del 18 maggio 2022, tramite il quale abbiamo deciso di rinunciare ameno sulla carta alle fonti e ai prodotti energetici russi, Mosca ha elaborato varie strategie per aggirare le sanzioni, cercando canali commerciali alternativi, soprattutto Cina e India, e utilizzando altre valute per regolare i pagamenti internazionali. Rispetto a quest’ultima problematica, le autorità russe si sono orientate principalmente verso l’utilizzo dello Yuan contribuendo ad aumentare il ruolo della divisa cinese nel panorama mondiale delle transazioni, una strategia non solo di natura economico-finanziaria ma anche, se non soprattutto, di carattere geopolitico. Conseguentemente la filiale moscovita della Industriale and Commercial Bank of China (ICBC), la principale banca mondiale con 400 milioni di clienti e 203 filiali estere, fra cui anche Milano26, dislocate in 40 paesi, ha sensibilmente aumentato il volume delle transazioni in Yuan fra Mosca e Pechino, in quanto collegata sia alla piattaforma cinese Cips che a quella russa Spfs, oltre che allo Swift27. Infatti negli ultimi 3 trimestri del 2022 la filiale moscovita dell’ICBC ha incrementato di oltre il 290% i depositi dei clienti e quasi 50 istituzioni bancarie vi hanno aperto un conto per poter operare con la Russia, aggirando di fatto le sanzioni occidentali28.
Il processo di dedollorazione, seppur in recente accelerazione, ha tuttavia un orizzonte ancora lontano per potersi completare, in quanto la maggior parte dei regolamenti dei flussi commerciali viene ancora effettuata tramite le valute dei paesi del G7 e in particolar in Dollari attraverso lo Swift. Infatti, a settembre dello scorso nell’ambito dello Swift, il Dollaro ricopriva una quota del 45,58% delle transazioni, l’Euro il 23,60%, la Sterlina il 7,32% e lo Yen il 4,20%, mentre lo Yuan seppur in crescita si attestava al quinto posto col 3,71%.
L’effettiva emancipazione del Brics+ dalla piattaforma sotto controllo occidentale potrà realizzarsi solo creando un proprio sistema multilaterale di pagamenti basato sulle proprie divise nazionali. Ed è proprio in questa ottica che a partire dal 2018 si stanno impegnando nella realizzazione del progetto Brics Play basato sull’utilizzo di tecnologie innovative come le piattaforme blockchain29 e le valute digitali ufficiali controllate della Banche Centrali (CBCD30), fra le quali lo Yuan digitale, entrato in vigore ad inizio 2022, oltre a numerose altre che si trovano nelle diverse fasi di progettazione e sperimentazione, soprattutto appartenenti a potenze emergenti come Russia, Arabia Saudita e Sudafrica (carta 1). Infatti il Brics Pay è stato predisposto in modo da poter utilizzare tutte le monete digitali dei paesi del Brics+31.
Carta 1: la situazione delle CBDC nei vari paesi.

Fonte: statista https://it.benzinga.com/2023/06/26/cbdc-quali-rischi-investitori-crypto/
Conclusioni
L’attuale situazione internazionale relativa all’impiego delle principali valute, per ciò che concerne le transazioni internazionali, le riserve delle Banche centrali e il mercato dei titoli di stato, come emerso in precedenza, presenta dunque carattere di fluidità e complessità che, a nostro avviso, per essere efficacemente inquadrata necessita di tenere in considerazione oltre alle dinamiche in atto anche la panoramica generale globale.
In considerazione di ciò, il quadro descritto in sintesi dall’agenzia britannica Reuters “Le Banche centrali stanno sperimentando una più ampia varietà di asset, fra cui obbligazioni di società private (corporate bonds. ndr), titoli di stato (government bonds), beni immobiliari, oro e ovviamente altre valute”, al pari di quello dall’amministratore delegato di Toscafund Hong Kong, Mark Tinkter, “Questo è il processo in corso. Il Dollaro verrà utilizzato sempre di meno nel sistema globale”32, a nostro avviso, se, da un lato, risultano entrambi centrati in relazione alle dinamiche in atto, dall’altro, non fotografano esaustivamente nel suo complesso la situazione valutaria mondiale attuale.
Dalla nostra analisi emerge come in un contesto in cui la posizione del Dollaro risulti al momento ancora maggioritaria, la sua parabola discendente sembra inesorabilmente esser stata imboccata, come ha efficacemente inquadrato la Banca centrale indiana (Reserve bank of India – Rbi): “Sembra, quindi evidente che mentre il dominio rimane per ora incontrastato, esso ha iniziato ad erodersi lentamente e in futuro l’ordine economico dovrà evolversi per guardare oltre la valuta statunitense”. Una prospettiva sostenuta anche dalla maggior parte degli analisti più qualificati, i quali prevedono che il Dollaro, almeno per qualche lustro, non verrà scalzato, principalmente per mancanza di competitor effettivi33, dalla leadership globale da altre valute, premunendosi, tuttavia, di specificare che il panorama valutario mondiale è destinato a subire un inevitabile riequilibro.
Lo scenario che potrebbe delinearsi nel Sistema monetario internazionale (Sim), nel cui ambito il Dollaro a fine 2022 rappresentava ancora il 56% degli investimenti finanziari internazionali e il 58,4% delle riserve delle Banche centrali34 (tabella 1), non presagisce tanto il passaggio di leadership a vantaggio di un’altra divisa, quanto, nel contesto della ridefinizione degli equilibri geoeconomici e geopolitici sospinti in senso multipolare dal Brics, la formazione di un ordine valutario internazionale basato su un nuovo assetto “multy-currency“35.
La tendenza, già in atto da alcuni anni, e in accelerazione dal febbraio 2022, indica che le Banche centrali stanno operando in modo da adeguare i propri asset monetari verso un paniere diversificato di valute, sotto la spinta dell’evoluzione strutturale del commercio mondiale a favore dei paesi emergenti e della riorganizzazione per aree geoeconomiche “amichevoli”.
Tabella 1: quota attuale di utilizzo del dollaro nelle forme di impiego
| Tipologie di impiego | Dollaro 2023 |
| Investimenti finanziari | 56,0% |
| Riserve delle Banche Centrali | 58,4% |
| Forex (anno 2022) indice su base 200 | 88,5 |
| Swift (settembre 23) | 45,58% |
Il processo di dedollarizzazione dell’economia e del Sistema monetario internazione è destinato a proseguire, tuttavia attraverso un non lineare incedere, le cui eventuali accelerazioni potrebbero derivare da eventi internazionali particolarmente gravi sia di carattere geoeconomico/finanziario che geopolitico/militare.
Soprattutto ulteriori tensioni geopolitiche o, addirittura, rotture dell’ordine economico internazionale, come le sanzioni alla Russia e il piano comunitario REPoweEU36 o di un inizio di disimpegno dagli asset in Dollari da parte dei grandi fondi di investimento, BlackRock e Vanguard in primis37, finiranno per imprimere nuovo slancio allo sganciamento dal Dollaro. In tal caso potrebbe formarsi, secondo Reanud Lambert e Dominique Plihon, un’area “Indipendente dal Dollaro” per gli stati sotto sanzioni statunitensi. In tale contesto, come afferma a tal proposito l’autorevole economista James K. Galbraith: “La Cina assumerebbe un ruolo chiave tra i due sistemi (monetari. ndr), (divenendo. ndr) punto di fermo di una struttura multipolare”.
Washington potrebbe, quindi, risultare lei stessa penalizzata dall’estremizzazione dell’utilizzo a fini politici del Dollaro, come rileva anche Galbraith: “Se Pechino dovesse a sua volta essere oggetto di decisioni così severe (come quelle imposte a Mosca. ndr), allora potrebbe prodursi una rottura in grado di dividere il mondo in due blocchi isolati”. Un passo azzardato che, visto l’enorme interscambio commerciale38 e finanziario in essere fra Washington e Pechino, gli Stati Uniti valuteranno sicuramente a fondo prima di compiere, in quanto innescherebbe ripercussioni negative in primis sui propri titoli di stato.39
“La multipolarità monetaria perseguita dal Brics, (parallelamente a quella geopolitica e geoeconomica. ndr)”, conclude Galbraith, “Potrebbe essere negativa per l’oligarchia, ma vantaggiosa per la democrazia, per la protezione del pianeta e per il bene comune. Da questo punto di vista non arriverà troppo presto. Le grandi trasformazioni dell’ordine economico mondiale sopraggiungono solo in occasione di crisi estrema”.
L’accelerazione del processo di ridimensionamento della supremazia globale del Dollaro risulterebbe, dunque, più interconnessa al livello di spregiudicatezza delle linee di politica internazionale di Washington, che alla reali attuali potenzialità del Brics di realizzare a breve un ordine monetario internazionale alternativo. Come già ebbe a presagire nel marzo 2022, all’indomani delle prime misure restrittive, il Vice direttore generale del Fmi, Gita Gopinath: “Le sanzioni contro la Russia potrebbero erodere il dominio del Dollaro incoraggiando blocchi di trading più piccoli in altre valute”. Anche perché il Brics nel suo complesso non sembra nelle condizioni di riuscire a portare a compimento il progetto di sostituzione del Dollaro con un’altra valuta a corso legale, essendo al momento orientato verso l’istituzione di una unità di conto40, più che di una moneta comune.
Il futuro Sistema Monetario Internazionale potrebbe anche assumere un assetto multipolare strutturato in “zolle valutarie”, ciascuna dominata da una singola divisa che andrebbe a ricalcare quello geopolitico globale attualmente in fase di ridefinizione, il quale sembrerebbe orientato a delinearsi in “placche geopolitiche e geoeconomiche” tendenzialmente assoggettate all’influenza di una potenza macroregionale
Indipendente dai connotati che assumerà in futuro il Sistema monetario internazionale, i tempi di sviluppo della curva di flessione della supremazia globale del Dollaro risultano, quindi in primis, nelle mani, o per meglio dire nelle politiche, delle future amministrazioni di Washington a partire da quella che uscirà dalle ormai prossime presidenziali del novembre.
Andrea Vento – 29 aprile 2024
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati (Giga)
NOTE:
1Il Forex è il mercato dove avvengono tutte le negoziazioni che hanno per oggetto le differenti valute. Non a caso, il termine stesso Forex deriva dall’inglese FOReign EXchange market. Ha origini antiche e nasce da esigenze commerciali di cambiare una valuta per un’altra, al fine di concludere transazioni. Il Forex è il mercato delle valute e ad essere scambiate non sono le singole valute, come spesso si dice, ma coppie di valute. Per esempio, non è possibile vendere dollari e basta. Bisogna vendere dollari e comprare, contemporaneamente, un’altra valuta, ad esempio euro. Nel Forex si ragiona, quindi, in termini di coppie di valute: ad esempio, EUR/USD sta ad indicare il cambio euro/dollaro.
https://www.prestitionline.it/guide-prestiti/domande-frequenti/cos-e-il-forex-e-come-funziona
2 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/
3 https://www.agenzianova.com/a/65a10ef4d46c74.84366983/4764358/2024-01-12/cina-russia-interscambio-commerciale-tocca-record-di-240-miliardi-di-dollari-nel-2023
4 https://www.agenzianova.com/news/russia-la-governatrice-della-banca-centrale-lo-yuan-cinese-ha-rimpiazzato-il-dollaro-nelle-nostre-operazioni/
5 Il commercio del petrolio ammonta a circa 1/5 del valore dell’interscambio mondiale complessivo
6 Nei Brics non si usa più il dollaro di Mario Lettieri e Paolo Raimondi. https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434
7 https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/L-Arabia-Saudita-sta-ancora-considerando-l-adesione-ai-BRICS-dicono-le-fonti-45767507/
8 Brics+ è nuova denominazione del gruppo allargato, dopo gli ingressi del 1 gennaio 2024
9 https://www.energiaitalia.news/news/petrolio/petrolio-la-classifica-dei-20-piu-grandi-produttori-mondiali/25339/
10 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/iran-tornano-vigore-le-prime-sanzioni-usa-21095
11https://www.groupama-am.com/it/article/la-progressiva-de-dollarizzazione-delleconomia-mondiale/
12 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/
13 https://www.italiaoggi.it/news/il-debito-usa-e-sempre-piu-alto-2624189
14 I Treasury Bond (T-Bond) sono titoli del debito pubblico statunitense di lungo termine
15 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/
16 https://www.swift.com/about-us
17 https://www.fondopriamo.it/blog/priamo/sistema-swift
18 https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434
19 Saggio: L’ascesa dei Brics parte II: La complessa questione della dedollarizzazione di Andrea Vento (mettere link)
20 La prima tranche di sanzioni occidentali è stata introdotta un giorno prima l’avvio dell’Operazione speciale russa in Ucraina a conferma della finalità di natura geoeconomica tesa a creare una frattura fra Ue e Russia a beneficio Usa
21 Nel dettaglio il provvedimento sanzionatorio ha colpito: VTB, Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vneseheconombank (VEB) https://www.confindustria.it/home/crisi-ucraina/sanzioni
22 https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/03/russia-s-aggression-against-ukraine-eu-adopts-sixth-package-of-sanctions/
23 https://www.agi.it/estero/news/2022-01-29/ucraina-ue-ridurre-dipendenza-gas-da-russia-15406821/
24 https://www.shipmag.it/europa-diminuisce-la-domanda-di-gas-ma-limport-dalla-russia-resta-alto/
25 https://www.rinnovabili.it/mercato/politiche-e-normativa/gnl-dalla-russia-ue/
26 https://milan.icbc.com.cn/it/column/1438058492186738925.html
27 https://wise.com/it/swift-codes/ICBKCNBJNTG
28 https://www.geopolitica.info/esclusione-russia-swift-internazionalizzazione-renminbi/
29 https://blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significato-applicazioni
30 Central Bank Digital Currency: può essere definita come la rappresentazione digitale di una moneta nazionale, intesa come moneta a corso legale, emessa e gestita da un’istituzione sovrana come la banca centrale. Si tratta quindi di una passività bancaria denominata in un’unità di conto esistente, accessibile a tutti, che funge sia da mezzo di scambio sia da riserva di valore. A differenza delle criptpvalute e delle stablecoin, una CBDC è quindi direttamente sostenuta da un governo e rappresenta una passività della banca centrale.
Fonte: https://civitas-schola.it/2022/02/09/valute-digitali-emesse-dalla-banca-centrale/
31 https://www.italiaoggi.it/news/nei-brics-non-si-usa-piu-il-dollaro-2627434
32 https://www.reuters.com/markets/currencies/end-king-dollar-forces-play-de-dollarisation-2023-05-25/
33 lo Yuan è la moneta che in teoria potrebbe sostituire il dollaro a causa del suo ruolo crescente nell’economia mondiale (la Cina rappresenta il 18% del PIL mondiale). Tuttavia, le autorità cinesi non accetteranno mai di non controllare la loro bilancia dei capitali, il che rende lo Yuan di fatto incompatibile con un ruolo di valuta di riserva.
34 Dati diramati da Christophe Morel, chief economist di Groupama Asset Management, https://esgnews.it/focus/opinioni/la-progressiva-de-dollarizzazione-delleconomia-mondiale/
35 Vale a dire multi valutario
36 Piano dell’Ue finalizzato al superamento delle forniture energetiche dalla Russia e alla ridefinizione della geografia degli approvvigionamenti comunitari a beneficio di altri paesi come Usa, Qatar, Norvegia, e Algeria
37 Tesi sostenuta dal prof. Alessandro Volpi nella trasmissione “Scommesse al posto del Welafre” di Ottolina tv a partire dal minuto 36. https://www.youtube.com/watch?v=zic9zuZDPTA&ab_channel=OttolinaTV
38 Nel 2022, ultimo anno con dati completi a disposizione, l’interscambio complessivo Cina – Usa, nonostante la guerra commerciale, secondo i dati ufficiali del Bureau of Economic Analysis ha raggiunto la cifra record di 690,6 miliardi di $, superando il precedente primato di 659 miliardi del 2018. L’export cinese negli Usa è risultato di 536,8 miliardi di $ e quello statunitense in Cina 153,8 con un saldo a favore di Pechino di 383 miliardi. https://www.agenzianova.com/a/63e320597ef4b1.11519917/4240576/2023-02-08/usa-cina-record-scambi-commerciali-nel-2022-690-miliardi-di-dollari-nonostante-tensioni
Nel 2023 l’interscambio commerciale Cina – Usa si è ridotto per la prima volta dal 2019 attestandosi a 644,4 miliardi $
39 James K. Galbraith “The dollar system in a multi-polar world” – International Journal of Political Economy vol.51, n°4, New York 2022
40 Il progetto è stato recentemente proposto dalla Russia e dal Brasile in ambito Brics.
Unità di conto: uno strumento comune per misurare il valore delle transazioni economiche tramite la fissazione dei prezzi e la contabilizzazione dei debiti e dei crediti, associati al passaggio di proprietà dei beni o delle attività senza un contestuale regolamento in moneta
https://www.treccani.it/enciclopedia/unita-di-conto_(Dizionario-di-Economia-e-Finanza)
Gli Usa e il “metodo Giacarta”: il massacro delle popolazioni come politica estera
di Piero Bevilacqua

Chi legge il libro di Vincent Bevins, Il metodo Giacarta, La crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro mondo (Einaudi, 2021) ne uscirà con una visione rovesciata della storia mondiale dopo il 1945, e con l’animo sconvolto. È successo anche a me, storico dell’età contemporanea, e testimone del mio tempo, a cui tanti fatti e vicende qui raccontate erano noti. L’autore è un prestigioso giornalista americano, che è stato corrispondente del Washington Post, del Los Angeles Times, del Financial Times, ha scritto per il New York Times e tanti altri giornali americani e inglesi. Già questa appartenenza al giornalismo USA, per quel che racconta di gravissimo in danno dei governi del proprio paese, costituisce una prima garanzia di imparzialità e obiettività. D’altra parte non sarebbe la prima volta. Quello dei giornalisti americani che scavano nelle carte segrete e denunciano le malefatte dei loro governanti è un fenomeno non raro, che fa onore a quei professionisti. È sintomatico dell’onestà di fondo dell’animo e della cultura antropologica di gran parte del popolo americano, comunque ormai ampiamente manipolati. È così clamorosa la contraddizione con gli ideali democratici della loro formazione, che non pochi giornalisti, allorché scoprono azioni omicide segrete del loro Stato, sono spinti a una ribellione morale che li porta a intraprendere vaste indagini e a scrivere libri come questi.
Ma l’autorevolezza del Metodo Giacarta si fonda sullo scrupolo scientifico di Bevins, sulla vastità e rilevanza documentaria delle sue fonti, che sono carte desecretate degli archivi americani e di vari paesi del mondo, pubblicazioni di altri studiosi, registrazioni dirette di riunioni segrete, telegrammi, testimonianze rese dai protagonisti e soprattutto dai sopravvissuti ai massacri ecc. Grazie a questi materiali l’autore ci fa entrare spesso direttamente nel tabernacolo del potere americano, facendoci assistere a conversazioni inquietanti, come quella del 1963, in cui John Kennedy ordina agli uomini della sua amministrazione, che lo informano sulla condotta non gradita del presidente del Vietnam del Sud, Ngo Dinh Diem: «fatelo fuori». «Diem venne rapito insieme a suo fratello. I due vennero uccisi a colpi i pistola e a pugnalate nel retro di un furgone blindato». E non meno sconcertanti sono le informazioni che si ricevono su personaggi ai quali, ad esempio, è andata per decenni la nostra simpatia umana e politica. Non si può rimanere indifferenti quando si apprende che dopo il fallito tentativo USA di invadere Cuba alla Baia dei Porci, nel 1961, Robert Kennedy «suggerì di far esplodere il consolato americano per giustificare l’invasione».
Ma in che cosa consiste il rovesciamento della storia ufficiale, da tutti accettata, degli ultimi 70-80 anni di storia mondiale? In breve, a partire dal dopoguerra, gli USA mettono in atto una strategia sempre più perfezionata per controllare e dominare economicamente e militarmente il maggior numero possibile dei paesi che si stavano liberando del colonialismo della Gran Bretagna, della Francia e dell’Olanda. Giova ricordare che in quei paesi, quasi ovunque, si affermano in quegli anni forze politiche nazionaliste che tentano di recuperare e gestire le proprie risorse, con processi di nazionalizzazione, ad esempio delle compagnie petrolifere (come fa in Indonesia il presidente Sukarno), delle miniere, delle piantagioni ecc. A queste riforme di solito si accompagnano programmi di alfabetizzazione della popolazione, costruzione di scuole pubbliche, distribuzione delle terre ai contadini, riforme agrarie. Tali strategie riformatrici di governi che intendono affacciarsi allo sviluppo economico dopo la guerra, seguono una politica equidistante tra Washington e Mosca, anche se talora sono appoggiati dai partiti comunisti nazionali. Ma essi sono guardati con sospetto e ostilità dagli USA che tramano segretamente per il loro rovesciamento. Talora è proprio la scoperta di tale ostilità che porta i dirigenti nazionalisti a guardare con favore e a chiedere appoggio a Mosca o a diventare comunisti, come accadde a Fidel Castro, dopo la fallita invasione americana di Cuba nel 1961.
Spesso a dare il via ai progetti dei colpi di stato sono le pressioni sulle amministrazioni americane delle compagnie petrolifere, o dei grandi proprietari terrieri, che vedono anche semplicemente contrastato il loro vecchio modello di sfruttamento coloniale delle risorse locali. Nel 1954 in Guatemala è il caso della United Fruit Company, sospettata di frodare il fisco. La pretesa del Governo guatemalteco di far rispettare gli obblighi fiscali alla ditta monopolista costò cara al Guatemala. Dopo due falliti colpi di Stato, «la Cia piazzò casse di fucili con l’effige della falce e del martello in modo che fossero “scoperti” e costituissero la prova della infiltrazione dei sovietici». Da li cominciò l’ingerenza armata degli USA, con varie vicende e campagne di terrorismo psicologico, di diffamazione dei comunisti come agenti di Mosca, a cui qui non possiamo neppure accennare. Il colpo di Stato si concluse con l’insediamento di Castillo Armas, il favorito degli USA. «In Guatemala tornò la schiavitù. Nei primi mesi del suo governo, Castillo Armas istituì il Giorno dell’anticomunismo e catturò e uccise dai tre ai cinquemila sostenitori di Arbenz» (il presidente deposto, che aveva avviato la riforma agraria).
Qui davvero è impossibile dar conto delle trame ingerenze messe in atto da tutte le amministrazioni USA degli ultimi 70 anni per controllare i paesi che uscivano dalle antiche colonizzazioni europee, spesso con l’aiuto del Regno Unito, maestro secolare di dominio coloniale, che in tanti casi rese onore alla sua tradizione sanguinaria. Lo fecero spesso con colpi di Stato poche volte falliti, ma spesso ripetuti fino al finale cambio di regime: in Iran (1953), Guatemala (1954), Indonesia (1958 e 1965), Cuba (1961), Vietnam del Sud (1963), Brasile (1964), Ghana (1966), Cile (1973) e un numero incalcolabile di sabotaggi, uccisioni, condizionamenti delle politiche del vari governi. Senza mettere nel conto la guerra contro il Vietnam, scatenata con il falso pretesto dell’“incidente del Tonchino”, che provocò 3 milioni di morti, oltre ai vasti bombardamenti con gli elicotteri dei villaggi contadini «in Cambogia e Laos [dove] ne morirono molti di più». Ricordo che dopo il colpo di stato in Brasile non ci furono più elezioni per 25 anni e la violenta dittatura di Suharto, in Indonesia, durò 32 anni.
Gli strumenti di queste politiche erano – come scrive lapidariamente Bevins – «esercito e finanza». I capi di tanti eserciti nazionali si erano formati spesso nelle scuole militari degli USA, e comunque venivano corrotti da ingenti finanziamenti americani, donazioni e vendite di armi, manovrati dalla Cia. In tante realtà si creò una scissione tra i governi indipendenti, che spesso venivano economicamente strozzati dai sabotaggi commerciali e finanziari, e i sistematici finanziamenti segreti forniti agli eserciti. Ma il cemento ideologico più determinante, e forse in assoluto la leva più potente che rese possibile l’intero progetto, fu la propaganda anticomunista, con tutto il repertorio di orrori fasulli di cui venivano ritenute responsabili le forze che vi si ispiravano. La minaccia del comunismo, oltre ad essere una formidabile arma di controllo sociale interno dei gruppi dirigenti americani, fu il fondamento psicologico e culturale, potremmo definirlo egemonico, su cui i vari golpisti riuscirono a coinvolgere nei massacri anche pezzi di popolazione civile. Uno strumento di persuasione di massa reso possibile dal fatto che in quasi tutti i paesi “attenzionati” dagli USA, la stampa era in mano ai grandi proprietari terrieri, o alle compagnie petrolifere, ostili alle riforme agrarie e alle nazionalizzazioni, in grado di imbastire campagne di falsificazione su larga scala, fondate su racconti di storie inventate, riprese dalle radio, talora trasformati in film e documentari.

Che cosa è il Metodo Giacarta? In breve. L’Indonesia, il quarto paese più popoloso del pianeta, che ospitava il terzo più grande Partito comunista del mondo (PKI), sostenuto da milioni di militanti, non poteva restare indipendente. Dopo vari tentativi falliti, uno riuscì e fu il più sanguinoso dei piani messi in atto dagli USA. Il pretesto definitivo fu un oscuro episodio ancora oggi non chiarito. Alcuni militari sequestrarono cinque generali dell’esercito indonesiano che poi furono trovati uccisi. Fu lanciata allora una campagna su larga scala di terrore psicologico, attraverso la stampa, la radio, i comizi. Venne sparsa la voce che i cinque uomini fossero stati oggetto di sevizie, mutilati dei genitali e poi massacrati, mentre alcune donne danzavano nude intorno a loro, svolgendo riti satanici. Nel 1987, quando tutto era ormai dimenticato, venne alla luce che la storia era un falso, i generali, secondo l’autopsia fatta eseguire allora da Suharto, il golpista a servizio degli USA che estromise il presidente Sukarno, aveva rivelato che erano tutti morti per colpi di arma da fuoco, eccetto uno, ucciso da una lama di baionetta, probabilmente durante il sequestro nel suo appartamento. Quel che seguì a Giacarta e in tutte le isole dell’arcipelago, dopo quella provocazione e quella campagna di caccia ai terroristi comunisti, è difficile da immaginare e da raccontare: «Le persone non venivano ammazzate nelle strade, non venivano giustiziate ufficialmente, le famiglie non erano sicure che fossero morte: venivano arrestate e poi scomparivano nel cuore della notte». Solo giorni dopo, come si vide ad esempio nel fiume Serayu, «gli omicidi di massa divennero evidenti: i corpi ammassati erano così tanti da ostacolare il corso del fiume e il tanfo che emanavano era orribile». In proporzione agli abitanti, l’isola che che subì la quota maggiore di uccisioni fu Bali, il 5% della popolazione, oltre 80 mila persone finite a colpi di machete. Non andò bene alle indonesiane: «Circa il 15% delle persone prese prigioniere furono donne. Vennero sottoposte a violenze particolarmente crudeli e di genere», ad alcune «tagliarono i seni o mutilarono i genitali; gli stupri e la schiavizzazione sessuale erano diffusi ovunque». Alla fine i morti complessivi, secondo calcoli necessariamente sommari, si aggirarono tra 500 mila e 1 milione di persone, mentre un altro milione venne rinchiuso nei campi di concentramento. Il PKi, cui non poté essere addebitata nessuna sommossa o violenza, venne sterminato. A compiere i massacri furono i militari indonesiani, le squadre armate dei proprietari terrieri, bande di persone comuni assoldate o sobillate dalla propaganda. «Le liste delle persone da uccidere non furono fornite all’esercito indonesiano soltanto dai funzionari del governo degli Stati Uniti: alcuni dirigenti di piantagioni di proprietà americana diedero i nomi di sindacalisti e comunisti “scomodi” che poi furono uccisi». Più tardi il Tribunale internazionale del Popolo per il 1965 convocato all’Aja nel 2014, dichiarò i militari indonesiani colpevoli di crimini contro l’umanità, e stabili che il massacro era stato realizzato allo scopo di distruggere il Partito comunista e «sostenere un regime dittatoriale violento» e che esso venne realizzato con il supporto degli USA, del Regno Unito e dell’Australia. Dopo il 1965 il Metodo Giacarta venne teorizzato da molti dirigenti filoamericani dell’Asia e dell’America Latina e usato anche come parola d’ordine con cui venivano terrorizzati i dirigenti comunisti e i politici nazionalisti che proponevano riforme e nazionalizzazioni. Venivano minacciati facendo circolare la voce: «Giacarta sta arrivando» .
Alcune considerazioni per concludere. Noi conosciamo da tempo molte delle operazioni, spesso ben documentate, condotte dagli USA in giro per il mondo almeno a partire dal dopoguerra. Nel voluminoso William Blum, Il libro nero degli Stati Uniti (Fazi, 2003, ed. orig. Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Sine World War II, 2003, che meglio rispecchia contenuto del volume e intenzioni dell’autore), se ne trova, da oltre 20 anni, un repertorio vastissimo e di impeccabile serietà storiografica. Ma il libro di Bevins ha qualcosa in più. Esso non mostra soltanto come gli USA abbiano condotto una politica estera fondata sulla violazione sistematica del diritto internazionale, spesso calpestando il diritto alla vita di milioni di persone. Non è solo questo, che sarebbe sufficiente per illuminare di luce meridiana le ragioni dell’attuale “disordine” mondiale. Il Metodo Giacarta mostra che cosa ha prodotto quella guerra segreta, che ha impedito l’emancipazione dei popoli usciti dal dominio coloniale e la nascita di un terzo polo mondiale dei paesi cosiddetti “non allineati”: cioè equidistanti rispetto a Washington e Mosca. Il grande progetto di mutua cooperazione avviato con la Conferenza di Bandung nel 1955, di cui Sukarno era stato uno dei protagonisti, si dissolse. I paesi del Sud del mondo vennero ricacciati nella loro subalternità che in tanti casi si è protratta fino quasi ai nostri giorni.
Perciò Bevins può scrivere, alludendo ai colpi di stato in Brasile e Indonesia: «La cosa più sconvolgente, e la più importante per questo libro, è che i due eventi in molti altri paesi portarono alla creazione di una mostruosa rete internazionale volta allo sterminio di civili – vale a dire al loro sistematico omicidio di massa – e questo sistema ebbe un ruolo fondamentale nel costruire il mondo in cui viviamo oggi». È, infatti, il nostro tempo che questo libro rende comprensibile. Alla luce di quanto accaduto, le guerre intraprese dagli USA, da soli o con la Nato, ispirate alla retorica delle lotta al terrore o all’esportazione della democrazia, in Jugoslavia, Afganistan, Iraq, Libia, Siria e ora in Ucraina, non sono una svolta aggressiva della politica estera USA nel nuovo millennio, ma la continuazione coerente del perseguimento del proprio dominio globale, da mantenere con ogni possibile mezzo.
Il popolo russo, Putin, la democrazia
di Piero Bevilacqua

Pensare con idee ricevute. E’ davvero stupefacente leggere o ascoltare intellettuali e studiosi democratici e di sinistra, talora di sinistra avanzata o radicale (cioè di sinistra, ma il termine è stato infamato dal cosiddetto centro-sinistra) che ancora oggi, dopo due anni di guerra in Ucraina, dopo tutte le rivelazioni di fonti americane, le ricostruzioni storiche dei precedenti che hanno preparato quel conflitto, continuano a ripetere lo slogan << la brutale invasione russa>> , <<l’occupazione violenta della Crimea>>, ecc. Gli stessi stereotipi e retoriche si ripetono per il massacro in corso nella martoriata Gaza. I combattenti di Hamas sono terroristi perché hanno ucciso civili israeliani con il progrom del 7 ottobre (cosa, ahimé, terribilmente vera e ovviamente da condannare, ma non bisognerebbe mai dimenticare la storia che la precede e predispone) mentre i soldati di Israele che di civili palestinesi, e soprattutto di bambini, ne hanno ucciso e ne vanno ammazzando un numero spaventosamente superiore, restano soldati. Intendiamoci, la guerra è sempre un errore, è l’ingresso al più grande degli orrori. Quindi condanniamo quella scelta di Putin. Ma chi non riconosce che la Russia è stata trascinata in quel massacro è persona non informata dei fatti.
Svolgo le considerazioni che seguono non solo per il dispiacere che provo a sentire anche tanti amici e studiosi di valore ripetere queste espressioni che sono il calco della vulgata occidentale, ma perché ovviamente tale subalternità interpretativa all’informazione corrente indebolisce gravemente l’opposizione politica all’atlantismo, che ci chiama alla guerra, all’involuzione antidemocraitca dell’UE, frena l’azione a favore delle trattative e della pace. Le svolgo anche perché mi vado convincendo di un fenomeno culturale che meriterebbe di essere approfondito e che qui accenno appena.Le sempre più spinte specializzazioni scientifiche del nostro tempo – per cui chi si occupa di sociologia finisce col sapere tanto del suo specifico campo sociologico, ma poco del resto, e così chi si occupa di fisica, di diritto, economia, ecc – espone la mente di tanti studiosi a dipendere, per la propria visione della situazione politica mondiale, dalla idee circolanti e inverificate elaborate dai media dominanti. Media, come sappiamo, che orchestrano campagne di persuasione sistematiche e di vasta portata ormai da decenni. Se non si conoscono in maniera circostanziata le questioni, la comodità di avere, con poco sforzo e a portata di mano, una spiegazione semplice e rassicurante fa perdere la libertà di un giudizio indipendente. Credo di poter parlare anche a nome personale. Chi conosce un po’ la mia biografia intellettuale sa che non mi sono mai rinchiuso nella mia specializzazione di storico. Eppure, anche io ero convinto di tante verità che erano idee ricevute accettate passivamente, spesso purissime menzogne. Superate solo dopo aver studiato su libri e documenti come sono andate realmente le cose. Purtroppo bisogna constatare che non si possono capire anche i gravi fatti del nostro tempo se ciascuno non compie uno sforzo supplementare di studio e di analisi, fuori dal proprio specialismo e non confidando nel giornalismo corrente. Troppo potenti e ben confezionate sono le falsificazioni che si respirano nell’aria per restare indenni. Quante prove ulteriori noi italiani dobbiamo avere, per come è stata raccontata la guerra in Ucraina, per riconoscere che i nostri media sono una fabbrica di contraffazioni della realtà? Senza, dunque, uno sforzo di documentazione supplementare si resta vittime di una versione costruita da interessi potenti.Perché forse mai, come oggi, le élites dominanti sono in grado di sovrapporre alla realtà effettiva la loro manipolata narrazione, puntello fondativo del loro dominio, imponendola come un qualunque seducente prodotto di consumo.
Un’altra ragione di stupore è l’evidente pregiudizio antirusso che in Italia circola in ogni canto di strada.E il fenomeno, quando vede protagonisti sinceri democratici, è davvero incomprensibile o comprensibile assai bene, quale prova della forza del punto di vista americano che è diventato anche il nostro.Ma come facciamo a giudicare la Russia prescindendo completamente dal popolo russo, dalla sua storia, dai sacrifici immani che credo nessun popolo ha dovuto sostenere in età contemporanea? Come può accadere che c’è così poca empatia e curiosità storica disinteressata per la sua storia? Nessuno trae ragione di ammirazione da quel che questo popolo è stato in grado di fare per difendere il proprio paese da forze sovrastanti? Chi si ricorda che i russi hanno dovuto dare alle fiamme Mosca, la loro amata città, per poter resistere all’invasione dell’esercito napoleonico? Qualcuno rammenta battaglia di Stalingrado, la carneficina urbana durata quasi 6 mesi che ha inflitto la più grave sconfitta strategica all’esercito di Hitler? Quell’esercito che nessuna potenza europea aveva potuto fermare? Uno sforzo bellico che costò alla Russia circa 20 milioni di morti. Oggi nell’immaginario collettivo americanizzato sono stati gli USA a vincere la guerra, cancellando la vittoria russa a Stalingrado, dimenticando che l’Armata Rossa è arrivata Berlino, nel cuore dell’invincibile Reich, nell’aprile del 1945, precedendo addirittura gli eserciti alleati. Se la Russia fosse crollata Hitler avrebbe molto probabilmente vinto la guerra e avrebbe imposto all’Europa il suo feroce dominio. Chi ha liberato i lager dove si era consumato l’olocausto? Eppure persino un comico geniale come Benigni ha messo le divise americane ai soldati che entrano nei campi di concentramento ne La vita è bella.
La rivoluzione d’Ottobre
Meno stupore desta l’oblio o perfino la dannazione della rivoluzione d’Ottobre. Essa viene fatta sparire sotto la facile demonizzazione dello stalinismo e dei suoi crimini, sotto la burocratizzazione elefantiaca dello stato russo del dopoguerra, sino alla sua finale dissoluzione nel 1991. Sappiamo quanto diffusa sia l’opinione, soprattutto nel campo un tempo di sinistra, che quella vicenda sia stata nient’altro che un unico e prolungato errore. Eppure non c’è giudizio più superficiale ed erroneo di questo. La rivoluzione del 1917, la prima rivoluzione proletaria della storia, a dispetto dei suoi errori e del sangue fatto scorrere, ha cambiato il corso della storia contemporanea. Qui basti ricordare, a parte l’eversione, spesso con prezzi umani drammatici, delle strutture feudali della Russia, che essa fin da subito ha avuto effetti di radicale trasformazione nella società del tempo spesso ignoti. Chi sa, ad esempio, che per effetto della rivoluzione, nell’Europa Centrale tra le due guerre, vennero avviate ampie riforme agrarie con divisione e distribuzione dei latifondi ai contadini per timore delle rivolte che avevano rovesciato gli Zar? Quelle riforme che in Italia spezzarono il latifondo solo nel 1950? Ma la rivoluzione, che già nel 1918 gli occidentali, compresi gli USA ( situati al di là dell’oceano), cercarono di soffocare sul nascere, ebbe effetti sotterranei nelle campagne dell’Asia e mise in moto vari movimenti contadini da cui prese slancio anche la Rivoluzione cinese.
Nel dopoguerra
il sostegno economico, militare, politico dell’URSS rese possibile e comunque facilitò enormemente la lotta anticoloniale dei Paesi del Sud del mondo, la liberazione di numerosi popoli da una dominazione secolare.Un stato burocratico e autoritario, che espresse anche dirigenti nefasti come Breznev, tuttavia, anche quando si muoveva per interessi geopolitici di potenza, svolgeva un ruolo prezioso per il processo di emancipazione dei paesi poveri.
Ma non si può tacere un altro esito che ci riguarda. La Rivoluzione d’ ottobre rese possibile la nascita dei partiti comunisti dell’Occidente – fenomeno represso sul nascere negli USA democratici – forze politiche moderne che non solo hanno concorso alla lotta antifascista nel dopoguerra, ma hanno svolto un ruolo decisivo nel processo di sviluppo sociale e di costruzione di stati democratici moderni, dotati di un costituzione.Il caso del Partito comunista italiano costituisce un capitolo esemplare di questa storia. Come si sarebbe potuto affermare il welfare – teorizzato peraltro da capi di stato lungimiranti come Roosevelt o da economisti come William Beveridge – senza il concorso e le lotte dei partiti comunisti e socialisti, la grande forza popolare e la mobilitazione dei sindacati? La storia non è una partita di calcio in cui si vince o si perde, e nulla accade mai invano.
Basterebbero questi brevi cenni per far comprendere quanto diversamente siano andate le cose rispetto alle convinzioni interessate e false che si sono affermate, specie negli ultimi decenni in cui la Verità Neoliberista ha riscritto il nostro passato. Del resto, una volta tanto, la storia offre la possibilità di una verifica, per così dire controffattuale, per giudicare il valore della Rivoluzione d’ottobre e di quel che ne è seguito. Che cosa è accaduto alle società occidentali dopo il crollo dell’URSS, quando è venuto a mancare un antagonista al capitalismo occidentale? Che cosa è accaduto al pensiero politico, diventato pensiero unico? Che cosa al welfare, al lavoro, ai sistemi politici, alla democrazia, agli equilibri mondiali? Chi di noi avrebbe mai immaginato il ritorno in grande stile del lavoro schiavile nelle campagne? Eppure, dalla California all’Italia, passando per il Regno Unito e la Spagna, questa è diventata una gloria tangibile dell’Occidente.E’ stata dunque un’errore la Rivoluzione d’ottobre?
E’ questa falsa coscienza, radicata nelle menti, che non consente di ragionare, che porta a guardare alla Russia come un ostacolo all’avanzare della democrazia nel mondo, e a Putin come un mostro assetato di sangue. Cosi dobbiamo sentire in TV, ormai Ministero della Verità, giornalisti anche intelligenti e non faziosi, come ad esempio Corrado Augias, i quali si chiedono che cosa accadrà agli altri territori contermini << se si cede sull’Ucraina>>. Un’espressione che mostra l’assoluta ignoranza delle ragioni di questa guerra, che in parte è una guerra civile, ma che riduce la Russia attuale a una caricatura. Ma quali interessi dovrebbero spingere la Russia ad espandersi ulteriormente ? Il suo territorio statale è <<la più vasta entità territoriale del mondo>> (Treccani) e assomma a 17.075.400 km2, con una popolazione intorno ai 160 milioni di abitanti. L’Europa, tanto per fare un raffronto eloquente, è estesa 4.950.000 km2 ed è popolata da circa 500 milioni di persone. Quale dissennato uomo di stato può spingere un tale paese, letteralmente spopolato, a occupare nuovi territori portando a morire un buona parte dei suoi scarsissimi giovani? Possibile che così pochi, in Italia e in Europa, sono in grado di sospettare che la dirigenza Russa non aveva nessuna convenienza a invadere l’Ucraina, con cui aveva convissuto per decenni, se non fosse stata minacciata dalla Nato ai suoi confini, se gli USA non si fossero mostrati indegni di qualunque fiducia, se la popolazione russofona non fosse stata sottoposta a ripetute persecuzioni? Ma chi grida al pericolo di un’espansione imperialistica ha una idea salottierea della guerra. Dimentica che essa costa la vita di migliaia e migliaia di soldati. Quanta intelligenza c’è nel pensare che anche un’autocrate come Putin può sacrificare, spensieratamente e senza conseguenze, la propria gioventù (sottratta peraltro a un’economia che ne necessita incessantemente) per astratti disegni di dominio?
Putin come Hitler?
Per finire alcune considerazioni su Putin. Ho da poco ascoltato in TV Massimo Giannini, un giornalista democratico e intelligente (a dispetto dei giornali padronali per cui scrive) lanciare grida di dolore di fronte alla notizia che Putin era stato riconfermato presidente con un’affermazione plebiscitaria di quasi il 90% dei votanti.<< Una grave sconfitta per l’Occidente >> l’ha definita con tono angosciato. Espressione che costituisce un involontario smascheramento dell’immagine caricaturale che i media, a partire dai giornali per cui Giannini scrive, hanno deliberatamente costruito della Russia e di Putin. Le nostre élites si rivoltolano negli errori e nelle finzioni che essi stessi propagandano. Esse hanno infatti inventato l’immagine di un dittatore sanguinario che estorce il consenso al suo popolo con il terrore. A questo servono pagine e pagine dedicate alla morte di Alexej Navalny, le decine e decine di trasmissioni televisive in cui si ricostruisce e ripete fine all’esaurimento lo stesso evento. Se avessero un approccio meno propagandistico alla realtà potrebbero capire come stanno realmente le cose. Ricordo che dagli elettori residenti all’estero Putin ha ricevuto il 72, 1% dei voti. E costoro certamente non subivano nessuna pressione o condizionamento. So che dispiace a tantissimi, ma quello del presidente russo è un autentico consenso popolare, dipendente da ragioni molto solide, che il giornalismo democratico dovrebbe avere l’onestà di ricostruire. Onestà di cui è gravemente sguarnito. Putin, agli occhi del suo popolo ha il grande merito di aver sottratto il paese all’anarchia, alla spaventosa povertà di massa creata dal decennio dei governi di Eltsin, rimettendolo sulla strada di uno sviluppo sempre più ordinato e apportatore di benessere. Sviluppo capitalistico, beninteso, in un’economia di libero mercato, con una forte presenza statale. Quella che servirebbe tanto all’Italia e all’ Europa. A lui riconosce il merito di aver domato in gran parte lo strapotere degli oligarchi, di aver limitato la corruzione dilagante, di aver soffocato il terrorismo ceceno che faceva esplodere bombe nei locali pubblici delle città e persino a Mosca. Repressione dolorosamente sanguinosa, certo, ma contro un nemico anch’esso sanguinario che prendeva di mira i civili. A Putin il popolo russo è grato per avergli restituito, dopo l’umiliazione del crollo dell‘URSS, l’orgoglio della propria storia, della propria identità. Questo rinato patriottismo – certo, spesso condito da Putin con improbabili e inopportuni richiami retorici alla Russia degli zar – viene demonizzato in Occidente per poterlo trasformare in imperialismo aggressivo. Eppure non si capisce perché il patriottismo sia invece considerato lecito e benefico per la Francia di Macron, che vuole inviare truppe europee contro la Russia, o per l ‘Italia del governo di guerra della sovranista Meloni, che lo ha preventivamente ceduto agli USA per ragioni di legittimazione politica. Ma il popolo russo ha rafforzato il suo consenso a Putin negli ultimi anni perché ancora una volta avverte i venti di guerra che soffiano contro di lei. La Nato e l’intero Occidente minacciano di “sconfiggerla” sul suo territorio, cioè ancora una volta di invaderla, e noi ci stupiamo che il suo popolo moltiplichi il proprio appoggio al leader che si è mostrato più capace di difenderlo da questa minaccia mortale? Ma come pensano i nostri analisti?
Infine, sempre dedicato agli intellettuali democratici e di sinistra, qualche considerazione su Putin dittatore spietato, argomento impervio, ma che credo di poter affrontare col dovuto equilibrio e freddezza. E’ un compito sgradevole che mi assumo non certo per difendere Putin, ma perché attraverso la sua demonizzazione si fa strada la propaganda bellicista dell’esportazione della democrazia e del regime change: il vero obiettivo per cui gli USA hanno provocato la guerra in Ucraina. Confido perciò nell’intelligenza del lettore. Comincio col dire che io immagino Putin come uomo di grande intelligenza politica, ma sicuramente spietato. Lo credo anche capace di ispirare l’eliminazione di qualche avversario politico. La sua provenienza e la sua esperienza autorizzano questa visione. D’altra parte, è noto, come qualche volta sosteneva Marx, che gli uomini fanno la storia, ma anche l’inverso, che cioé è la storia a fare gli uomini. Del resto come avrebbe potuto rimettere in piedi un moderno stato, in un paese sprofondato nel caos, senza un certo grado di spietatezza? Nella patria di Machiavelli queste considerazioni non dovrebbero destare stupore. Tuttavia quando gli si attribuiscono responsabilità dirette nella morte di un oppositore come Navalny o nell’uccisione della giornalista Anna Politkovskaja, ogni serio analista, che non può contare su nessuna prova che non siano le opinioni dei nostri giornalisti, dovrebbe avere l’intelligenza di porsi delle domande. Occorre sempre esaminare le “convenienze” degli attori in campo per comprendere le dinamiche della politica. E’ davvero giovata a Putin la morte del prigioniero Navalny? Abbiamo poi saputo, del resto, che era destinato a uno scambio di detenuti. E Putin temeva a tal punto la giornalista Anna Politkovskaja, da farla assassinare in quel modo plateale, esponendosi alla condanna universale dei paesi occidentali?
Quel che appare inaccettabile in queste ricostruzioni inverificate e spesso infondate è la rappresentazione del presidente russo come un signorotto feudale, che comanda a piacimento i propri sudditi, riducendo la Russia a un villaggio rurale dell’ ‘800. Si dimentica che anche in quel paese esiste una magistratura che gode di una relativa indipendenza, formata da magistrati che vi accedono per concorsi. Si sopprime interamente la complessità di quella società, al cui interno operano servizi segreti, anche stranieri, criminalità organizzata, fazioni politiche in lotta reciproca, ecc.. L’assassino della Politkovskaja, è stato infatti individuato e condannato a 20 anni di carcere. Come si fa a rappresentare Putin come un grande burattinaio se non per legittimare un suo rovesciamento progettato negli studi degli strategici americani? E infatti non si fanno campagne diffamatorie contro il turco Erdogan, l’egiziano Abdel al Sisi, l’indiano Modi, il saudita Mohammed bin Salman, com’è noto campioni di democrazia liberale.
La democrazia e il popolo russo
In una delle tante interviste rilasciate da Giulietto Chiesa prima di morire questo grande esperto delle cose russe e amico di quel paese, pur riconoscendo a Putin molti meriti, gli rimproverava di non aver fatto avanzare il processo di democratizzazione e liberalizzazione di quella società. La giusta critica che tutti gli rivolgeremmo se la propaganda USA non lo avesse trasformato nel nemico numero uno dell’Occidente. E tuttavia una riflessione sulle difficoltà di fare avanzare il processo di democratizzazione in Russia andrebbe fatto, coinvolgendo il suo passato storico e l’antropologia del suo popolo. Certo, il processo di espansione della Nato e la continuazione della guerra fredda da parte degli USA, anche dopo il crollo dell’URSS, ha ostacolato i processi di democratizzazione interni di quel paese. I dirigenti russi sanno bene quanto danaro e forza organizzativa i servizi segreti USA sono in grado di impiegare per dar vita a formazioni politiche eversive, organizzare rivolte e colpi di stato. Non avevano bisogno di aspettare il rovesciamento del legittimo governo di Kiev nel 2014. D’altra parte non bisogna dimenticare che dopo Eltsin la Russia si è aperta a un’economia di mercato, capitalistica, in cui operano liberi imprenditori, che godono più o meno delle stesse libertà che in Occidente. Dunque l’evoluzione in senso democratico del sistema politico sarebbe naturale, se le relazioni internazionali fossero meno minacciose e agitate. E tuttavia l’inimicizia ricercata e orchestrata dagli USA e dalla Nato per ragioni geopolitiche non basta a spiegare la lentezza dei processi di democratizzazione, anche se appare sufficiente per giustificare la loro recente involuzione.
La democrazia non è un semplice costrutto giuridico, non si esaurisce nella sua architettura istituzionale. E’ una forma di organizzazione della società frutto di un lungo processo storico. Perciò la storia appare come la disciplina chiave per avvicinarsi con meno superficialità ai fenomeni complessi che riguardano questo sconosciuto paese.
E anche in questo caso guardare il corso delle cose dal lato del popolo è importante. Non bisogna dimenticare che in Russia la servitù della gleba è stata abolita, sul piano giuridico, solo nel 1861. Quindi mentre in Italia si avviava il processo di unificazione del paese la Russia, ma solo sul piano meramente formale, cominciava a uscire dal Medioevo. Era una società dominata da una immobile burocrazia imperiale con alla base l’immenso popolo dei contadini, un mondo ai margini della modernità, che noi conosciamo grazie a narratori giganteschi, alla più grande letteratura dell’età contemporanea. La Rivoluzione d’ottobre mandò in aria quel pachiderma e vide per qualche tempo il protagonismo delle masse popolari sino a che la dittatura del proletariato non si trasformò in dittatura tout court. Per oltre 40 anni il sistema di potere dominato da Stalin tolse al popolo ma anche all’intelligentija ogni possibilità di iniziativa e di creatività. Le cose non cambiarono di molto dopo la morte del dittatore e l’esplosione della guerra fredda, la corsa agli armamenti, ecc., non aiutarono l’evoluzione liberale di quella società-apparato. Il tentativo di Kruscev, com’è noto, venne risucchiato dagli elementi conservatori che puntarono al rafforzamento della difesa e agli armamenti per fronteggiare gli USA. Da qui ovviamente le tragedie delle repressioni, prima in Ungheria nel 1956, l’occupazione di Praga nel 1968. Dunque sin quasi all’avvento di Gorbaciov alla dirigenza del paese, il controllo burocratico della popolazione russa è stato sistematico, spesso soffocante. Come si fa a non comprendere la passivizzazione civile della popolazione che ne è derivata, la sua scarsa confidenza con la democrazia, la sua apatia partecipativa? Come si poteva costruire la democrazia con tali precedenti storici se non attraverso un lungo processo? Bruno Giancotti, un italiano che ha lavorato nello staff giornalistico di Gorbaciov e vive in Russia da 40 anni, mi ha spiegato che tra i russi domina una particolare attitudine a demandare il potere a chi sta più in alto, si sentono rassicurati dalla protezione del “Nachalnik”, che vuol dire il “tuo capo”.
Non è un caso che il processo di democratizzazione della Perestrojka, avviato da Gorbaciov forse con non piena consapevolezza della complessità del compito, crollò in poco tempo, trascinando l’URSS nel collasso. Ma come era possibile trasformare in una democrazia liberale, nel giro di mesi, un società senza stato, surrogato da un partito burocratizzato e in parte corrotto, priva di un vero parlamento, di partiti indipendenti, magistratura, sindacati e corpi intermedi autonomi, senza una libera stampa, una tradizione popolare di partecipazione alla vita politica? Perciò il decennio di Eltsin fu una fase fra le più dolorose nella storia del popolo russo in tempo di pace. Dunque, Putin – che, come è emerso nella recente intervista al giornalista Dmitrij Kisilev, aveva rifiutato, in un primo tempo, di fronte alle difficoltà immani del compito, di assumere la responsabilità della presidenza, offertagli da Jeltsin, – dovette ricostruire uno stato che non c’era e ricomporre un’organizzazione economica e sociale devastata dall’improvvisa apertura al mercato, di una società che nelle sue strutture amministrative e rappresentative non doveva essere molto più dinamica di quella zarista. E dunque solo uno statista privo di senno poteva cercare di rimettere in piedi una società interamente collassata – forse un caso unico per dimensioni nell’età contemporanea – ripercorrendo la strada fallimentare di chi l’aveva preceduto. E infatti lo avrebbero preteso, dai loro tranquilli studi, le anime belle del giornalismo occidentale. Senza un elevato tasso di governo autoritario dei processi di riorganizzazione, visto tra l’altro la forza eslege che avevano guadagnato moltitudini di oligarchi, il terrorismo nelle regioni del Caucaso (che si è tragicamente rifatto vivo il 22 marzo) e la corruzione dilagante, il tentativo era destinato al fallimento.
E’ dunque questa, per brevissimi cenni, la storia, sono questi i processi che spiegano Putin e la sua gestione autoritaria che i democratici dovrebbero considerare. La sua demonizzazione non serve né a comprendere le cose, né a favorire il processo di democratizzazione della società russa. Giova all’atlantismo e all’imperialismo guerriero della dirigenza USA, che ha un interesse supremo nel costruire un nemico impresentabile per tenere unita la propria società lacerata un sistema politico esaurito. Quella dirigenza che oggi mostra al mondo la sua feroce capacità di mentire, fingendo di opporsi a Netanyahu, ma continuando a inviargli armi perché completi il massacro a Gaza. Capire dunque un un po’ meglio la storia giova alla causa ragionevole della pace.
FONTE: https://transform-italia.it/il-popolo-russo-putin-la-democrazia/
Ucraina: colta da improvviso panico, l’Europa flirta con ipotesi futili quanto avventate
di Roberto Iannuzzi
Dalla Francia di Macron alla Germania di Scholz, l’Europa a fari spenti di fronte a scelte chiave per il futuro della stabilità continentale

Isteria e allarmismo dominano il dibattito europeo sulla crisi ucraina e sullo scontro con la Russia. “Ciò che guida la politica europea in questo momento è la paura”, ha scritto recentemente il Telegraph in un articolo che tradiva tanto la russofobia britannica quanto l’irritazione di Londra nei confronti della Germania e del suo cancelliere Olaf Scholz.
I dissapori fra le varie capitali europee sono tuttavia conseguenza di un improvviso “risveglio”. Dopo essere cadute vittima della loro stessa propaganda, le élite politiche europee si stanno riavendo dalla sbornia, per scoprire che Kiev sta effettivamente perdendo la guerra.
“La guerra è persa ma i nostri governi rifiutano di ammetterlo. Invece, fingono che si possa ancora vincere – anzi, bisogna vincere per evitare che “Putin” marci verso la Finlandia, la Svezia, gli Stati baltici, e infine Berlino. Due anni fa ci fu promesso che oggi al più tardi la Russia sarebbe stata completamente sconfitta, economicamente, militarmente e politicamente. Ma le sanzioni si sono rivelate un boomerang, e i carri armati Leopard II non erano sufficienti…”
A scrivere queste parole è Wolfgang Streeck, direttore emerito dell’Istituto Max Planck di Colonia. Il quale prosegue:
“È ora di chiedersi chi ha messo gli ucraini in questo pasticcio – chi ha detto all’estrema destra ucraina che la Crimea sarebbe tornata in mano loro? Per evitare tali domande, la classe politica europea è disposta a lasciare che il massacro continui sulla linea congelata del fronte ucraino – cinque anni, dieci anni – nessun problema, tanto saranno solo gli ucraini a combattere. Ma cosa succederà se si rifiuteranno di stare al gioco e di morire per i “nostri valori”?
Streeck è per certi versi una voce fuori dal coro, in quanto lascia trasparire segni di ripensamento dai quali la maggioranza dell’intellighenzia europea sembra tuttora immune.
A titolo di esempio, nella stessa miscellanea di riflessioni sulla guerra, raccolte dal britannico New Statesman in occasione del secondo anniversario dello scoppio del conflitto, Ivan Krastev, presidente del Centro per le Strategie Liberali con sede a Sofia, in Bulgaria, scrive:
“Ciò che rende il momento attuale radicalmente diverso dall’inizio della guerra o addirittura dalla situazione di un anno fa è che, ora, i governi e un numero crescente di cittadini europei hanno iniziato a percepire la guerra non in termini di solidarietà con l’Ucraina, ma di difesa dei fondamentali interessi di sicurezza dei vicini europei della Russia”.
L’opinione di Krastev non va scartata troppo frettolosamente come il punto di vista di un esponente dell’Europa dell’Est. E’ proprio tale punto di vista, infatti, che sta prendendo il sopravvento, con la complicità di Washington, all’interno dell’UE e della NATO.
Lo conferma il recente viaggio a Praga del presidente francese Emmanuel Macron, il quale ha accettato il piano ceco di acquistare 800.000 proiettili d’artiglieria da paesi non appartenenti all’UE per rifornire l’Ucraina.
Inizialmente Parigi si era detta contraria a spendere denaro europeo al di fuori dell’Unione, affermando che sarebbe stato preferibile investirlo nell’industria della difesa del vecchio continente. Ma il nuovo ordine di scuderia a livello europeo è che non c’è tempo, bisogna soccorrere Kiev.
Politica perdente non si cambia
In linea di principio, di fronte all’improvvisa realizzazione che l’Ucraina sta perdendo la guerra, l’Europa potrebbe scegliere fra due opzioni strategiche: tagliare le perdite imboccando la strada del compromesso con Mosca, oppure aumentare nuovamente la posta in gioco. La fazione che propende per la seconda ipotesi è tuttora dominante nel dibattito politico europeo.
Preso atto dell’impossibilità di recuperare i territori ucraini perduti, la nuova priorità europea ed occidentale è preservare lo Stato ucraino e consolidarne la sua posizione all’interno del blocco euro-atlantico.
Come scrive sul Financial Times lo stesso Krastev (che è anche membro del Consiglio di fondazione dell’ European Council on Foreign Relations, e del comitato consultivo dell’ Open Society Foundations, istituto fondato da George Soros), “ciò che è non-negoziabile non è tanto l’integrità territoriale dell’Ucraina, quanto il suo orientamento democratico e filo-occidentale”.
Krastev traccia quindi un parallelo fra l’Ucraina e la Germania Ovest durante la Guerra Fredda. L’analogia è illustrativa perché implica la possibilità di una riunificazione alla prima occasione.
Ma, fino a quando l’Occidente si ostinerà a voler inserire l’Ucraina nell’architettura di sicurezza occidentale – osserva il noto analista russo Fyodor Lukyanov – Mosca sarà costretta a rispondere, a prescindere dal fatto che Kiev aderisca ufficialmente alla NATO o meno.
Le conseguenze sono ovvie: siamo tuttora di fronte a una prospettiva di escalation.
Fermare il nemico russo alle porte
Alla base del tambureggiante allarmismo europeo sulla possibilità che Mosca non limiti i propri obiettivi all’Ucraina, ma intenda attaccare un paese NATO nei prossimi anni, sono poi da ravvisare due esigenze: rilanciare l’industria bellica europea, e consolidare la nuova cortina di ferro che dividerà l’Europa dal Mar Nero al Baltico, fino all’Artico.
Nel quadro del rafforzamento di quest’ultima, spicca l’ossessione NATO per la protezione di quello che è considerato il suo punto più debole, il corridoio di Suwalki (in inglese, Suwalki gap), un lembo di terra lungo circa 65 km che corre sul confine tra Lituania e Polonia, separando la Bielorussia alleata di Mosca dall’exclave russa di Kaliningrad.
L’assillo della NATO, alimentato dalla presa di coscienza della propria debolezza militare a seguito dello scontro non vittorioso con Mosca in Ucraina, è che le forze russe possano occupare questa striscia di terra con un’azione fulminea, ponendo così il blocco atlantico di fronte al fatto compiuto, e isolando le tre repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia e Lituania) dal resto dell’Alleanza.
Chiamata francese alle armi
Di fronte all’esigenza di “salvare” lo Stato ucraino e la sua appartenenza al blocco occidentale, ecco allora la proposta, fino a poco tempo fa ritenuta impensabile, di inviare truppe NATO in Ucraina. Ad avanzarla è stato Macron a una conferenza di leader europei riuniti a Parigi, ispirando, a stretto giro di posta, la constatazione (più che la “minaccia”) del presidente russo Putin che uno scontro Russia-NATO sfocerebbe in un conflitto nucleare.
La proposta francese ha suscitato reazioni negative da parte di cechi, slovacchi, italiani, polacchi, così come del cancelliere tedesco Scholz. Tuttavia non si è trattato di una semplice boutade del capo dell’Eliseo.
Lo stesso quotidiano Le Monde, due giorni dopo, affermava che, sebbene la questione fosse mal posta, un dibattito su di essa era necessario. E poco tempo dopo, da Praga, il presidente francese ha reiterato la propria idea.
Questa volta, l’omologo ceco Petr Pavel (un ex generale NATO) ha detto che non vedeva ragioni per cui almeno addestratori dell’Alleanza non potessero essere inviati in Ucraina.
Partizione dell’Ucraina?
Alcuni analisti americani hanno osservato che mandare truppe NATO nel paese non significherebbe necessariamente impegnarle in battaglia contro le forze di Mosca. Nel caso in cui i russi dovessero sfondare il fronte, si potrebbe infatti concepire l’invio di soldati dell’Alleanza per preservare un residuale Stato ucraino, controllando Kiev e attestandosi su una linea ben più a ovest dell’avanzata russa, come base per proporre un cessate il fuoco.
Si tratterebbe, in altre parole, di operare una partizione di fatto dell’Ucraina, secondo uno schema non troppo dissimile da quello applicato qualche anno fa in Siria, ma in un contesto infinitamente più pericoloso.
Per scongiurare uno scontro con Mosca, tale partizione comporterebbe per Kiev una perdita di territori molto più consistente rispetto alla situazione attuale, al fine di garantire una sufficiente “zona cuscinetto” che separi le forze NATO da quelle russe.
Superamento delle linee rosse
Simili scenari, naturalmente, implicherebbero rischi ben maggiori di quelli fin qui corsi nella contrapposizione Russia-NATO. Non bisogna tuttavia dimenticare che i paesi occidentali hanno già oltrepassato un gran numero di linee rosse nel conflitto ucraino, senza che l’opinione pubblica occidentale ne fosse adeguatamente informata.
Vi sono già migliaia di “volontari” stranieri sul suolo ucraino, provenienti soprattutto da Polonia, Romania, e altri paesi dell’Est, ma anche da Francia, Gran Bretagna, Germania e Stati Uniti. Essi si dividono grossomodo in quattro categorie: mercenari che combattono al fronte, personale addestrato nell’uso dei sistemi d’arma occidentali, consulenti tattici e personale di intelligence.
A fine gennaio, la Russia affermò di aver ucciso una sessantina di mercenari francesi nel bombardamento di un albergo impiegato come caserma a Kharkiv. Parigi negò l’accaduto, ma pochi giorni dopo convocò l’ambasciatore russo accusando Mosca di aver ucciso due operatori umanitari francesi in Ucraina.
L’ambasciata russa a Parigi rispose che le autorità francesi non avevano presentato alcuna prova che i due concittadini uccisi fossero operatori umanitari, né aveva dato risposta riguardo alla presenza di mercenari francesi in Ucraina.
I russi hanno anche colpito batterie Patriot in Ucraina, piste di decollo e centri di comando, uccidendo probabilmente numerosi “volontari” stranieri.
Per converso, è emerso che l’aereo da trasporto russo Il-76 abbattuto a fine gennaio nell’oblast di Belgorod vicino al confine, con a bordo 65 prigionieri di guerra ucraini, era stato colpito da una batteria di missili Patriot, il cui equipaggio potrebbe aver incluso anche personale americano.
Segreti di Pulcinella
Nel frattempo, il New York Times ha rivelato l’esistenza di una partnership di lungo corso fra la CIA e i servizi ucraini, che risalirebbe ai giorni immediatamente successivi al rovesciamento del presidente Viktor Yanukovych nel febbraio 2014, a seguito della rivolta di Maidan.
(Va rilevato che le ingerenze americane in Ucraina furono continue nel dopoguerra, e non cessarono nemmeno tra la fine della Guerra Fredda e la rivolta del 2014).
Nei giorni successivi al rovesciamento di Yanukovych, il neonominato capo dei servizi ucraini (SBU), Valentyn Nalyvaichenko, propose una collaborazione a tre con la CIA e l’MI6 britannico.
Qualche commentatore americano ha perfino ammesso che la presenza della CIA in Ucraina dopo il 2014 abbia rappresentato una delle provocazioni che hanno infine portato Mosca a invadere il paese.
Nell’ambito della collaborazione fra Kiev e la CIA, quest’ultima ha creato circa 12 stazioni lungo il confine russo – ha riferito il New York Times. Tali avamposti che, come osservano i russi, sono probabilmente ben più di 12, collaborano con le forze speciali e i commando ucraini che compiono attacchi e attentati in territorio russo.
Allo stesso modo, sono le operazioni di ricognizione e spionaggio compiute da aerei americani e britannici sul Mar Nero ad aver facilitato gli attacchi ucraini contro la flotta russa e il ponte di Kerch in Crimea.
Simili operazioni, e la presenza di personale militare occidentale in territorio ucraino, rendono difficile ai paesi NATO mantenere una “plausible deniability”. Sebbene essi abbiano ufficialmente affermato di opporsi all’invio di truppe occidentali, tali forze di fatto già operano sul terreno.
Bisticci fra Londra e Berlino
E’ quanto ha indirettamente confermato lo stesso Olaf Scholz, il 26 febbraio, allorché ha dichiarato che la Germania non fornirà i suoi missili Taurus a lungo raggio all’Ucraina, perché ciò richiederebbe la presenza di personale militare tedesco per gestire questi complessi sistemi d’arma, allo stesso modo di quanto già fanno i britannici per operare i loro Storm Shadow.
La dichiarazione ha suscitato irritazione a Londra. Sebbene dal governo britannico non siano pervenute reazioni ufficiali, l’ex ministro della difesa Ben Wallace ha descritto il cancelliere tedesco come “l’uomo sbagliato al posto sbagliato nel momento sbagliato”. Mentre Tobias Ellwood, ex presidente della commissione Difesa alla Camera dei Comuni, ha definito la dichiarazione di Scholz “un flagrante abuso di intelligence”.
La stizza britannica appare tuttavia fuori luogo, se si pensa che nel frattempo il Times di Londra lodava il capo di stato maggiore dell’esercito di Sua Maestà, ammiraglio Tony Radakin, per aver preso parte alla pianificazione ed esecuzione degli attacchi ucraini contro la flotta russa nel Mar Nero.
Il fronte bellicista tedesco
Nel frattempo, tuttavia, la diffusione della registrazione di un colloquio tra alti ufficiali della Luftwaffe, l’aviazione militare tedesca, era destinata ad essere fonte di ulteriore imbarazzo per Berlino.
Nella loro conversazione, quattro ufficiali parlavano di un possibile piano per distruggere il ponte di Kerch, che unisce la Crimea alla madrepatria russa, impiegando da 10 a 20 missili Taurus. Tuttavia, per avere successo, l’attacco avrebbe richiesto il diretto coinvolgimento tedesco nella sua pianificazione, e ciò avrebbe significato un’entrata in guerra di fatto della Germania contro la Russia.
Dalla conversazione, confermata come autentica, emerge che, sebbene Scholz sia restio a fornire i suoi missili da crociera all’Ucraina, vi sono elementi all’interno dell’esercito (ma anche del governo) che sono pronti a coinvolgere ulteriormente la Germania in uno scontro con la Russia.
In spregio della volontà popolare
In generale, vi è una crescente propensione occidentale a fornire armi a lungo raggio che permetterebbero a Kiev di colpire obiettivi in profondità in territorio russo, accrescendo i rischi di un inasprimento del conflitto con Mosca.
Va detto però che tali armi difficilmente cambierebbero i destini dell’Ucraina. Nel caso tedesco, Berlino potrebbe rendere disponibili al più un centinaio di Taurus, capaci di colpire a una distanza di 500 km.
Essi sarebbero dunque potenzialmente in grado di mettere Mosca sotto tiro. Ma il loro numero esiguo fa sì che, pur essendo un loro impiego per eventuali attacchi in territorio russo estremamente provocatorio, esso non muterebbe gli equilibri complessivi.
Come hanno osservato alcuni esperti militari americani, ciò di cui l’Ucraina ha veramente bisogno sono proiettili d’artiglieria e sistemi di difesa aerea contro i missili e i droni russi. Ma è proprio questo materiale che l’industria bellica occidentale non riesce a produrre in quantità sufficienti.
Gli avventurismi occidentali, dunque, accrescono il rischio di incidenti che potrebbero portare a uno scontro diretto con la Russia, senza tuttavia risollevare le sorti di Kiev.
Per salvare l’Ucraina, sarebbe molto più utile la ricerca di un compromesso con Mosca, come del resto vorrebbe la maggioranza delle opinioni pubbliche europee.
Ma si sa, nelle “democrazie” occidentali, raramente i governi si fanno interpreti della volontà delle rispettive popolazioni.
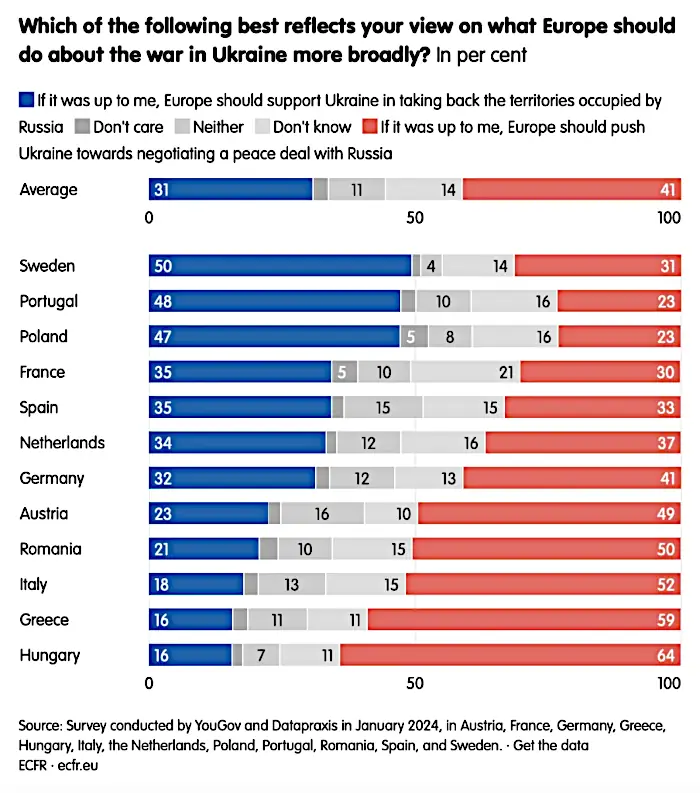
Sondaggio dell’European Council on Foreign Relation risalente al gennaio 2024.
A Mosca, riunite tutte le fazioni della Resistenza palestinese

Dal 29 febbraio al 2 marzo rappresentanti delle varie fazioni palestinesi, pur avendo posizioni spesso profondamente diverse su molte questioni nella regione, stante la situazione di guerra e genocidio contro il proprio popolo, hanno accettato questa Conferenza sulla situazione in Medio Oriente, grazie al lavoro della Russia all’interno del progetto di “ Dialogo inter-palestinese”, da tempo avviato dal Ministro russo Lavrov. Erano presenti 14 organizzazioni palestinesi, da Hamas, ai Fronti Popolari, OLP, Fatah, Jihad islamica e altri.
Il rappresentante speciale del presidente russo per il Medio Oriente e i paesi africani, il viceministro degli Esteri della Federazione Russa, M. Bogdanov , che ha proposto la piattaforma per l’incontro svoltosi nel palazzo del Ministero degli Esteri, ha rilasciato una dichiarazione, dove ha sottolineato un clima di collaborazione e dialogo tra tutte le fazioni, al di là di posizioni e giudizi su molti aspetti molto diversificati: “…La composizione è stata più o meno la stessa dei due precedenti incontri interpalestinesi, con la presenza di 14 organizzazioni, da quelle che fanno parte dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ma anche strutture che non sono in essa incluse come Hamas e la Jihad islamica. Ora abbiamo invitato anche loro… L’obiettivo della Russia è favorire e aiutare le varie forze palestinesi ad accettare di unire politicamente i loro ranghi…”.
Questo il comunicato finale delle organizzazioni presenti:
“Le fazioni palestinesi riunite nella città di Mosca. esprimono la loro gratitudine e apprezzamento alla leadership russa per aver ospitato i loro incontri e per il suo sostegno alla causa palestinese. Nel mezzo dell’aggressione criminale sionista che il nostro popolo sta affrontando, le fazioni hanno evidenziato lo spirito costruttivo e positivo che ha prevalso durante l’incontro. Hanno concordato che i loro incontri continueranno nei futuri cicli di dialogo per raggiungere un’unità nazionale globale che comprenda tutte le forze e le fazioni palestinesi nel quadro dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina, come unico e legittimo rappresentante del popolo palestinese.
Le fazioni hanno affermato il loro accordo sui compiti urgenti che il popolo palestinese deve affrontare e i loro sforzi congiunti per realizzarli, tra cui:
Affrontare la criminale aggressione “israeliana” e la guerra genocida condotta contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e ad Al-Quds, con il sostegno, l’appoggio e la partecipazione degli Stati Uniti.
Resistere e fermare i tentativi di scacciare il nostro popolo dalla sua patria, la Palestina, soprattutto nella Striscia di Gaza o in Cisgiordania e Al-Quds, e affermare l’illegittimità degli insediamenti e dell’espansione degli insediamenti secondo le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e del Consiglio Generale Assemblea delle Nazioni Unite.
Lavorare per revocare il brutale assedio sul nostro popolo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania e garantire la consegna di aiuti umanitari, vitali e medici, senza restrizioni o condizioni.
Costringere l’esercito di occupazione a ritirarsi dalla Striscia di Gaza, impedendo i tentativi di consolidare la sua occupazione o il controllo su qualsiasi parte della Striscia di Gaza con il pretesto delle zone cuscinetto e aderendo all’unità di tutte le terre palestinesi in conformità con la Legge Internazionale.
Rifiutando qualsiasi tentativo di separare la Striscia di Gaza dalla Cisgiordania, compreso Al-Quds, come parte degli sforzi volti a privare il popolo palestinese del diritto all’autodeterminazione e a stabilire il proprio stato libero, indipendente e pienamente sovrano su tutte le terre palestinesi occupate, con Al-Quds come capitale, in conformità con le risoluzioni internazionali.
Sostenendo e appoggiando l’eroica fermezza del nostro popolo in lotta e la sua resistenza in Palestina, la sua volontà di sostenere il nostro popolo nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, soprattutto ad Al-Quds, e la sua coraggiosa resistenza nel superare le ferite e la distruzione causate dalla guerra di aggressione criminale, per ricostruire ciò che l’occupazione ha distrutto e per sostenere le famiglie dei martiri, dei feriti e di coloro che hanno perso la casa, le proprietà e i mezzi di sussistenza.
Affrontando le cospirazioni dell’occupazione e le sue continue violazioni contro la benedetta Moschea di Al-Aqsa, i suoi attacchi alla libertà di culto durante il mese sacro del Ramadan, impedendo ai fedeli di raggiungerla e insistendo nel resistere a qualsiasi danno alla Moschea di Al-Aqsa, la città di Al-Quds e le sue santità islamiche e cristiane.
Pieno sostegno ai valorosi prigionieri uomini e donne nelle carceri che sono sottoposti a varie forme di tortura e oppressione, e determinazione a dare priorità a ogni sforzo possibile per liberarli dalla prigionia dell’occupazione.
Sottolineando la difesa dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione (UNRWA) e il suo ruolo vitale nella cura dei rifugiati palestinesi fino al loro ritorno e all’attuazione della Risoluzione 194 delle Nazioni Unite.
Le fazioni palestinesi rendono omaggio al Sudafrica per il suo sostegno al popolo palestinese e per il suo ruolo fondamentale nel portare il caso giudiziario davanti alla Corte internazionale, di giustizia e per far ritenere l’occupazione “israeliana” responsabile del crimine di genocidio.”.
Nella conferenza si è discusso anche di approntare un programma per un apparato di sicurezza congiunto, sia per proteggere i territori già sotto controllo, sia per liberare quelli catturati dall’occupazione, sia in Cisgiordania che nella Striscia di Gaza.
Il Ministro degli Esteri russo S. Lavrov, dopo la Conferenza ha sottolineato che: “…il dato estremamente significativo e rilevante, è quello che, nel comunicato adottato al termine della riunione di Mosca, le fazioni palestinesi, per la prima volta si sono espresse ad una disponibilità a rispettare la piattaforma dell’OLP. Questo è un buon passo avanti affinché diventino veramente uniti e parlino la stessa lingua con il mondo esterno…Così come, sulla base dei colloqui, i palestinesi hanno adottato una dichiarazione finale consensuale… “, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.
Con questo ennesimo atto, la Russia conferma di voler cercare anche nell’area medio orientale soluzioni negoziali, politiche e costruttive verso scenari di pace e non di guerra e conflittualità.
Con il “Formato Mosca” per il “Dialogo inter-palestinese”, Mosca rafforza la sua influenza geopolitica nell’area, assumendo nei fatti un ruolo di mediazione centrale in questo processo,: il Cremlino mantiene rapporti di lavoro con tutti i partecipanti all’incontro, evita giudizi categorici, ritenendo che i palestinesi debbano definire da soli il loro futuro. In sostanza, il progetto di Mosca è il tentativo di far mettere in atto concretamente e senza cancellazioni, gli accordi che erano stati raggiunti in Algeria, Il Cairo e Doha, ma che non hanno mai preso forma definitiva.
Enrico Vigna, IniziativaMondoMultipolare/CIVG – 7 marzo 2024
Economia di guerra parte IX – Gli effetti delle sanzioni occidentali sulla dinamica economica e commerciale del 2022 dei Paesi co-belligeranti
di Andrea Vento
Nel contesto della nostra disamina relativa ai molteplici effetti innescati dall’escalation del conflitto in Ucraina, per ciò che concerne la sfera geoeconomica, per funzionalità di analisi, abbiamo suddiviso gli Stati in tre principali tipologie: quelli coinvolti direttamente nelle attività belliche, i co-belligeranti, vale a dire i 38 Paesi alleati Stati Uniti che hanno comminato le sanzioni economiche alla Russia e la galassia dei restanti Stati che, pur condannando l’invasione russa in sede Onu, hanno continuato ad aver rapporti economici con Mosca, intensificandoli in alcuni casi.
Dopo aver dettagliatamente analizzato in precedenza i casi di Ucraina e Russia, anche in relazione all’adozione di due economie di guerra dalle diverse caratteristiche, procediamo all’analisi dei riflessi economici sui Paesi co-belligeranti, definiti tali perché, oltre ad imporre misure restrittive a Mosca, stanno da due anni sostenendo, seppur in diversa misura, Kiev con aiuti militari, finanziari e umanitari. Corposo e imprescindibile sostegno che ha consentito all’Ucraina, da un lato, di sostenere lo sforzo bellico e, dall’altro, di evitare sia il crollo strutturale dell’economia che il default dello Stato.
La flessione dell’economia mondiale
Abbiamo precedentemente analizzato come alcuni fattori concomitanti, legati in primis agli effetti dell’escalation militare in Ucraina, abbiano determinato un rallentamento del ciclo economico e dei commerci mondiali già a partire dal quarto trimestre 2021. Infatti, da una previsione di crescita per il 2022 dell’economia mondiale del 4.9% dell’Outlook Fmi di ottobre 2021, il dato definitivo di +3,5% mostrava una significativa riduzione del 30% (tab. 1), con la flessione che, proseguita nell’anno successivo, dovrebbe portare, secondo i dati preliminari del Fmi del gennaio 2024, ad una chiusura intorno al 3,1% per il 2023.
Tabella 1: previsioni e dati definitivi in % anni 2022 e 2023 dei vari Word Economic Outlook Fmi
| Tipologia di dati | Previsioni 2022 | Previsioni 2022 | Previsioni 2022 | Definitivo 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2023 | Preliminare 2023 |
| Economic Outlook Fmi | Ottobre 2021 | Gennaio 2022 | Aprile 2022 | Luglio 2023 | Gennaio 2023 | Luglio 2023 | Ottobre 2023 |
| Economia mondiale | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 3,5 | 2,9 | 3,0 | 3.1 |
| Economie avanzate | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 1,6 |
| Economie emergenti | 5,1 | 4,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| Russia | 4,7 | 4,5 | -8,5 | -2,1 | 0,3 | 1,5 | 3,0 |
| Stati Uniti | 5,2 | 4,0 | 3,7 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 2,5 |
| Germania | 4,6 | 3,8 | 2,1 | 1,8 | 0,1 | -0,3 | -0,3 |
| Italia | 4,2 | 3,8 | 2,3 | 3,7 | 0,6 | 1,1 | 0,7 |
| Eurozona | 2,8 | 3,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 |
| Cina | 8,0 | 8,1 | 4,4 | 3,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| India | 9,5 | 9,0 | 8,2 | 7,2 | 6,1 | 6,1 | 6,7 |
Il trend economico globale del 2022 risulta, tuttavia, caratterizzato da una marcata articolazione, sia fra i vari raggruppamenti geoeconomici, nel cui contesto le Economie sviluppate hanno subito un pesante -40% (da +4,5% a 2,7% finale) di riduzione della crescita rispetto alle previsioni Fmi di ottobre 2021, che fra i principali Stati, fra i quali risultano i Paesi occidentali e la Cina ad aver subito i più gravi contraccolpi. Mentre, la Russia, benché gravata nel 2022 da un -2,1% finale, riesce a contenere la recessione ad un livello quattro volte inferiore rispetto al -8,5% del primo Outlook Fmi dopo l’escalation, quello di aprile.
Le Economie emergenti, interessate in minor misura dallo smottamento geopolitico e geoeconomico, sono invece riuscite nel 2022 a contenere, rispetto alle previsioni, la flessione al 20%, ripiegando dal +5,1% di ottobre 2021 al +4,0% finale (tab. 1) .
Fra queste merita sicuramente attenzione l’India, unica fra le principali 10 economie mondiali in fase marcatamente espansiva, che chiude il 2022 con un ragguardevole +7,2%, anche in virtù del vertiginoso aumento dell’import di petrolio1 a prezzi ribassati dalla Russia, il quale, trasformato nelle sue raffinerie in diesel e carburanti per aerei, viene rivenduto in primis all’Ue a prezzi competitivi2. New Delhi si è in tal modo trovata a beneficiare di una favorevole rendita di posizione determinata dalla rinuncia europea alle forniture energetiche russe, che ha contribuito a sostenere anche nel 2023 la sua ascesa in seno alle principali potenze economiche mondiali. Autorevoli istituti di ricerca hanno infatti rilevato che grazie alla crescita del 2023, prevista dal Fmi al 6,7% nel preliminare di gennaio (tab.1), l’india è arrivata a scalzare Il Regno Unito dalla quinta posizione della specifica graduatoria3.
Espletata la breve sintesi relativa all’andamento ciclo economico del 2022, anno di rottura degli equilibri internazionali geopolitici, passiamo all’individuazione dei principali fattori che stanno tutt’ora influenzando negativamente la dinamica economica mondiale, dei blocchi geoeconomici e dei singoli Paesi.
L’impennata del costo dell’energia: cause e dinamica temporale
Da una dettagliata analisi dei valori medi mensili dei contratti Spot4 di compravendita del gas naturale sul mercato TTF (Title Transfer Facility) di Amsterdam, abbiamo ricavato come l’inizio dell’impennata delle stesse trovi origine già nella tarda primavera 2021, a causa di carenze nell’offerta, innescate dalla ripresa post pandemica, prontamente colte dalla speculazione finanziaria. Dai 17,48 euro per megawatt/ora di aprile si era, infatti, saliti a 87,47 euro ad ottobre, per poi toccare i 110,12 a dicembre e ripiegare a 83,7 a febbraio 2022 (tab. 2). Proprio al termine di tale mese, l’approvazione della prima tranche di sanzioni occidentali il 23 e l’avvio dell’operazione militare russa in Ucraina il 24, hanno fornito nuovo terreno fertile alla speculazione finanziaria, la cui spregiudicata attività tramite i famigerati strumenti derivati, ha spinto nuovamente al rialzo le quotazioni del gas naturale, salite infatti a marzo a 125,42 euro a megawatt/ora, per poi ripiegare nei due mesi successivi intorno ai 90 euro.
Tabella 2: valori medi mensili dei contratti Spot del gas sul mercato TTF in euro al Smc e a MegaWatt/ora Fonte: https://luce-gas.it/guida/mercato/ttf-gas
| Quotazioni medie mensili del Gas naturale sul mercato TTF | ||
| Mese | €/Smc | €/MWh |
| gennaio 2024 | 0,321 | 30,00 |
| dicembre 2022 | 0,377 | 35,23 |
| novembre 2023 | 0.460 | 42,99 |
| ottobre 2023 | 0.460 | 42,99 |
| settembre 2023 | 0,383 | 35,79 |
| agosto 2023 | 0,355 | 33,17 |
| luglio 2023 | 0,318 | 29,71 |
| giugno 2023 | 0,342 | 31,96 |
| maggio 2023 | 0,339 | 31,68 |
| aprile 2023 | 0,459 | 42,89 |
| marzo 2023 | 0,478 | 44,67 |
| febbraio 2023 | 0,576 | 53,82 |
| gennaio 2023 | 0,680 | 63,55 |
| dicembre 2022 | 1,268 | 118,55 |
| novembre 2022 | 0,975 | 91,18 |
| ottobre 2022 | 0,850 | 79,44 |
| settembre 2022 | 2,019 | 188,69 |
| agosto 2022 | 2,379 | 222,33 |
| luglio 2022 | 1,837 | 171,68 |
| giugno 2022 | 1,112 | 103,92 |
| 18 maggio: approvazione Piano REPowerEU | ||
| maggio 2022 | 0,956 | 89,34 |
| aprile 2022 | 0,993 | 92,80 |
| marzo 2022 | 1,342 | 125,42 |
| 24 febbraio: avvio operazione militare speciale russa in Ucraina 23 febbraio: prima tranche di sanzioni alla Russia | ||
| febbraio 2022 | 0,889 | 83,07 |
| gennaio 2022 | 0,895 | 83,63 |
| dicembre 2021 | 1,178 | 110,12 |
| novembre 2021 | 0,874 | 81,70 |
| ottobre 2021 | 0,936 | 87,47 |
| settembre 2021 | 0,679 | 63,45 |
| agosto 2021 | 0,472 | 44,12 |
| luglio 2021 | 0,311 | 29,07 |
| giugno 2021 | 0,267 | 24,95 |
| Ripresa economica post pandemica | ||
| maggio 2021 | 0,218 | 20,37 |
| aprile 2021 | 0,187 | 17,48 |
| marzo 2021 | 0,185 | 17,29 |
| febbraio 2021 | 0,217 | 20,28 |
| gennaio 2021 | 0,173 | 16,17 |
Il piano comunitario REPowerEU del 18 maggio 2022, contenente le strategie energetiche per “ridurre le dipendenze” dalle convenienti e continuative forniture via gasdotto da Mosca al fine di mettere in crisi l’export della Russia, ha innescato una crisi da carenza negli approvvigionamenti europei di combustibili fossili. Nell’incerta nuova fase di ridefinizione delle impalcature energetiche europee, ha avuto nuovamente buon gioco la speculazione finanziaria, che lasciata libera di agire, ha spinto a livelli stratosferici le quotazioni nei mesi successivi, fino a raggiungere l’apice di 222,33 euro per megawatt/ora ad agosto. Dal mese successivo il gas naturale ha quindi imboccato un non lineare trend ribassista sfociato tuttavia in un rapida contrazione della sua quotazione media mensile fino al minimo di 29,73, euro a megawatt/ora a luglio 2023, per poi intraprendere una lieve risalita ed attestarsi nei mesi successivi nei mesi successivi fra i 30 ed i 43 euro.
I riflessi economici delle sanzioni alla Russia
Il tentativo di strangolare l’economia russa facendo leva sulle numerose tranche di sanzioni e il piano REPowerEU, tramite il quale abbiamo rinunciato al gas russo senza che ci venisse precluso da Mosca, si sono rivelati nel breve periodo un clamoroso boomerang per le economie europee. Queste ultime, hanno infatti subito immediati pesanti contraccolpi in termini di forte aumento del costo dell’energia e delle materie prime, aggravamento della bilancia commerciale, inflazione e rallentamento economico. L’economia dell’Eurozona da una previsione iniziale del Outllook Fmi di gennaio 2022 di buona crescita del +3,5%, registra un dato definitivo, ridotto ad 1/4, pari al solo + 0,8%, poco sopra la soglia della stagnazione. Mentre gli Stati Uniti, che come vedremo hanno subito effetti alquanti diversi rispetto ai paesi europei, da una previsione di +4,0% di gennaio, riescono a contenere la flessione a circa il 50%, attestandosi nel dato definitivo a + 2,1% (tab. 1).
L’impatto economico e commerciale sulla Russia
Diametralmente opposta, invece, la situazione della Russia, la quale nonostante fosse stata inizialmente prevista per il 2022 in grave recessione (-15% a febbraio, poi ridotta a -8,5 dal Fmi ad aprile5) e addirittura a rischio crollo6, grazie all’impennata delle materie prime, ha beneficiato di un incremento dell’attivo del saldo commerciale di 79,8 mld € nel 2021 e ulteriori 97,6 mld € nel 2022 (tab. 3), riuscendo ad attenuare la contrazione della propria economa nel corso dei mesi successivi ed a chiudere l’anno a -2,1% (tab. 1).
Tabella 3: export e import commerciale della Russia in miliardi di € anni 2020-22 con variazioni
Fonte: http://www.infomercatiesteri aggiornamento del 19 ottobre 20237
| Bilancia commerciale Russia | 2020 dati rilevati | 2021 dati rilevati | Variazioni 2020/21 | 2022 dati rilevati | Variazioni 2021/22 |
| Valore export totale (mld €) | 301,1 | 431 | + 129,9 | 497,5 | + 66,5 |
| Valore import totale (mld €) | 206,9 | 257 | + 50,1 | 225,9 | – 31.1 |
| Saldo bilancia commerciale (mld €) | 94,2 | 174 | + 79,8 | 271,6 | + 97,6 |
Il saldo commerciale dell’Unione Europea cala a picco nel 2022
In controtendenza rispetto a quanto verificatosi in Russia, sempre nel 2022, l’Unione Europea ha subito un gravoso peggioramento delle relazioni commerciali con i Paesi extra-Ue. In base ai dati diffusi dall’Eurostat8, infatti, il deficit annuo relativo al commercio di soli beni, esclusi quindi i servizi, è sprofondato a ben -432 miliardi di euro, il livello più basso dall’inizio della serie temporale delle rilevazioni statistiche nel 2002 (grafico 1). Dopo aver registrato nel 2020, grazie al blocco delle attività produttive e al basso costo delle materie prime, un avanzo commerciale di +215,3 miliardi di euro9, nel 2021 il cospicuo aumento del 25% del valore dell’import dovuto all’impennata dei combustibili, aveva già impattato negativamente sul saldo facendolo ripiegare a soli +54,5% miliardi (tab.4).
Grafico 1: andamento del commercio internazionale extra-Ue di soli beni dell’Unione europea periodo 2012-2022. Fonte Eurostat (nota 10)

In merito alle cause della debacle, lo stesso Istituto specifica che “Il deficit era dovuto, in particolare al forte aumento del costo dell’energia importata, iniziato verso la fine del 2021 e proseguito per gran parte del 2022”. Precisando di seguito, per completezza e puntualità di analisi, che “Uno sguardo più dettagliato agli ultimi due anni mostra che le importazioni hanno iniziato a crescere più delle esportazioni da giugno 2021. Ciò è dovuto in particolare ai notevoli aumenti dei prezzi dei principali prodotti energetici, già in atto nel 2021 sulla scia della crescente domanda internazionale dopo la pandemia”10 (tab. 2).
Con un certo conforto rileviamo come l’analisi dell’autorevole istituto di Statistica comunitario concordi, sia per quanto riguarda la tempistica, il giugno 2021, sia in merito alle cause dell’aumento delle quotazioni del gas naturale, la speculazione finanziaria, con quanto da noi evidenziato al precedente paragrafo “L’impennata del costo dell’energia: cause e dinamica temporale”.
Tabella 4: valore dell’export, dell’import e del saldo commerciale di soli beni dell’Unione europea coi Paesi extra-Ue in miliardi di euro, periodo 2012-2022. Fonte: Eurostat11 – Rielaborazione: Giga
| Bilancia commerciale Unione europea coi paesi extra-Ue (mld €) | |||
| Anno | Saldo | Esportazioni | Importazioni |
| 2012 | + 68,4 | 1.770,9 | 1.702,5 |
| 2013 | + 149,3 | 1.780,1 | 1.630,8 |
| 2014 | + 171,4 | 1.796,8 | 1.625,4 |
| 2015 | + 228,2 | 1.876,3 | 1.648,1 |
| 2016 | + 264,3 | 1.866,8 | 1.602,5 |
| 2017 | + 222,1 | 1.994,2 | 1.772,1 |
| 2018 | + 147,7 | 2.059,8 | 1.912,1 |
| 2019 | + 191,1 | 2.132,0 | 1.940,9 |
| 2020 | + 215,3 | 1.932,7 | 1.717,4 |
| 2021 | + 54,5 | 2.180,7 | 2.126,2 |
| 2022 | – 432,6 | 2.571,4 | 3.004,0 |
La stretta correlazione inversa fra l’andamento del saldo commerciale comunitario ed il costo dei prodotti energetici, ad ulteriore conferma, emerge anche dalla comparazione della variazione delle quote di import per categorie merceologiche delle bilance commerciali del 2021 e del 2022. Nonostante il già elevato livello delle quotazioni degli idrocarburi del 2021, l’ulteriore impennata del 2022 incrementa la percentuale di import di tali materie prime dal 18% ad oltre il 27,5% (grafico 2).
La conseguente fiammata inflazionistica e l’innalzamento del tasso di riferimento da parte della Bce da 0% al 4,5%, teso a farla ripiegare, ha finito inevitabilmente per comprimere la domanda aggregata innescando un rallentamento dell’economia comunitaria che si è riflesso negativamente anche sulle quote di import delle altre tipologie merceologiche, dai macchinari ai manufatti di consumo e dai prodotti chimici a quelli alimentari, che infatti nel 2022 hanno evidenziato un generale arretramento (grafico 2).
Grafico 2: variazione delle quote di import extra- Ue per tipologia di prodotti confronto fra 2021 e 2022

In particolare, l’Unione europea ha subito riflessi negativi nell’interscambio commerciale con la Russia a seguito, da un lato, della sensibile riduzione dell’export, frutto dell’effetto combinato di sanzioni e contro-sanzioni, con rapida riduzione dei volumi scambiati (tab. 4 prime 2 colonne), e dall’altro, dall’aumento del costo delle materie prime agricole, minerarie ed energetiche (grafico 3) importate da Mosca, le quali, pur in presenza di una riduzione dei volumi, hanno registrato un aumento in valore (grafici 2 e 4).
Tabella 4: quota di import e di export di soli beni dell’U.e. ricoperto dalla Russia e saldo mensile in miliardi di euro dell’interscambio Ue – Russia. Fonte Eurostat12
| Febbraio 2022 | Settembre 2022 | Marzo 2022 | Novembre 2022 | |
| Quota export Ue in Russia | 4,0% | 1,8% | ||
| Quota import Ue dalla Russia | 9,5% | 5,0% | ||
| Saldo bilancia commerciale Ue – Russia (mld €) | – 19,6 | – 6,9 |
Grafico 3: andamento dell’indice delle materie prime di Bloomberg fra gennaio 2021 e aprile 2023

Grafico 4: bilancia commerciale di soli beni Ue-Russia gennaio 2018 – maggio 2022

Il mese di febbraio del 2022 rappresenta, dunque, un fondamentale spartiacque nelle relazioni commerciali extra-Ue dell’Unione Europea. Nello specifico nell’interscambio con la Russia si è passati da una fase iniziale in cui il disavanzo commerciale comunitario ha raggiunto in marzo il picco su base mensile di ben – 19,6 miliardi di euro, a seguito principalmente dell’impennata delle quotazioni delle materie prime (grafico 3), ai mesi successivi, nei quali l’interscambio si è gradualmente ridotto, alleggerendo il deficit della bilancia commerciale Bruxelles-Mosca fino agli 8,1 miliardi di euro di novembre 2022. Ciò a seguito dell’effetto combinato della diminuzione della domanda comunitaria, dell’assestamento autunnale dei prezzi delle materie prime (grafico 3) e della diversificazione degli approvvigionamenti dei Paesi Ue.
Le ripercussioni negative dei provvedimenti restrittivi comminati alla Russia sulla dinamica economica e commerciale dei paesi dell’U.e. nel 2022, anche in considerazione degli effetti contrastanti sugli stessi parametri di Mosca, non ha purtroppo costituito elemento di riflessione né a Bruxelles, né tanto meno nelle cancellerie occidentali, incuranti del netto peggioramento che stavano registrando i loro parametri macroeconomici.
I governi europei invece di prendere atto del boomerang che stava ritornando minacciosamente verso di loro a seguito del piano REPowerEU e dei 10 pacchetti sanzionatori introdotti13, ignorando l’Outlook di ottobre del Fmi che dava la Russia in recupero dal -8,5% di aprile al – 3,4%14 di quel mese e i dati Eurostat sulla bilancia commerciale Ue in pesante passivo (tab. 2), hanno scelleratamente continuato, per servilismo verso Washington, sulla stessa strada introducendo l’undicesimo, il 16 dicembre15. Finendo in tal modo per creare le condizioni per il disastro economico-commerciale per l’anno 2022 che abbiamo esposto e per il 2023 che analizzeremo in seguito.
“Il mal voluto non è mai abbastanza” recita un vecchio adagio popolare pisano…
Andrea Vento – 21 febbraio 2024
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1 “Secondo i dati ufficiali del Ministero del Commercio indiano, da aprile (mese di inizio dell’anno fiscale) a dicembre 2022 l’interscambio cumulato di beni tra Russia e India è ammontato a 35 miliardi di dollari, aumentando di quasi 4 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con l’export verso la Russia che si contrae del 13,5%, il balzo si deve esclusivamente all’enorme crescita dell’import indiano da Mosca, pari a 32,8 (+399% su base annua)”.
2 “Kpler spiega che l’Europa rappresenta circa il 50% delle esportazioni di carburante per aerei indiano con Francia, Turchia, Belgio e Paesi Bassi tra i principali consumatori europei di diesel raffinato nel paese asiatico”
https://greenreport.it/news/energia/lindia-sta-vendendo-diesel-russo-allunione-europea
3 https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-105-trillion-world-economy-in-one-chart/
4 Il mercato spot e anche denominato mercato a pronti o mercato cash poiché la liquidazione dei contratti di compravendita negoziati in ogni giornata è eseguita con un differimento molto breve (pochi giorni). Il differimento è comunque legato solo a ragioni tecniche e l’acquirente deve disporre del denaro e il venditore deve disporre degli strumenti negoziati il giorno stesso nel quale lo scambio è effettuato. Essi si contrappongono ai mercati a termine nei quali, invece, i contratti conclusi dagli operatori prevedono una liquidazione differita nel tempo, anche di alcuni mesi. In questi mercati inoltre venditore e acquirente possono non disporre degli strumenti negoziati e del loro (intero) controvalore al momento dello scambio. Fonte: https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/mercato-spot.html
5 https://www.limesonline.com/cartaceo/il-suicidio-economico-della-russia
6 https://www.milanofinanza.it/news/russia-verso-il-default-tecnico-non-paga-cedole-per-29-mld-rublo-sbriciolato-202203021104414596
7 https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_paesi=88#
8 Eurostat: Commercio internazionale di beni 2022 – https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods#EU_trade_increased_strongly_in_2022
9 Nel 2020 la bilancia commerciale Ue ha registrato il più rilevante attivo dell’ultimo decennio dopo il triennio 2015-17
10 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/DDN-20230331-1
11https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_LT_INTERTRD__custom_5507953/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=ef704ca5-8523-4e0d-b22f-c34fba0e0159
12https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/EXT_ST_EU27_2020SITC__custom_4653539/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=c588302b-a6e2-4cba-bce8-5714f45c3c1d
13 I primi 10 pacchetti sanzionatori dell’Ue alla Russia sono stati introdotti il 23, il 25 e il 28 febbraio, il 2, il 9 e il 15 marzo, il 8 aprile, il 3 giugno, il 21 luglio e il 6 ottobre 2022
14 mf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022#:~:text=Press%20Briefing%3A%20World%20Economic%20Outlook%2C%20October%202022,-October%2011%2C%202022&text=The%20IMF%20forecasts%20global%20growth,2022%20and%202.7%25%20in%202023.
15 Per il dettaglio delle tranche di sanzioni Ue: https://www.confindustria.it/home/crisi-ucraina/sanzioni
Come la CIA destabilizza il mondo

di Jeffrey D. Sachs
La portata del continuo caos derivante dalle operazioni della CIA andate male è sbalorditiva. In Afghanistan, Haiti, Siria, Venezuela, Kosovo, Ucraina e molto altro ancora, le morti inutili, l’instabilità e la distruzione scatenate dalla sovversione della CIA continuano ancora oggi. I media tradizionali, le istituzioni accademiche e il Congresso dovrebbero indagare su queste operazioni al meglio delle loro possibilità e chiedere la pubblicazione di documenti per consentire una responsabilità democratica.
La CIA ha tre problemi fondamentali: i suoi obiettivi, i suoi metodi e la sua mancanza di responsabilità. I suoi obiettivi operativi sono quelli che la CIA o il Presidente degli Stati Uniti definiscono essere nell’interesse degli Stati Uniti in un determinato momento, indipendentemente dal diritto internazionale o dalle leggi statunitensi. I suoi metodi sono segreti e doppi. L’assenza di responsabilità significa che la CIA e il Presidente gestiscono la politica estera senza alcun controllo pubblico. Il Congresso è uno zerbino, uno spettacolo secondario.
Come ha detto un recente direttore della CIA, Mike Pompeo, parlando del suo periodo alla CIA: “Ero il direttore della CIA. Mentivamo, imbrogliavamo, rubavamo. Avevamo interi corsi di formazione. Ti ricorda la gloria dell’esperimento americano”.
La CIA fu istituita nel 1947 come successore dell’Office of Strategic Services (OSS). L’OSS aveva svolto due ruoli distinti durante la Seconda guerra mondiale, l’intelligence e la sovversione. La CIA assunse entrambi i ruoli. Da un lato, la CIA doveva fornire informazioni al governo degli Stati Uniti. Dall’altro, la CIA doveva sovvertire il “nemico”, cioè chiunque il presidente o la CIA definissero tale, utilizzando un’ampia gamma di misure: assassinii, colpi di stato, inscenare disordini, armare gli insorti e altri mezzi.
Quest’ultimo ruolo si è rivelato devastante per la stabilità globale e per lo Stato di diritto statunitense. Un ruolo che la CIA continua a perseguire anche oggi. In effetti, la CIA è un esercito segreto degli Stati Uniti, capace di creare scompiglio in tutto il mondo senza alcuna responsabilità.
Quando il Presidente Dwight Eisenhower decise che l’astro nascente della politica africana, il democraticamente eletto Patrice Lumumba dello Zaire (oggi Repubblica Democratica del Congo), era il “nemico”, la CIA cospirò nel suo assassinio nel 1961, minando così le speranze democratiche dell’Africa. Non sarebbe stato l’ultimo presidente africano abbattuto dalla CIA.
Nei suoi 77 anni di storia, la CIA è stata chiamata a rispondere pubblicamente solo una volta, nel 1975. In quell’anno, il senatore dell’Idaho Frank Church guidò un’indagine del Senato che rivelò la scioccante furia della CIA in fatto di assassinii, colpi di stato, destabilizzazione, sorveglianza, torture ed “esperimenti” medici in stile Mengele.
La denuncia da parte del Comitato Church delle scioccanti malefatte della CIA è stata recentemente riportata in un superbo libro del reporter investigativo James Risen, The Last Honest Man: The CIA, the FBI, the Mafia, and the Kennedys-and One Senator’s Fight to Save Democracy.
Quel singolo episodio di svista si verificò a causa di una rara confluenza di eventi.
L’anno prima del Comitato Church, lo scandalo Watergate aveva rovesciato Richard Nixon e indebolito la Casa Bianca. Come successore di Nixon, Gerald Ford non era stato eletto, era un ex membro del Congresso ed era riluttante ad opporsi alle prerogative di supervisione del Congresso. Lo scandalo Watergate, su cui aveva indagato la Commissione Ervin del Senato, aveva inoltre dato potere al Senato e dimostrato il valore della supervisione del Senato sugli abusi di potere dell’Esecutivo. In particolare, la CIA era da poco guidata dal direttore William Colby, che voleva ripulire le operazioni della CIA. Inoltre, il direttore dell’FBI J. Edgar Hoover, autore di illegalità pervasive esposte anche dalla commissione Church, era morto nel 1972.
Nel dicembre 1974, il giornalista investigativo Seymour Hersh, allora come oggi un grande reporter con fonti all’interno della CIA, pubblicò un resoconto delle operazioni illegali di intelligence della CIA contro il movimento antiguerra statunitense. Il leader della maggioranza del Senato dell’epoca, Mike Mansfield, un leader di carattere, nominò Church per indagare sulla CIA. Church stesso era un senatore coraggioso, onesto, intelligente, indipendente e intrepido, caratteristiche che scarseggiano cronicamente nella politica statunitense.
Se solo le operazioni disoneste della CIA fossero state consegnate alla storia come risultato dei crimini denunciati dalla Commissione Church, o almeno avessero portato la CIA sotto lo stato di diritto e la responsabilità pubblica. Ma non è stato così. La CIA ha avuto l’ultima risata – o meglio, ha fatto piangere il mondo – mantenendo il suo ruolo preminente nella politica estera degli Stati Uniti, compresa la sovversione all’estero.
Dal 1975, la CIA ha condotto operazioni segrete di sostegno ai jihadisti islamici in Afghanistan, che hanno distrutto completamente l’Afghanistan e dato origine ad Al-Qaeda. La CIA ha probabilmente condotto operazioni segrete nei Balcani contro la Serbia, nel Caucaso contro la Russia e in Asia centrale contro la Cina, tutte con l’impiego di jihadisti sostenuti dalla CIA. Negli anni 2010, la CIA ha condotto operazioni mortali per rovesciare la Siria di Bashir al-Assad, sempre con jihadisti islamici. Per almeno 20 anni, la CIA è stata profondamente coinvolta nella fomentazione della crescente catastrofe in Ucraina, compreso il violento rovesciamento del Presidente Viktor Yanukovych nel febbraio 2014, che ha innescato la devastante guerra che ora sta travolgendo l’Ucraina.
Cosa sappiamo di queste operazioni? Solo le parti che gli informatori, alcuni intrepidi reporter investigativi, una manciata di coraggiosi studiosi e alcuni governi stranieri sono stati disposti o in grado di raccontarci, con tutti questi potenziali testimoni che sapevano di poter incorrere in una severa punizione da parte del governo statunitense. La responsabilità dello stesso governo americano è stata scarsa o nulla, così come la supervisione o la limitazione imposta dal Congresso. Al contrario, il governo è diventato sempre più ossessivamente segreto, perseguendo azioni legali aggressive contro la divulgazione di informazioni classificate, anche quando, o soprattutto quando, tali informazioni descrivono le azioni illegali del governo stesso.
Di tanto in tanto, un ex funzionario statunitense vuota il sacco, come quando Zbigniew Brzezinski ha rivelato di aver indotto Jimmy Carter a incaricare la CIA di addestrare jihadisti islamici per destabilizzare il governo dell’Afghanistan, con l’obiettivo di indurre l’Unione Sovietica a invadere quel Paese.
Nel caso della Siria, abbiamo appreso da alcuni articoli del New York Times nel 2016 e nel 2017 delle operazioni sovversive della CIA per destabilizzare la Siria e rovesciare Assad, come ordinato dal Presidente Barack Obama. Ecco il caso di un’operazione della CIA terribilmente sbagliata, in palese violazione del diritto internazionale, che ha portato a un decennio di caos, a un’escalation della guerra regionale, a centinaia di migliaia di morti e a milioni di sfollati, eppure non c’è stato un solo riconoscimento onesto di questo disastro guidato dalla CIA da parte della Casa Bianca o del Congresso.
Nel caso dell’Ucraina, sappiamo che gli Stati Uniti hanno svolto un importante ruolo segreto nel violento colpo di Stato che ha fatto cadere Yanukovych e che ha trascinato l’Ucraina in un decennio di spargimenti di sangue, ma a tutt’oggi non ne conosciamo i dettagli. La Russia ha offerto al mondo una finestra sul colpo di Stato intercettando e poi pubblicando una telefonata tra Victoria Nuland, allora Vicesegretario di Stato americano (ora Sottosegretario di Stato) e l’Ambasciatore americano in Ucraina Geoffrey Pyatt (ora Vicesegretario di Stato), in cui si tracciava il governo post-golpe. Dopo il colpo di Stato, la CIA ha addestrato segretamente le forze operative speciali del regime post-golpe che gli Stati Uniti avevano contribuito a portare al potere. Il governo statunitense ha taciuto sulle operazioni segrete della CIA in Ucraina.
Abbiamo buone ragioni per credere che siano stati gli agenti della CIA a distruggere il gasdotto Nord Stream, come ha affermato Seymour Hersh, che ora è un reporter indipendente. A differenza del 1975, quando Hersh lavorava per il New York Times, quando il giornale cercava ancora di chiedere conto al governo, il Times non si degna nemmeno di esaminare la testimonianza di Hersh.
Chiedere alla CIA di rendere conto pubblicamente è ovviamente una lotta in salita. I presidenti e il Congresso non ci provano nemmeno. I media tradizionali non indagano sulla CIA, preferendo invece citare “alti funzionari senza nome” e l’insabbiamento ufficiale. I media mainstream sono pigri, subornati, timorosi degli introiti pubblicitari del complesso militare-industriale, minacciati, ignoranti o tutte queste cose? Chi lo sa.
C’è un piccolo barlume di speranza. Nel 1975, la CIA era guidata da un riformatore. Oggi la CIA è guidata da William Burns, uno dei principali diplomatici americani di lunga data. Burns conosce la verità sull’Ucraina, poiché è stato ambasciatore in Russia nel 2008 e ha informato Washington del grave errore di spingere l’allargamento della NATO all’Ucraina. Data la statura e i risultati diplomatici di Burns, forse sosterrebbe l’urgente necessità di un’assunzione di responsabilità.
La portata del continuo caos derivante dalle operazioni della CIA andate male è sbalorditiva. In Afghanistan, Haiti, Siria, Venezuela, Kosovo, Ucraina e molto altro ancora, le morti inutili, l’instabilità e la distruzione scatenate dalla sovversione della CIA continuano ancora oggi. I media tradizionali, le istituzioni accademiche e il Congresso dovrebbero indagare su queste operazioni al meglio delle loro possibilità e chiedere la pubblicazione di documenti per consentire una responsabilità democratica.
L’anno prossimo ricorre il 50° anniversario delle audizioni del Comitato Church. A cinquant’anni di distanza, con il precedente, l’ispirazione e la guida dello stesso Church Committee, è urgente aprire le tende, rivelare la verità sul caos guidato dagli Stati Uniti e dare inizio a una nuova era in cui la politica estera degli Stati Uniti diventi trasparente, responsabile, soggetta allo stato di diritto sia interno che internazionale e diretta alla pace globale piuttosto che alla sovversione di presunti nemici.
FONTE: https://www.acro-polis.it/2024/02/13/come-la-cia-destabilizza-il-mondo/
MARIO DRAGHI: La globalizzazione ha fallito

Il discorso tenuto da Mario Draghi al Nabe, Economic Policy Conference di Washington è utile oggetto di lettura e di riflessione. Possibilmente senza restare avvinghiati dalla terminologia liturgica (d’obbligo per Draghi) dell’economia mainstream. Tentando quindi di estrarre dal lungo e in molte parti condivisibile ragionamento le questioni essenziali che possono anche essere riepilogate con un altro linguaggio, più comprensibile e svincolato dallo schema ideologico approntato nei territori del “miliardo d’oro” per attraversare la declinante epoca post-globale: quella per cui, come sostiene Mario Draghi, si dovrebbero preservare i valori alla base della civiltà occidentale evitando che le spinte interne ed esterne mettano definitivamente al tappeto questa costruzione.
Al netto dunque, dell'”ingratitudine” con cui Cina e altri paesi emergenti hanno colto il meglio di ciò che potevano ricevere dalla globalizzazione neoliberista senza venire abbagliati e penetrati dal complesso di valori che dovevano andare a braccetto con essa e conservando le architetture – autoritarie… – proprie degli altri mondi; al netto del fatto che la loro apertura all’occidente è stata solo utilitaristica e non ha consentito “l’esportazione della democrazia”; al netto cioè delle espressioni di natura ideologica a cui evidentemente ci si deve continuare ad aggrappare, tuttavia il discorso di Mario Draghi fotografa lo stato dell’arte di questi ultimi decenni in un modo che fino ad ora non aveva azzardato. E i consigli che dispensa senza remore sembrano essere un messaggio forte alle elites politiche e finanziarie, in parte ancora immerse nel sogno di un mercato che se la può cavare anche senza la politica, o meglio, orientando, come loro meglio aggrada, la dimensione politica nazionale e continentale europea.
Draghi taglia la storia in un prima (di cui è stato uno dei massimi interpreti) e un dopo (in cui sembra aspirare a mantenere quantomeno un ruolo di suggeritore di rango): l’epoca di prima è finita ed è fallita rispetto ai suoi obiettivi; ne è arrivata un’altra, che necessita di una impalcatura molto diversa, soprattutto per l’indispensabile funzione di riequilibrio che la politica dovrà svolgervi se non si vuole che il fallimento si trasformi in sconfitta definitiva.
La politica, nella nuova fase, è chiamata a garantire la riproduzione del territorio – spaziale e valoriale – dell’ Occidentale (una sorta di arrocco preservativo), ma soprattutto a riprodurre concrete condizioni di egemonia all’interno di questo spazio; vale a dire le condizioni materiali per cui gli abitanti/produttori/consumatori/elettori che lo abitano possano garantire il consenso necessario alla sua stabilizzazione. Altrimenti la creatura andrà in fumo, attratta, come sarà, dalle sirene dell’autoritarismo o di altre prospettive e aggredita da una frantumazione ideale e culturale.
Depurato dai suoi elementi ideologici, il discorso propone alcune correzioni al modello: recupera approcci di riequilibrio tra mercato e politica, (con la prevalenza della seconda che dovrebbe caratterizzare l’epoca in cui siamo entrati), di riequilibrio tra flussi di capitale (da sottrarre alla speculazione e riorientare verso gli investimenti), di riequilibrio nella distribuzione della ricchezza (con adeguate politiche salariali, fiscali e monetarie) in modo tale che le spinte disgregative vengano contenute e ricomposte.
Si tratta di una sorta di manuale di politica interna allo spazio occidentale e ai singoli paesi che lo compongono: i quali dovrebbero quindi attrezzarsi alla modifica sostanziale degli approcci prevalenti seguiti fino ad ora, con il passaggio dall’orientamento all’export che ha consentito enormi surplus solo ad alcuni paesi guida della fase di globalizzazione (e alle loro grandi imprese multinazionali, non citate), ad un ri-orientamento al/ai mercati interni tale da migliorarne le condizioni di vita e ambientali.
Un nuovo modello di competizione quindi, che dovrebbe recuperare la logica dei “massimi e migliori sistemi”, (inevitabilmente analoga al tempo della guerra fredda) che è al tempo stesso competizione culturale, organizzativa e redistributiva, quindi competizione ideale che deve essere corroborata da evidenti e concreti risultati ben percepibili dalle masse.
In tutto il discorso Draghi non cita, se non indirettamente quando accenna alle delocalizzazioni e alla competizione sul costo del lavoro, il ruolo centrale delle grandi imprese globali che sono state i soggetti reali della globalizzazione e i veri percettori dei sui vantaggi, come si evince dai picchi di ricchezza raggiunti e accumulati in sempre meno mani: ciò che in senso traslato definiamo “i mercati”. Ma si capisce che il bersaglio sono proprio loro. Non l’astratta globalizzazione ha fallito, ma queste grandi imprese hanno fallito nella loro presunzione di regolare il mondo e gli stessi Stati con gli annessi popoli che li abitano.
E allo stesso tempo, a parte le ovvie e necessitate invettive sull’autoritarismo, sembra di cogliere il riconoscimento di una superiorità verificabile di quei paesi che hanno mantenuto o potenziato la funzione della politica come centro decisivo di progettazione e programmazione economica e sociale: la Cina, da questo punto di vista è certamente l’esempio principe, nella sua capacità di aver utilizzato tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione sottraendosi però alla reclamata (da USA & C.) permeabilità totale dei flussi di capitale, a meno che non fossero destinati o destinabili agli investimenti. Ma è proprio il mancato rispetto di queste “regole” di libertà di scorazzare dei flussi di capitale internazionale ad aver consentito il grande sviluppo della Cina, poiché il loro orientamento produttivo ha permesso con successive messe a punto, un sensibile miglioramento delle condizioni di vita di centinaia di milioni di persone. (Cosa che non ha fatto in maniera adeguata l’Occidente).
In questa competizione tra modelli e sistemi, tra grandi gruppi monopolistici e Stato, sembrano aver fallito i primi e aver vinto il secondo. Dunque, da quanto si coglie dal discorso, bisognerebbe seguire il modello vincente; rivisto e corretto sulla base dei principi costitutivi dello spazio occidentale.
Che questa scelta debba necessariamente implicare un nuovo keynesismo di guerra con massicci investimenti sulla “sicurezza” militare non viene detto. Forse è una variabile implicita dell’approccio proposto. O forse no. La questione, è che ciò che è da salvaguardare non è un generico e impersonale Occidente, ma i suoi attori reali (che continuano ad essere in primis le grandi imprese globali non citate). Il discorso di Draghi puntualizza cioè il perimetro del confronto tra le elìtes di questa parte di mondo e della vaga Europa.
Discorso integrale di Mario Draghi al Nabe, Economic Policy Conference di Washington, durante il conferimento del premio Paul A. Volcker Lifetime Achievement Award
Tutti i governi, fino a non molto tempo fa, nutrivano grandi aspettative sulla globalizzazione, intesa come integrazione dinamica dell’economia mondiale. Si pensava che la globalizzazione avrebbe aumentato la crescita e il benessere a livello mondiale, grazie a un’organizzazione più efficiente delle risorse mondiali. Man mano che i Paesi sarebbero diventati più ricchi, più aperti e più orientati al mercato, si sarebbero diffusi i valori democratici insieme allo Stato di diritto. E tutto ciò avrebbe reso le economie emergenti più produttive nelle istituzioni multilaterali, legittimando ulteriormente l’ordine globale. Lo stato d’animo prevalente è stato ben colto da George H.W. Bush nel 1991, quando ha affermato che “nessuna nazione sulla Terra ha scoperto un modo per importare i beni e i servizi del mondo fermando le idee alla frontiera”.
Questo circolo virtuoso porterebbe anche a una “uguaglianza per difetto”, nel senso che non sarebbe necessaria alcuna politica governativa specifica per raggiungerla. Piuttosto, avremmo una convergenza armoniosa verso standard di vita più elevati, valori universali e stato di diritto internazionale. Non c’è dubbio che alcune di queste aspettative si siano realizzate. L’apertura dei mercati globali ha portato decine di Paesi nell’economia mondiale e ha fatto uscire dalla povertà milioni di persone – 800 milioni solo in Cina negli ultimi 40 anni. Ha generato il più ampio e rapido miglioramento della qualità della vita mai visto nella storia. Ma il nostro modello di globalizzazione conteneva anche una debolezza fondamentale. La persistenza del libero scambio fra Paesi necessita che vi siano regole internazionali e regolamenti delle controversie recepite da tutti i Paesi partecipanti. Ma in questo nuovo mondo globalizzato, l’impegno di alcuni dei maggiori partner commerciali a rispettare le regole è stato ambiguo fin dall’inizio. A differenza del mercato unico dell’Ue, dove il rispetto delle regole è intrinseco e avviene attraverso la Corte di giustizia europea, le organizzazioni internazionali create per supervisionare l’equità del commercio globale non sono mai state dotate di indipendenza e poteri equivalenti. Pertanto, l’ordine commerciale mondiale globalizzato è sempre stato vulnerabile a una situazione in cui qualsiasi Paese o gruppo di Paesi poteva decidere che il rispetto delle regole non sarebbe servito ai propri interessi a breve termine.
Per fare solo un esempio, nei primi 15 anni di adesione all’Organizzazione Mondiale del Commercio (Omc), la Cina non ha notificato all’Omc alcun sussidio del governo sub-centrale, nonostante la maggior parte dei sussidi sia erogata dai governi provinciali e locali. Questa inadempienza era nota da anni: già nel 2003 si era notato che gli sforzi della Cina per l’attuazione dell’Omc avevano “perso un notevole slancio”, ma l’indifferenza ha prevalso e non è stato fatto nulla di concreto per affrontarla. Le conseguenze di questa scarsa conformità a regole condivise sono state economiche, sociali e politiche.
La globalizzazione ha portato a grandi squilibri commerciali, ed i responsabili politici hanno tardato a riconoscerne le conseguenze. Questi squilibri sono sorti in parte perché l’apertura del commercio avveniva tra Paesi con livelli di sviluppo molto diversi, il che ha limitato la capacità dei Paesi più poveri di assorbire le importazioni da quelli più ricchi e ha dato loro la giustificazione per proteggere le industrie domestiche nascenti dalla concorrenza estera. Ma riflettono anche scelte politiche deliberate in ampie parti del mondo per accumulare avanzi commerciali e limitare l’aggiustamento del mercato.
Dopo la crisi del 1997, le economie dell’Asia orientale hanno utilizzato le eccedenze commerciali per accumulare grandi riserve valutarie e autoassicurarsi contro gli shock della bilancia dei pagamenti, soprattutto impedendo l’apprezzamento dei tassi di cambio, mentre la Cina ha perseguito una strategia deliberata a lungo termine per liberarsi dalla dipendenza dall’Occidente per i beni capitali e la tecnologia. Dopo la crisi dell’eurozona del 2011, anche l’Europa ha perseguito una politica di accumulo deliberato di avanzi delle partite correnti, anche se in questo caso attraverso le errate politiche fiscali procicliche sancite dalle nostre regole che hanno depresso la domanda interna e il costo del lavoro. In una situazione in cui i meccanismi di solidarietà dell’Ue erano limitati, questa posizione poteva persino essere comprensibile per i paesi che dipendevano dai finanziamenti esterni. Ma anche quelli con posizioni esterne forti, come la Germania, hanno seguito questa tendenza. Queste politiche hanno fatto sì che le partite correnti dell’area dell’euro siano passate da un sostanziale equilibrio prima della crisi a un massimo di oltre il 3% del Pil nel 2017. A questo picco, si trattava in termini assoluti del più grande avanzo delle partite correnti al mondo. In percentuale del Pil mondiale, solo la Cina nel 2007-08 e il Giappone nel 1986 hanno registrato un avanzo più elevato.
L’accumulo di eccedenze ha portato a un aumento del risparmio globale in eccesso e a un calo dei tassi reali globali, un fenomeno rilevato da Ben Bernanke già nel 2005. A questo non è corrisposto un aumento della domanda di investimenti. Gli investimenti pubblici sono diminuiti di quasi due punti percentuali nei Paesi del G7 dagli anni ’90 al 2010, mentre gli investimenti del settore privato si sono bloccati una volta che le imprese hanno ridotto la leva finanziaria dopo la grande crisi finanziaria. Questo calo dei tassi reali ha contribuito in modo sostanziale alle sfide incontrate dalla politica monetaria negli anni 2010, quando i tassi di interesse nominali sono stati schiacciati sul limite inferiore. La politica monetaria è stata ancora in grado di generare occupazione attraverso misure non convenzionali e ha prodotto risultati migliori di quanto molti si aspettassero. Ma queste misure non sono state sufficienti per eliminare completamente il rallentamento del mercato del lavoro. Le conseguenze sociali si sono manifestate in una perdita secolare di potere contrattuale nelle economie avanzate, poiché i posti di lavoro sono stati spostati dalla delocalizzazione o le richieste salariali sono state contenute dalla minaccia della delocalizzazione.
Nelle economie del G7, le esportazioni e le importazioni totali di beni sono aumentate di circa 9 punti percentuali dall’inizio degli anni ’80 alla grande crisi finanziaria, mentre la quota di reddito del lavoro è scesa di circa 6 punti percentuali in quel periodo. Si è trattato del calo più marcato da quando i dati relativi a queste economie sono iniziati nel 1950. Ne sono seguite le conseguenze politiche. Di fronte a mercati del lavoro fiacchi, investimenti pubblici in calo, diminuzione della quota di manodopera e delocalizzazione dei posti di lavoro, ampi segmenti dell’opinione pubblica dei Paesi occidentali si sono giustamente sentiti “lasciati indietro” dalla globalizzazione. Di conseguenza, contrariamente alle aspettative iniziali, la globalizzazione non solo non ha diffuso i valori liberali, perché la democrazia e la libertà non viaggiano necessariamente con i beni e i servizi, ma li ha anche indeboliti nei Paesi che ne erano i più forti sostenitori, alimentando invece l’ascesa di forze orientate verso l’interno.
La percezione dell’opinione pubblica occidentale è diventata quella che i cittadini comuni stessero giocando in un gioco imperfetto, che aveva causato la perdita di milioni di posti di lavoro, mentre i governi e le imprese rimanevano indifferenti. Al posto dei canoni tradizionali di efficienza e ottimizzazione dei costi, i cittadini volevano una distribuzione più equa dei benefici della globalizzazione e una maggiore attenzione alla sicurezza economica. Per ottenere questi risultati, ci si aspettava un uso più attivo dello “statecraft” (l’arte di governare), che si trattasse di politiche commerciali assertive, protezionismo o redistribuzione. Una serie di eventi ha poi rafforzato questa tendenza. In primo luogo, la pandemia ha sottolineato i rischi di catene di approvvigionamento globali estese per beni essenziali come farmaci e semiconduttori. Questa consapevolezza ha portato al cambiamento di molte economie occidentali verso il re-shoring delle industrie strategiche e l’avvicinamento delle catene di fornitura critiche.
La guerra di aggressione in Ucraina ci ha poi indotto a riesaminare non solo dove acquistiamo i beni, ma anche da chi. Ha messo in luce i pericoli di un’eccessiva dipendenza da partner commerciali grandi e inaffidabili che minacciano i nostri valori. Ora, ovunque vediamo che la sicurezza degli approvvigionamenti – di energia, terre rare e metalli – sta salendo nell’agenda politica. Questo cambiamento si riflette nell’emergere di blocchi di nazioni che sono in gran parte definiti dai loro valori comuni e sta già portando a cambiamenti significativi nei modelli di commercio e investimento globali. Dall’invasione dell’Ucraina, ad esempio, il commercio tra alleati geopolitici è cresciuto del 4-6% in più rispetto a quello con gli avversari geopolitici. Anche la quota di Ide che si svolge tra Paesi geopoliticamente allineati è in aumento. E, nel frattempo, è aumentata l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico. Raggiungere lo zero netto in tempi sempre più brevi richiede approcci politici radicali in cui il significato di commercio sostenibile viene ridefinito.
L’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti e, in prospettiva, il Carbon Border Adjustment Mechanism dell’Ue danno entrambi la priorità agli obiettivi di sicurezza climatica rispetto a quelli che in precedenza erano considerati effetti distorsivi sul commercio. Questo periodo di profondi cambiamenti nell’ordine economico globale comporta sfide altrettanto profonde per la politica economica. In primo luogo, cambierà la natura degli shock a cui sono esposte le nostre economie. Negli ultimi trent’anni, le principali fonti di disturbo della crescita sono state gli shock della domanda, spesso sotto forma di cicli del credito. La globalizzazione ha causato un flusso continuo di shock positivi dell’offerta, in particolare aggiungendo ogni anno decine di milioni di lavoratori al settore commerciale delle economie emergenti. Ma questi cambiamenti sono stati per lo più fluidi e continui. Ora, con l’avanzamento della Cina nella catena del valore, non sarà sostituita da un altro esportatore di rallentamento del mercato del lavoro globale. Al contrario, è probabile che si verifichino shock negativi dell’offerta più frequenti, più gravi e anche più consistenti, mentre le nostre economie si adattano a questo nuovo contesto.
È probabile che questi shock dell’offerta derivino non solo da nuovi attriti nell’economia globale, come conflitti geopolitici o disastri naturali, ma ancor più dalla nostra risposta politica per mitigare tali attriti. Per ristrutturare le catene di approvvigionamento e decarbonizzare le nostre economie, dobbiamo investire un’enorme quantità di denaro in un orizzonte temporale relativamente breve, con il rischio che il capitale venga distrutto più velocemente di quanto possa essere sostituito. In molti casi, stiamo investendo non tanto per aumentare lo stock di capitale, quanto per sostituire il capitale che viene reso obsoleto da un mondo in continua evoluzione. Per illustrare questo punto, si pensi ai terminali di Gnl costruiti in Europa negli ultimi due anni per alleviare l’eccessiva dipendenza dal gas russo. Non si tratta di investimenti destinati ad aumentare il flusso di energia nell’economia, ma piuttosto a mantenerlo. Gli investimenti nella decarbonizzazione e nelle catene di approvvigionamento dovrebbero aumentare la produttività nel lungo periodo, soprattutto se comportano una maggiore adozione della tecnologia. Tuttavia, ciò implica una temporanea riduzione dell’offerta aggregata mentre le risorse vengono rimescolate all’interno dell’economia. Il secondo cambiamento chiave nel panorama macroeconomico è che la politica fiscale sarà chiamata a svolgere un ruolo maggiore, il che significa – mi aspetto – deficit pubblici persistentemente più elevati.
Il ruolo della politica fiscale è classicamente suddiviso in allocazione, distribuzione e stabilizzazione, e su tutti e tre i fronti è probabile che le richieste di spesa pubblica aumentino. La politica fiscale sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare le nuove esigenze di investimento. I governi dovranno affrontare le disuguaglianze di ricchezza e di reddito. Inoltre, in un mondo di shock dell’offerta, la politica fiscale dovrà probabilmente svolgere anche un ruolo di stabilizzazione maggiore, un ruolo che in precedenza avevamo assegnato principalmente alla politica monetaria. Abbiamo assegnato questo ruolo alla politica monetaria proprio perché ci trovavamo di fronte a shock della domanda che le banche centrali sono in grado di gestire. Ma un mondo di shock dell’offerta rende più difficile la stabilizzazione monetaria. I ritardi della politica monetaria sono in genere troppo lunghi per frenare l’inflazione indotta dall’offerta o per compensare la contrazione economica che ne deriva, il che significa che la politica monetaria può al massimo concentrarsi sulla limitazione degli effetti di secondo impatto.
Pertanto, la politica fiscale sarà naturalmente chiamata a svolgere un ruolo maggiore nella stabilizzazione dell’economia, in quanto le politiche fiscali possono attenuare gli effetti degli shock dell’offerta sul Pil con un ritardo di trasmissione più breve. Lo abbiamo già visto durante lo shock energetico in Europa, dove i sussidi hanno compensato le famiglie per circa un terzo della loro perdita di benessere – e in alcuni Paesi dell’Ue, come l’Italia, hanno compensato fino al 90% della perdita di potere d’acquisto per le famiglie più povere. Nel complesso, questi cambiamenti indicano una crescita potenziale più bassa man mano che si svolgono i processi di aggiustamento e una prospettiva di inflazione più volatile, con nuove pressioni al rialzo derivanti dalle transizioni economiche e dai persistenti deficit fiscali. Inoltre, abbiamo un terzo cambiamento: se stiamo entrando in un’epoca di maggiore rivalità geopolitica e di relazioni economiche internazionali più transazionali, i modelli di business basati su ampi avanzi commerciali potrebbero non essere più politicamente sostenibili. I Paesi che vogliono continuare a esportare beni potrebbero dover essere più disposti a importare altri beni o servizi per guadagnarsi questo diritto, pena l’aumento delle misure di ritorsione. Questo cambiamento nelle relazioni internazionali inciderà sull’offerta globale di risparmio, che dovrà essere riallocato verso gli investimenti interni o ridotto da un calo del Pil. In entrambi gli scenari, la pressione al ribasso sui tassi reali globali che ha caratterizzato gran parte dell’era della globalizzazione dovrebbe invertirsi.
Questi cambiamenti comportano conseguenze ancora molto incerte per le nostre economie. Un’area di probabile cambiamento sarà la nostra architettura di politica macroeconomica. Per stabilizzare il potenziale di crescita e ridurre la volatilità dell’inflazione, avremo bisogno di un cambiamento nella strategia politica generale, che si concentri sia sul completamento delle transizioni in corso dal lato dell’offerta, sia sullo stimolo alla crescita della produttività, dove l’adozione estesa dell’IA (intelligenza artificiale) potrebbe essere d’aiuto. Ma per fare tutto questo in fretta sarà necessario un mix di politiche appropriato: un costo del capitale sufficientemente basso per stimolare la spesa per gli investimenti, una regolamentazione finanziaria che sostenga la riallocazione del capitale e l’innovazione, e una politica della concorrenza che faciliti gli aiuti di Stato quando sono giustificati. Una delle implicazioni di questa strategia è che la politica fiscale diventerà probabilmente più interconnessa alla politica monetaria. A breve termine, se la politica fiscale avrà uno spazio sufficiente per raggiungere i suoi vari obiettivi dipenderà dalle funzioni di reazione delle banche centrali.
In prospettiva, se la crescita potenziale rimarrà bassa e il debito pubblico ai massimi storici, la dinamica del debito sarà meccanicamente influenzata dal livello più elevato dei tassi reali. Ciò significa che probabilmente aumenterà la richiesta di coordinamento delle politiche economiche, cosa non implicita nell’attuale architettura di politica macroeconomica. In effetti, questa architettura ha volutamente assegnato diverse importanti funzioni politiche ad agenzie indipendenti, che operano a distanza dai governi, in modo da essere isolate dalle pressioni politiche – e questo ha senza dubbio contribuito alla stabilità macroeconomica a lungo termine. Tuttavia, è importante ricordare che indipendenza non significa necessariamente separazione e che le diverse autorità possono unire le forze per aumentare lo spazio politico senza compromettere i propri mandati. Lo abbiamo visto durante la pandemia, quando le autorità monetarie, fiscali e di vigilanza bancaria hanno unito le forze per limitare i danni economici dei blocchi e prevenire un crollo deflazionistico. Questo mix di politiche ha permesso a entrambe le autorità di raggiungere i propri obiettivi in modo più efficace.
Allo stesso modo, nelle condizioni attuali una strategia politica coerente dovrebbe avere almeno due elementi. In primo luogo, deve esserci un percorso fiscale chiaro e credibile che si concentri sugli investimenti e che, nel nostro caso, preservi i valori sociali europei. Ciò darebbe maggiore fiducia alle banche centrali che la spesa pubblica corrente, aumentando la capacità di offerta, porterà a una minore inflazione domani. In Europa, dove le politiche fiscali sono decentralizzate, possiamo anche fare un passo avanti finanziando più investimenti collettivamente a livello dell’Unione. L’emissione di debito comune per finanziare gli investimenti amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione, alleggerendo alcune pressioni sui bilanci nazionali. Allo stesso tempo, dato che la spesa dell’Ue è più programmatica – spesso si estende su un orizzonte di più anni – la realizzazione di investimenti a questo livello garantirebbe un impegno più forte affinché la politica fiscale sia in ultima analisi non inflazionistica, cosa che le banche centrali potrebbero riflettere nelle loro prospettive di inflazione a medio termine. In secondo luogo, se le autorità fiscali dovessero definire percorsi di bilancio credibili in questo modo, le banche centrali dovrebbero assicurarsi che l’obiettivo principale delle loro decisioni siano le aspettative di inflazione.
Nei prossimi anni la politica monetaria si troverà ad affrontare un contesto difficile, in cui dovrà più che mai distinguere tra inflazione temporanea e permanente, tra spinte alla crescita salariale e spirali che si autoavverano, e tra le conseguenze inflazionistiche di una spesa pubblica buona o cattiva. In questo contesto, una misurazione accurata e un’attenzione meticolosa alle aspettative di inflazione sono il modo migliore per garantire che le banche centrali possano contribuire a una strategia politica globale senza compromettere la stabilità dei prezzi o la propria indipendenza. Questo obiettivo permette di distinguere con precisione gli shock temporanei al rialzo dei prezzi, come gli spostamenti dei prezzi relativi tra settori o l’aumento dei prezzi delle materie prime legato a maggiori investimenti, dai rischi di inflazione persistente. Abbiamo bisogno di spazio politico per investire nelle transizioni e aumentare la crescita della produttività. Le politiche economiche devono essere coerenti con una strategia e un insieme di obiettivi comuni. Ma trovare la strada per questo allineamento politico non sarà facile. Le transizioni che le nostre società stanno intraprendendo, siano esse dettate dalla nostra scelta di proteggere il clima o dalle minacce di autocrati nostalgici, o dalla nostra indifferenza alle conseguenze sociali della globalizzazione, sono profonde.
E le differenze tra i possibili risultati non sono mai state così marcate. Ma i cittadini conoscono bene il valore della nostra democrazia e ciò che ci ha dato negli ultimi ottant’anni. Vogliono preservarla. Vogliono essere inclusi e valorizzati al suo interno. Spetta ai leader e ai politici ascoltare, capire e agire insieme per progettare il nostro futuro comune.
Maccartismo in salsa europea
Coloro che dissentono dalla verità ufficiale del Parlamento Europeo che ha identificato la Russia come il nemico da combattere, sono le quinte colonne del nemico, che bisogna smascherare e mettere a tacere.
di Domenico Gallo

Il termine “maccartismo” deriva dal nome del senatore repubblicano del Wisconsin Joseph McCarthy che diresse, negli anni 50 del secolo scorso, la principale Commissione del Senato USA per la repressione delle “attività antiamericane”. L’attività della Commissione consisteva in quella che fu definita la “caccia alle streghe”. La guerra fredda generò, sul piano internazionale una forte contrapposizione fra blocchi militari che si fronteggiarono in Europa in una guerra simulata intorno ad un confine percepito come una “cortina di ferro”. Sul versante interno la guerra fu combattuta identificando come nemici gli attivisti del partito comunista, i funzionari pubblici, gli intellettuali, gli artisti, gli scrittori, sospettati di simpatie comuniste o, semplicemente, antifascisti. Professare idee non conformi alla narrazione ideologica ufficiale, o essere semplicemente sospettati di averle, comportava ogni genere di discriminazione o di esclusione dalla vita sociale. Il film Il prestanome di Woody Allen (1976) rievocò in modo magistrale la condizione dell’industria culturale nel periodo del maccartismo, quando centinaia di attori, registi e sceneggiatori, sospettati di idee sovversive, furono iscritti nella cosiddetta lista nera in seguito alle indagini della Commissione per le attività antiamericane, perdendo ogni possibilità di continuare a lavorare.
Adesso che lo spirito e la cultura della guerra fredda è ritornato in auge, attraverso la guerra calda combattuta contro la Russia sulla pelle della popolazione ucraina, ci tocca assistere anche al ritorno del maccartismo. Incredibilmente il Parlamento Europeo, che dovrebbe essere la culla dei diritti di libertà, faticosamente conquistati dai popoli europei, ha resuscitato il maccartismo, calpestando i principi solennemente sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle tradizioni costituzionali comuni ai suoi Stati membri. Lo ha fatto con una Risoluzione approvata l’8 febbraio 2024 avente ad oggetto l’ingerenza russa nei processi democratici europei. Il leit motiv della Risoluzione è lo stesso posto a fondamento del maccartismo: c’è uno Stato nemico (la Russia) i cui “agenti di influenza prendono attivamente di mira tutti i settori della vita pubblica, in particolare la cultura, la memoria storica, i media e le comunità religiose, nonché i politici e le loro famiglie” diffondendo la manipolazione delle informazioni. Vi sono esponenti politici che, prezzolati o meno, assumono posizioni filorusse, volte ad alleviare le sanzioni e l’isolamento internazionale della Russia, col rischio di influenzare i Governi e lo stesso Parlamento europeo. Coloro che dissentono dalla verità ufficiale del Parlamento Europeo che ha identificato la Russia, (già qualificata Stato sponsor del terrorismo), come il nemico contro il quale bisogna prepararsi a combattere, sono le quinte colonne del nemico, che bisogna smascherare e mettere a tacere. Per combattere meglio la disinformazione e la minaccia di ingerenze straniere, la Risoluzione raccomanda “una più stretta cooperazione con la NATO”. Dunque le c.d. “attività antiamericane” che ossessionavano il sen. MacCarty che ritornano in salsa europea e spingono il Parlamento Europeo a dichiarare che l’ingerenza russa, attraverso le quinte colonne europee “non deve restare impunita”.
La Risoluzione infine: “sottolinea il ruolo chiave del giornalismo investigativo nel rivelare i tentativi di ingerenza straniera e attività occulte”, evidentemente apprezzando quei giornali che, anche in Italia hanno costruito le liste di proscrizione dei filoputiniani, mentre si dimentica di Julen Assange, che rischia la condanna a morte nelle carceri americane per aver rivelato i crimini di guerra dello zio Sam.
Si dice che le tragedie storiche quando si ripetono si trasformano in farsa; anche in questo caso il maccartismo in salsa europea ha il sapore di una farsa, soprattutto perché in Europa la caccia alle streghe è un po’ più difficile da attuare a causa dei vincoli fastidiosi del diritto. Tuttavia la farsa può trasformarsi in tragedia poiché la delegittimazione politica di ogni pensiero critico può favorire l’avverarsi della profezia nera della guerra inevitabile con la Russia, rilanciata, da ultimo, dall’Ammiraglio olandese Rob Bauer, Presidente del Comitato militare della NATO. Bauer il 18 gennaio ha dichiarato: “Vivere in pace non è un dato di fatto. Ed è per questo che ci stiamo preparando per un conflitto con la Russia”, che potrebbe scoppiare entro “i prossimi 20 anni”. Dobbiamo evitare che la previsione dell’Ammiraglio Bauer diventi una profezia che si autoavvera. Durante le fasi più acute della Guerra Fredda, nessun leader politico o militare si era mai azzardato a dichiarare inevitabile la guerra totale con l’URSS, che infatti è stata evitata. Forse sarebbe il caso di rassegnarsi un po’ di meno alla guerra e prepararsi alla pace, valorizzando il naturale istinto di sopravvivenza del genere umano.
(articolo pubblicato sul Fatto Qutidiano del 16 febbraio 2024 con il titolo: Il maccartismo europeo sogna 20 anni di guerra)
FONTE: https://www.domenicogallo.it/2024/02/maccartismo-in-salsa-europea/
LEGGI ANCHE: https://cambiailmondo.org/2024/02/19/la-ridicola-isteria-russofoba-del-parlamento-europeo/
Moni Ovadia: Il sionismo è l’opposto dell’ebraismo. Il sionismo è antisemitismo. (VIDEO)

FONTE: OttolinaTV
Pepe Escobar – Le 5 variabili che definiranno il nostro futuro
di Pepe Escobar – ( da L’Antidiplomatico)

Alla fine degli anni Trenta, con la seconda guerra mondiale in corso e pochi mesi prima del suo assassinio, Leon Trotsky aveva già una visione di ciò che avrebbe fatto il futuro Impero del Caos…
“Per la Germania si trattava di ‘organizzare l’Europa’. Gli Stati Uniti devono ‘organizzare’ il mondo. La storia sta mettendo l’umanità di fronte all’eruzione vulcanica dell’imperialismo americano… Con un pretesto o un altro, gli Stati Uniti interverranno nel tremendo scontro per mantenere il loro dominio mondiale.”
Sappiamo tutti cosa è successo dopo. Ora ci troviamo sotto un nuovo vulcano che nemmeno Trotsky avrebbe potuto identificare: un declino degli Stati Uniti di fronte alla “minaccia” Russia-Cina. E ancora una volta l’intero pianeta è interessato da importanti mosse nello scacchiere geopolitico.
I neocons straussiani a capo della politica estera degli Stati Uniti non potrebbero mai accettare che la Russia e la Cina aprano la strada a un mondo multipolare. Per ora abbiamo l’espansionismo perpetuo della NATO come strategia per debilitare la Russia… e Taiwan come strategia per debilitare la Cina.
Eppure, negli ultimi due anni, la feroce guerra per procura in Ucraina ha solo accelerato la transizione verso un ordine mondiale multipolare, guidato dall’Eurasia.
Con l’aiuto indispensabile del Prof. Michael Hudson, riassumiamo brevemente le 5 variabili chiave che stanno condizionando l’attuale transizione.
I perdenti non dettano le condizioni
- Lo stallo: Questa è la nuova, ossessiva narrazione statunitense sull’Ucraina – sotto steroidi. Di fronte all’imminente, cosmica umiliazione della NATO sul campo di battaglia, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato hanno dovuto – letteralmente – improvvisare.
Mosca, però, on si scompone. Il Cremlino ha fissato le condizioni molto tempo fa: resa totale e niente Ucraina come parte della NATO. “Negoziare”, dal punto di vista della Russia, significa accettare queste condizioni.
E se le potenze decise a Washington optano per mettere il turbo all’armamento di Kiev, o per scatenare “le più atroci provocazioni per cambiare il corso degli eventi”, come ha affermato questa settimana il capo dell’SVR, Sergey Naryshkin, bene.
La strada da percorrere sarà sanguinosa. Nel caso in cui i soliti sospetti mettano da parte il popolare Zaluzhny e installino Budanov a capo delle Forze Armate dell’Ucraina, l’AFU sarà sotto il totale controllo della CIA – e non dei generali della NATO, come avviene tuttora.
Questo potrebbe impedire un colpo di stato militare contro il fantoccio in felpa sudata di Kiev. Ma le cose si faranno molto più brutte. L’Ucraina passerà alla Guerriglia Totale, con due soli obiettivi: attaccare i civili russi e le infrastrutture civili. Mosca, ovviamente, è pienamente consapevole dei pericoli.
Nel frattempo, i ciancioni iperattivi a diverse latitudini suggeriscono che la NATO potrebbe addirittura prepararsi a una spartizione dell’Ucraina. Qualunque sia la forma che potrebbe assumere, non sono i perdenti a dettare le condizioni: È la Russia che lo fa.
Per quanto riguarda i politici dell’UE, è prevedibile che siano in preda al panico più totale, convinti che, dopo aver fatto piazza pulita dell’Ucraina, la Russia diventerà ancora di più una “minaccia” per l’Europa. Fesserie. Non solo Mosca se ne frega di quello che “pensa” l’Europa; l’ultima cosa che la Russia vuole o di cui ha bisogno è annettere isterismi baltici o dell’Europa orientale. Inoltre, persino Jens Stoltenberg ha ammesso che “la NATO non vede alcuna minaccia da parte della Russia verso nessuno dei suoi territori”.
- BRICS: Dall’inizio del 2024, questo è il Quadro Generale: la presidenza russa dei BRICS+, che si traduce in un acceleratore di particelle verso il multipolarismo. Il partenariato strategico Russia-Cina aumenterà la produzione effettiva, in diversi settori, mentre l’Europa sprofonderà nella depressione, scatenata dalla Tempesta Perfetta delle sanzioni contro la Russia e della deindustrializzazione tedesca. E non è mica finita qui, perché Washington sta ordinando anche a Bruxelles di sanzionare la Cina su tutti i fronti.
Come afferma il Prof. Michael Hudson, siamo nel bel mezzo della “spaccatura del mondo e della svolta verso la Cina, la Russia, l’Iran, i BRICS”, uniti nel “tentativo di invertire, annullare e far retrocedere l’intera espansione coloniale che si è verificata negli ultimi cinque secoli.”
Oppure, come ha definito il Ministro degli Esteri Sergei Lavrov al Consiglio di Sicurezza dell’ONU, questo processo dei BRICS che si lasciano alle spalle i prepotenti occidentali, il cambiamento dell’ordine mondiale è come “una rissa in un parco giochi – che l’Occidente sta perdendo”.
Bye-Bye, Soft Power
- L’Imperatore Solitario: Lo “stallo” – cioè la perdita di una guerra – è direttamente collegato al suo compenso: l’Impero che schiaccia e rimpicciolisce un’Europa vassalla. Ma anche se si esercita un controllo quasi totale su tutti questi vassalli relativamente ricchi, si perde definitivamente il Sud Globale: se non tutti i loro leader, certamente la stragrande maggioranza dell’opinione pubblica. La ciliegina sulla torta tossica consiste nel sostenere un genocidio seguito dall’intero pianeta in tempo reale. Bye-bye, soft power.
- De-dollarizzazione: In tutto il Sud Globale hanno fatto i conti: se l’Impero e i suoi vassalli dell’UE possono rubare oltre 300 miliardi di dollari di riserve estere russe – a una potenza nucleare/militare di prim’ordine – possono farlo a chiunque, e lo faranno.
Il motivo principale per cui l’Arabia Saudita, ora membro dei BRICS 10, è così mite sul genocidio a Gaza è che le sue ingenti riserve di dollari sono ostaggio dell’Egemone.
Eppure la carovana che si allontana dal dollaro USA continuerà a crescere nel 2024: ciò dipenderà dalle cruciali deliberazioni incrociate all’interno dell’Unione Economica Eurasiatica (UEEA) e dei BRICS 10.
- Giardino e giungla: Ciò che Putin e Xi hanno essenzialmente detto al Sud Globale – compreso il mondo arabo ricco di energia – è abbastanza semplice. Se volete migliorare il commercio e la crescita economica, a chi vi rivolgete?
Torniamo così alla sindrome “del giardino e della giungla”, coniata per la prima volta dall’orientalista della Gran Bretagna imperiale Rudyard Kipling. Sia il concetto britannico di “fardello dell’uomo bianco” che quello americano di “Destino manifesto” derivano dalla metafora “del giardino e della giungla”.
Il NATOstan, e mica tutto, dovrebbe essere il giardino. Il Sud Globale è la giungla. Ancora Michael Hudson: allo stato attuale, la giungla sta crescendo, ma il giardino non sta crescendo “perché la sua filosofia non è l’industrializzazione. La sua filosofia è quella di fare rendite di monopolio, cioè rendite che si fanno nel sonno senza produrre valore. Si ha solo il privilegio di avere il diritto di incassare denaro su una tecnologia di monopolio che si possiede”.
La differenza oggi, rispetto ai decenni passati del “pranzo gratis” imperiale, è “un immenso spostamento del progresso tecnologico”, dal Nord America e dagli Stati Uniti verso la Cina, la Russia e alcuni nodi selezionati dell’Asia.
Guerre Eterne. E Nessun Piano B..
Se combiniamo tutte queste varianti – lo stallo, i BRICS, l’Imperatore Solitario, de-dollarizzazione, giardino e giungla – alla ricerca dello scenario più probabile, è facile vedere che l’unica “via d’uscita” per un Impero messo all’angolo è, che altro, il modus operandi predefinito: Guerre Eterne.
E questo ci porta all’attuale portaerei americana in Asia occidentale, totalmente fuori controllo ma sempre sostenuta dall’Egemone, che punta a una guerra su più fronti contro l’intero Asse della Resistenza: Palestina, Hezbollah, Siria, milizie irachene, Ansarullah nello Yemen e Iran.
In un certo senso siamo tornati all’immediato post-11 settembre, quando ciò che i neocon volevano veramente non era l’Afghanistan, ma l’invasione dell’Iraq: non solo per controllare il petrolio (cosa che alla fine non è avvenuta) ma, secondo l’analisi di Michael Hudson, “per creare essenzialmente la legione straniera dell’America sotto forma di ISIS e al– Qaeda in Iraq”. Ora, “l’America ha due eserciti che usa per combattere nel Vicino Oriente, la legione straniera ISIS/al-Qaeda (legione straniera di lingua araba) e gli israeliani.”
L’intuizione di Hudson sull’ISIS e Israele come eserciti paralleli è impagabile: entrambi combattono l’Asse della Resistenza, e mai (corsivo mio) si combattono tra loro. Il piano neocon straussiano, per quanto squallido, è essenzialmente una variante della “lotta all’ultimo ucraino”: “combattere fino all’ultimo israeliano” sulla via del Santo Graal, che è: bombardare, bombardare, bombardare l’Iran (copyright John McCain) e provocare un cambio di regime.
Così come il “piano” non ha funzionato in Iraq o in Ucraina, non funzionerà contro l’Asse della Resistenza.
Ciò che Putin, Xi e Raisi hanno spiegato al Sud Globale – in modo sia esplicito sia piuttosto sottile – è che ci troviamo proprio nel punto cruciale di una guerra di civiltà.
Michael Hudson ha fatto molto per ridurre in termini pratici questa lotta epica. Ci stiamo dirigendo verso quello che ho descritto io come techno-feudalesimo – che è il formato AI del turbo-neoliberismo a caccia di rendite? O ci stiamo dirigendo verso qualcosa di simile alle origini del capitalismo industriale?
Michael Hudson definisce un orizzonte di buon auspicio come “aumentare gli standard di vita invece di imporre l’austerità finanziaria del FMI sul blocco del dollaro”: ideare un sistema che Big Finance, Big Bank, Big Pharma e quello che Ray McGovern ha memorabilmente coniato come il MICIMATT (complesso militare-industriale-congressuale-intelligence-mediatico-universitario-tank tank) non possano controllare. Alea Jacta Est.
Articolo originale in Inglese su: Sputnik
L’ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali – parte II°
La complessa questione della dedollarizzazione

di Andrea Vento
Il Sistema Monetario Internazionale (Smi) uscito dagli Accordi di Bretton Woods ha riservato al Dollaro statunitense la duplice funzione di moneta nazionale e di valuta di riferimento nelle transazioni internazionali, concedendo alla Federal Reserve il privilegio di poter indirizzare le politiche monetarie dell’intero campo capitalistico tramite l’orientamento delle manovre sul tasso di riferimento.
L’utilizzo del Dollaro come arma politica
A partire dal febbraio 2022, con l’escalation del conflitto in Ucraina, è tuttavia emersa nella sua piena dimensione anche una terza dirompente funzione, peraltro già utilizzata in passato con portata più limitata ai danni di 22 paesi: quella sanzionatoria. Le draconiane misure coercitive imposte dal 23 febbraio 2022 unilateralmente alla Russia, in 12 tranche successive, hanno infatti determinato “la trasformazione del dollaro in arma”, espressione giustappunto coniata nell’anno in questione.
In base agli studi di Christopher Sabatini del Royal Institute of International Affairs, storico think tank inglese comunemente noto come Chathan house, “Più di un quarto dell’economia mondiale si trova a subire una forma o l’altra di sanzione” anche a causa del fatto che, secondo il Financial Times, nel corso dell’ultimo decennio “I presidenti statunitensi che si sono susseguiti hanno optato per una strategia ritenuta poco onerosa in termini di sforzi e vite umane per risolvere i problemi di politica estera”1. Conseguentemente, gli Stati Uniti, oltre a godere dei privilegi dell’indebitamento incontrollato e della facoltà di orientare le politiche monetarie internazionali, si sono arrogati anche quello dell’extraterritorialità. Possedendo, infatti, la moneta su cui è strutturato il Sim, Washington risulta in grado di imporre le proprie volontà a tutti i soggetti statuali e non che, più o meno volontariamente, utilizzano il Dollaro. Infatti, oltre ad aver recentemente sanzionato diverse banche che avevano effettuato pagamenti per conto di paesi soggetti a sanzioni unilaterali Usa e comminato o inasprito misure ai danni di vari paesi come Cuba, Venezuela, Iran, Corea del Nord, Afghanistan e Siria2, Washington imprime alle misure coercitive un inedito salto di qualità a seguito dell’intervento russo in Ucraina. Mosca viene, infatti, estromessa dal sistema di pagamenti internazionali incentrati sul Dollaro denominato Swift e subisce il congelamento di 300 miliardi di dollari di riserve proprie depositati nelle banche occidentali.
Gli economisti Michel Aglietta, Guao Bei e Camille Macaire hanno affermato che “L’uso deliberato del sistema di pagamenti internazionale in dollari per bloccare le transazioni private, riguardanti paesi che gli Stati Uniti intendono sanzionare, può solo confermare la strumentalizzazione del dollaro come evidente mezzo di dominazione politica”3.
La tendenza verso transazioni in valute alternative al dollaro
Come già evidenziato in precedenza4, l’evoluzione del ruolo del Brics e l’ampliamento dei propri obiettivi registrati nel corso degli ultimi 15 anni si sono verificati in correlazione di eventi economico-finanziari e geopolitico-militari generalmente riconducibili ai paesi del G7, Stati Uniti in primis.
Anche tale utilizzo a fini politici dell’architettura finanziaria globale a guida statunitense ha finito per consolidare, nei paesi che si sentono minacciati dall’egemonia di Washington in questo campo, la necessità di realizzare una struttura internazionale alternativa a quella basata sul Dollaro.
In sostanza si tratta di attuare strategie tese alla dedollarizzazione delle transazioni internazionali, delle riserve monetarie e degli asset finanziari, componente essenziale della strategia di ridefinizione degli equilibri strategici internazionali.
Il dibattito che si è, quindi, aperto ruota, per i paesi sanzionati o potenzialmente nelle condizioni di esserlo e per il Brics nel suo complesso, intorno ad una questione ormai divenuta ineludibile, anche secondo autorevoli economisti non allineati all’egemonia dell’Occidente: quale moneta adottare?
Un quesito tanto di semplice formulazione quanto particolarmente complesso nella sostanza in quanto l’egemonia del Dollaro è ancora ben salda e nessuna delle valute alternative, dall’Euro allo Yuan, possiedono ad oggi le caratteristiche per sostituirlo all’interno di un nuovo Sistema monetario internazionale, considerando che per assurgere a tale ruolo una moneta deve svolgere funzione di unità di conto e di strumento di riserva, vale dire poter permettere gli scambi e accantonare capitali.
I paesi trovatisi nella necessità di procedere verso lo sganciamento dal Dollaro, in assenza di una moneta concretamente alternativa, hanno comprensibilmente optato per l’adozione della propria nelle transazioni internazionali, soprattutto nelle relazioni con partner interessati all’implementazione di un nuovo ordine valutario monetario, come quelli del Brics.
Conseguentemente, soprattutto dopo febbraio 2022, sono iniziati a proliferare tutta una serie di accordi bilaterali, promossi principalmente da paesi del Brics, per l’utilizzo della valuta di entrambe o di una delle due controparti. Fra i numerosi casi, riportiamo l’annuncio del marzo 2023 fra Brasile e Cina di regolare gli scambi in Real e Yuan e, quello del mese successivo, fra India e Malesia di effettuare le transazioni in rupie.
Nuova Delhi, pur alleata militarmente con gli Usa nel Quad (Quadrilateral Security Dialogue) in funzione anticinese5, si è distinta per un particolare attivismo nel processo di disgiungimento dal Dollaro. Infatti, l’Indian Oil Corp la principale raffineria di greggio del paese, nell’estate 2022 ha acquistato 1 milione di barili di petrolio dalla Abu Dhabi National Oil Company regolando per la prima volta la transazione in rupie e dal 2022 ha acquistato ingenti quantità di greggio da Mosca sempre nella propria valuta. Inoltre, nel 2023 erano diventate ormai 18 le istituzioni finanziarie internazionali autorizzate dalla Banca centrale indiana (Reserve Bank of India-Rbi) ad aprire conti speciali per regolare i pagamenti in rupie, favorendo l’internazionalizzazione della propria divisa, anche in considerazione dei progressi compiuti in termini di convertibilità in conto capitale e di integrazione nella catena del valore globale, anche tramite la creazione di un proprio hub finanziario, la Gurajat International Finance Tech (Gift) City6.
Il processo di dedollarizzazione con finalità di carattere geopolitico risulta, tuttavia, strettamente collegato al più pragmatico aspetto della riduzione dei costi delle transazioni gravate dalla doppia conversione in dollari delle due valute dei paesi coinvolti negli scambi: dalla Rupia al Dollaro e da quest’ultimo al Rublo, nel caso di scambi commerciali Russia – India.
Altro fattore fondamentale nell’ambito di tale processo è determinato dalla imponente rete commerciale internazionale sviluppata dalla Repubblica Popolare Cinese, principale attore mondiale con un interscambio totale di ben 6.002 miliardi di euro nel 20227 e primo partner commerciale di ben 61 paesi, esattamente il doppio dei 30 degli Stati Uniti, in base ai dati forniti dalla Direzione delle statistiche sul commercio del Fmi (Dots)8
Il lento ma progressivo sganciamento dal Dollaro si scontra, tuttavia, con una serie di problematiche pratiche di non facile risoluzione. In primis, la situazione dei saldi commerciali fra i vari stati che, risultando di rado perfettamente equilibrati, determinano, nel caso di utilizzo di monete nazionali, un accumulo di valuta del paese partner, finendo per creare un problema soprattutto in presenza di valute soggette a fluttuazioni di valore e/o non facilmente convertibili. Condizione che ha determinato a maggio 2023 la sospensione delle transazioni russo-indiane in rupie9, in quanto Mosca con un saldo nettamente positivo, a seguito del vertiginoso aumento della quantità di greggio esportato (grafico 1), aveva accumulato una tale quantità di valuta indiana da divenire difficilmente impiegabile10. La soluzione è stata trovata utilizzando negli scambi fra Mosca e New Delhi anche i Dirham degli Emirati Arabi Uniti a partire dal febbraio 202311.
Grafico 1: quantità di greggio esportato dalla Russia nei 5 paesi con maggior aumento 2021 – 2022

Affinché le transazioni fra due paesi possano efficacemente avvenire nelle rispettive monete nazionali, risulta, infatti, determinante, che queste ultime possano essere trasformate in riserve valutarie, vale a dire in liquidità immediatamente utilizzabili e scarsamente soggette a marcate svalutazioni. Condizioni che al momento non possiedono le due valute principalmente designate a sostituire il Dollaro, vale a dire l’Euro e lo Yuan. Il primo in quanto l’incertezza causata dalla crisi del debito sovrano12 dei paesi periferici dell’Eurozona, iniziata nel 2010 e placata dal famoso “Wathever it takes” di Mario Draghi nel 2012, ancora ne condiziona la sua affidabilità, mentre il secondo tutt’oggi non gode della convertibilità in conto capitale ed è soggetto nei movimenti a rigidi controlli da parte delle autorità cinesi.
Affinché lo Yuan possa in futuro sostituire il Dollaro come moneta di riferimento degli scambi internazionali sarebbe dunque necessario che Pechino liberalizzi la propria divisa omologandola agli standard internazionali. Passi che il governo e la Banca centrale non sono propensi a compiere, in quanto ciò provocherebbe una rivalutazione della stessa con evidente penalizzazione nella competitività dell’export e lascerebbe mano libera al trasferimento all’estero degli ingenti capitali privati accumulati, oggi soggetti a stretti controlli. Inoltre, la deregolamentazione della moneta aumenterebbe il rischio di instabilità finanziaria in caso di turbolenze internazionali, come avvenuto del 2015-16 dopo un tentativo di parziale liberalizzazione da parte delle autorità cinesi, poi costrette a una rapida marcia indietro13.
Il processo di internazionalizzazione dello Yuan in atto, risulta pertanto trainato più dall’espansione commerciale cinese che da una precisa strategia di Pechino che al momento preferisce continuare ad attuare la politica monetaria adottata fino ad oggi, procedendo gradatamente verso l’aumento dell’utilizzo della propria divisa seguendo l’ampliamento del volume degli scambi.
Andrea Vento 27 gennaio 2024
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE
1 “China exploits sanctions to undermine dollar” Michael Stott and James Kynge Financial Times 28 agosto 2023
2 Per una panoramica completa delle sanzioni recentemente comminate dal Tesoro Usa: https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information
3Michel Aglietta, Guao Bei e Camille Macaire “La course a la suprematie monetaire mondiale”. Odie Jacob Parigi 2022
4 L’ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali – parte I di Andrea Vento
5 Le nuove alleanze militari di Washington nell’area Asia-Pacifico di Andrea Vento
6 https://www.linkiesta.it/2023/09/dollaro-valuta-mondiale-commercio/
7Commercio Cina 2022: Export 3.423 + Import 2.579 Totale: 6.002 Saldo: + 844 miliardi di euro
Fonte: https://www.infomercatiesteri.it/bilancia_commerciale.php?id_paesi=122
8 https://data.imf.org/?sk=9d6028d4f14a464ca2f259b2cd424b85
9 https://formiche.net/2023/05/russia-india-rupia-petrolio-moneta-ucraina/
10 Michel Aglietta, Guao Bei e Camille Macaire “La course a la suprematie monetaire mondiale”. Odie Jacob Parigi 2022
11 https://www.reuters.com/business/energy/indian-refiners-pay-traders-dirhams-russian-oil-2023-02-03/
12 https://www.consob.it/web/investor-education/crisi-debito-sovrano-2010-2011
13 Siamo davvero di fronte alla fine del Dollaro? Di Reanud Lambert e Dominique Plihon. Le Monde diplomatique, novembre 2023
L’ampliamento dei Brics ulteriore passo in avanti nella ridefinizione degli assetti geopolitici e geoeconomici internazionali – parte I°
di Andrea Vento
Il Bric: da aggregato geoeconomico a soggetto geopolitico
La genesi dell’acronimo Bric viene ricondotta all’economista inglese Jim O’Neil quando a fine 2001 in un documento1, redatto in qualità di Chief Economist della Banca di investimenti Goldaman Sachs, identificò il nuovo aggregato geoeconomico composto da Brasile, Russia, India e Cina come il gruppo di Paesi che, in base a caratteristiche comuni, avrebbero verosimilmente dominato l’economia mondialedel secolo appena iniziato. Pertanto, secondo O’Neil, agli Stati Uniti per poter mantenere la leadership globale anche nel XXI secolo sarebbe stato dunque necessario inglobarli nella governance economica e finanziaria mondiale egemonizzata fino a quel momento dal sistema occidentale.
I quattro paesi risultavano, infatti, accomunati da alcune caratteristiche simili da consentir loro nell’arco di alcuni lustri di posizionarsi nei piani alti della graduatoria delle potenze economiche mondiali: la condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e prospettive di forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale.
La tesi sostenuta da O’Neal non venne, tuttavia, pienamente percepita nella sua portata strategica negli ambienti di Washington, in quegli anni, peraltro, impegnati nella ridefinizione dell’assetto geopolitico mediorientale con gli interventi militari in Afghanistan e Iraq. Finì, invece, per fornire un inaspettato input aggregativo per i quattro paesi che fino ad allora avevano scarsamente cooperato dal punto di vista economico2 e geopolitico, i quali, a partire dal settembre 2006, iniziarono ad effettuare annualmente riunioni informali a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.
Il primo incontro ufficiale dei Bric a livello di Capi di Stato e di governo, che sancì il varo dell’aggregato geoecomico, si tenne a Toyako in Giappone il 9 luglio 2008 a margine del vertice del G8, allora comprendente anche la Russia. Le successive riunioni ufficiali ai massimi livelli di rappresentanza si tennero a Ekaterinburg in Russia il 16 giugno 2009 e a Brasilia il 15 aprile 2010, gettando le basi per la graduale trasformazione del BRIC da semplice aggregato geoconomicoin raggruppamento geopolitico caratterizzato dall’attuazione di strategie condivise.
Tale processo evolutivo prese le mosse dalla prima rilevante posizione comune assunta in ambito ufficiale internazionale: l’astensione in sede di Consiglio di Sicurezza sulla Risoluzione 1730 sulla Libia dell’11 marzo 20113. Infatti, oltre a Russia e Cina membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, vi erano presenti, fra i 10 a rotazione, anche Brasile e India risultando, insieme alla Germania, i 5 paesi ad astenersi sulla Risoluzione. La quale con forzature interpretative da parte francese, britannica e statunitense avrebbe a breve portato all’intervento della Nato contro le forze armate di Gheddafi e alla destrutturazione dello stato libico.
L’adesione del Sudafrica
Nel settembre 2010, le quattro potenze emergenti hanno convenuto di invitare la Repubblica Sudafricanaa partecipare alle riunioni del BRIC, per offrire rappresentatività anche al continente africano nel contesto del gruppo che aspirava a porsi alla guida del Sud globale. A partire dal successivo vertice di Sanya in Cina del 14 aprile 2011 si è aggiunto quindi il Sudafrica, determinando l’evoluzionedell’acronimo in BRICS e fornendo nuova linfa al processo di trasformazione.
Fin dalle prime riunioni ai vertici è emerso che tali potenze emergenti non condividevano solamente lo status economico comune di potenze emergenti ma che le loro finalità avrebbero assunto anche carattere geopolitico. Infatti, facendo leva sul crescente ruolo rivestito nel contesto dell’economia mondiale, il raggruppamento ha iniziato a rivendicare la necessità di realizzare un nuovo equilibrio interno all’ordine economico-finanziario mondiale che superasse quello imposto dagli Stati Uniti tramite gli Accordi di Bretton Wood del 1944. I quali sancirono, fra le varie, il ruolo centrale del Dollaro nelle transazioni internazionali e la fondazione delle due istituzioni finanziarie mondiali a guida occidentale: Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e Banca Mondiale (Bm).
L’ampliamento ha permesso al gruppo di acquisire una maggiore rappresentatività geografica e consapevolezza geopolitica, accentuando in tal modo il suo carattere dinamico e multipolare. Tuttavia, interpretare il BRICS come un blocco con caratteristiche omogenee non sarebbe risultato corretto né un decennio fa, agli inizi della loro ascesa, né tanto meno oggi in piena fase di ampliamento. Nel 2012 sussistevano, al pari di oggi, significative differenze non solo nella potenza economica (Pil totale), con la Cina già al secondo posto della graduatoria mondiale dal 2010 e il Sudafrica, a causa del suo peso demografico limitato, posizionata la 29° posto a sensibile distanza dagli altri quattro, ma anche nella superficie con India e Sudafrica distanti dagli altri tre, veri e propri sub-continenti (tabella 1). Oltre a diversità nel modello economico, nel livello di sviluppo economico (Pil pro capite) e tecnologico e in campo militare, in quest’ultimo con ruolo nettamente prevalente della Russia.
Tabella 1: potenza e livello di sviluppo economico dei Brics (Fonte Fmi) e quota di Pil, superficie e popolazione mondiale (Fonte Bm e Onu) nel 2012
| Potenza e livello di sviluppo economico Fonte: Fmi | Comparazione nel contesto mondiale Fonte: Bm, Onu | |||||||
| Stato | Pil mld $ | Pil pro capite in $ | % di Pil mondiale | % superficie terrestre | % popolazione terrestre | |||
| Cina | 8.221 (2°) | 6.807 | 10,5 | 7,2 | 19,3 | |||
| Brasile | 2.250 (7°) | 11.208 | 3,5 | 6,5 | 2,8 | |||
| Russia | 2.014 (9°) | 14.612 | 2,7 | 12,6 | 2,0 | |||
| India | 1.841 (10°) | 1.499 | 2,6 | 2,3 | 17,8 | |||
| Sudafrica | 384 (29°) | 6.618 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | |||
| Totale Brics | 19,9 | 29,5 | 42,7 | |||||
A livello militare nel 2012 i Brics non risultavano in grado di proiettare una propria potenza a livello militare e il gap con i soli Stati Uniti assumeva dimensioni considerevoli visto che la loro quota di spesa militare mondiale, nell’anno in questione, secondo il Sipri rappresentava il 19,5% del totale, al cospetto del 39% di Washington.
I progetti infrastrutturali: strumento d’espansione dell’influenza
Nel 2012, come d’altronde oggi, sussistevano alcuni fattori di divergenza soprattutto fra i membri asiatici. Russia, Cina e India evidenziavano, infatti, aspirazioni di espansione della loro influenza su porzioni del continente asiatico le quali, col tempo, sono andate consolidandosi ed anche interconnettendosi: Mosca in Asia Centrale, in Siria e in parte del Mondo arabo e in Africa, mentre Pechino, negli anni, è riuscita ha stringere un’alleanza strategica col Pakistan e ha ampliato il raggio della propria influenza con il grande progetto infrastrutturale delle Nuove vie della seta (Bri – Belt and Road Initiative) lanciato da Xi Jimping nel 2013, nel cui contesto rientra anche il corridoio Cina-Pakistan (carta 1). New Delhi invece, in ritardo rispetto alle altre due potenze emergenti asiatiche, a partire dal 2015 ha progressivamente intensificato i rapporti con Teheran con l’obiettivo di creare una sinergia infrastrutturale in grado di aggirare via mare il Pakistan, suo storico avversario, e di raggiungere l’Asia centrale via terra. In particolare la sinergia indo-iraniana ha inizialmente portato alla progettazione del corridoio India-Afghanistan-Iran4 incentrato sul porto iraniano di Chabahar sul mar Arabico (carta 1).
Carta 1: corridoio Cina Pakistan e i porti di Gwadar e Chabahar terminali di progetti concorrenziali

L’origine della collaborazione infrastrutturale euro-asiatica risale addirittura al maggio 2002 quando India, Iran e Russia hanno sottoscritto il North South Corridor Trasporter (Nsct) al quale successivamente si sono aggiunti altri 10 stati: Azerbaigian, Armenia, Bielorussia, Turchia, Kazakistan, Oman, Tagikistan, Kirghizistan, Siria, Ucraina (che probabilmente abbandonerà) e la Bulgaria come paese osservatore.
Parallelamente al processo di ampliamento del Nsct, nel 2016 è entrato in vigore l’Accordo di Ashgabat5 finalizzato allo sviluppo di una rotta di trasporto fra il mar Arabico e l’Asia centrale che è stato sottoscritto da Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakistan e Oman, al quale ha aderito anche l’India nel 2018.
La convergenza strategica fra i due progetti, a seguito anche dell’accelerazione impressa dell’escalation del conflitto in Ucraina nel febbraio 2022 e delle misure restrittive che hanno isolato la Russia a Occidente, è sfociata nella realizzazione dell’International North South Corridor Trasporter (Insct)6. Un progetto infrastrutturale multimediale, navale, ferroviario e stradale, che si estende per 7.200 km tra India, Iran Azerbaigian, Asia Centrale, Russia ed Europa, interconnesso alla rotta ferroviaria meridionale della Via della seta cinese (carta 2).
Il percorso è principalmente incentrato sul trasferimento di merci lungo l’asse strategico India – Iran – Azerbaigian – Russia, in alternativa alla più lunga e costosa rotta del Canale di Suez, assumendo particolare valenza geopolitica e geostrategica per Russia e Iran, entrambi soggetti alle sanzioni statunitensi.
Carta 2: la 3 rotte dell’Insct e la rotta ferroviaria meridionale della Via della seta terrestre cinese.

Il Corridoio Internazionale di Trasporto Nord – Sud è diventato operativo dal 7 luglio 2022, quando la società russa RZD Logistic ha annunciato di aver effettuato con successo il suo primo trasporto di merci in India per mezzo di questa infrastrutturale multimediale che offre, in base ad uno studio condotto dalla Federazione delle associazioni degli spedizionieri in India (FFFAI), un risparmio del 30% in termini di costi ed è del 40% più breve rispetto alla rotta di Suez7 (carta 2).
Come emerso dagli sviluppi della collaborazione infrastrutturale, si era, dunque, inizialmente in presenza di potenze emergenti fra loro potenzialmente competitive, le cui comuni prospettive geopolitiche col tempo hanno spinto per il superamento delle divergenze e delle controversie a favore di una crescente cooperazione strategica, pur mantenendo i rispettivi progetti di sviluppo nazionali.
Verso un Nuovo ordine internazionale
Sin dalla sua strutturazione, il percorso evolutivo del Brics ha indubbiamente beneficiato degli sviluppi delle dinamiche internazionali sia di carattere economico che geopolitico-militare.
L’aumento della loro rilevanza nel contesto dell’economia mondiale, oltre che da fattori strutturali come i più alti tassi di crescita che fisiologicamente caratterizzano le economie in via di sviluppo rispetto a quelle avanzate, è stato favorito anche da fenomeni contingenti. In primis la crisi economica, innescata dalla bolla dei mutui subprime sul mercato finanziario statunitense, la quale se da un lato ha investito, nel biennio 2008-2009, gli Stati Uniti, l’Eurozona, gli altri Paesi europei e il Giappone spingendoli nella più grave recessione dal 1929 (grafico 1), dall’altro ha solo parzialmente colpito i paesi del Bric. Nello specifico, se Sudafrica e, soprattutto, Russia, sono scese in terreno negativo, Cina e India hanno subito solo un rallentamento nella crescita (grafico 2).
Grafico 1: variazione percentuale del Pil in Cina, Usa, Eurozona e Giappone fra 2006 e 2020

Grafico 2: tasso di variazione annua del Pil dei paesi del Brics fra il 2006 e il 2015

Grafico 3: ripartizione delle quote di Prodotto Lordo Mondiale fra G7 e Brics fra 1992-2024

Tale divergente dinamica economica ha inciso sulla rimodulazione della distribuzione del Prodotto Lordo Mondiale a beneficio del Brics, la cui quota nel 2014 era arrivata al 22%, quando nel 2008 risultava del 15% e nel 2002 del 9%.
Mentre i paesi del G7 dal 63% del 2002 erano già discesi al 52% nel 2008 e ripiegati ulteriormente al 47% nel 2014 (grafico 3), a seguito anche della crisi del debito sovrano dei paesi periferici dell’Eurozona (2012-2014) che, gestito con politiche di austerità fiscali dai “rigoristi” di Bruxelles, ha causato una nuova recessione nell’Eurozona nel 2012 e in Grecia, Italia, Spagna e in Francia anche nel 2013 (grafico 4).
Grafico 4: tasso di variazione annua del Pil in Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna 1999-2013

Nuove istituzioni finanziari internazionali
Parallelamente, pure le dinamiche di carattere geopolitico e militare hanno impresso una significativa accelerazione sia al processo di integrazione del Brics, che all’ampliamento dei propri obiettivi.
In particolare, le vicende legate alla crisi Ucraina del 2014, sfociate nel colpo di stato di piazza Maidan ai danni del presidente Yanukovich, la revoca dell’autonomia agli Oblast del Donbass da parte di Kiev poi sfociata in conflitto armato e l’annessione russa della Crimea con le conseguenti nuove sanzioni economiche comminate a Mosca dall’Occidente, compresa la sospensione dal G8, hanno fornito elementi di riflessione e spinto ad importanti decisioni riguardanti persino l’architettura economico-finanziaria internazionale. Infatti, nel successivo vertice di Fortaleza in Brasile del luglio 2014 i paesi del Brics hanno affrettato i tempi procedendo alla fondazione della Nuova Banca per lo Sviluppo (New Developement Bank Brics – Ndb Brics) e di un fondo di riserva. La decisione di realizzare istituzioni finanziarie alternative rispetto a quelle create a Bretton Woods, Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e Banca mondiale (Bm), era già stata assunta nel precedente vertice di Durban in Sudafrica del marzo 2013, a seguito del rifiuto dei paesi del G7 di riformare il Fmi attuando una più equa distribuzione delle quote di voto a beneficio dei paesi emergenti.
La questione dello scontro in seno al Fmi fra Cina e Stati Uniti è risultata paradigmatica della contrapposizione strategica che si svilupperà negli anni seguenti fra le prime due economie mondiali. In breve i fatti.
Risale al 2010 l’ultima volta che il Fmi aveva modificato il sistema delle quote, queste ultime consistenti nelle partecipazioni azionarie dei vari stati al capitale del Fondo, che grosso modo corrispondono ai relativi diritti voto e, in linea teorica, avrebbero dovuto essere proporzionali al peso8 di ciascun stato nell’economia mondiale. Tuttavia, in una fase di trasformazioni degli equilibri geoeconomici globali, nel 2010 nonostante la Cina ricoprisse, in termini di Pil nominale, il 9% dell’economia mondiale, le venne assegnata solo una quota del 6,08% a causa della strenua opposizione degli Stati Uniti. Washington, infatti, risultò irremovibile nel suo intento di far rimanere come secondo possessore di quote in seno al Fmi il Giappone col 6,14%, quantunque la sua economia corrispondesse nel 2010 al 6,80% di quella mondiale.
Nonostante nominalmente le quote sarebbero dovute essere aggiornate ogni 5 anni9, la Cina continua a mantenere invariata la sua quota del 6,08% dal 2010, anche se la sua economia in rapida ascesa è arrivata nel 2023 a rappresentare il 18% di quella mondiale. Tale immobilismo è dovuto al fatto che gli Stati Uniti, pur essendo sottorappresentati in termini di diritti di voto rispetto al suo ruolo nell’economia mondiale, circa il 25%10, con il suo 16,5% detiene un sostanziale diritto di veto sulle decisioni più importanti del Fondo, le quali necessitano della maggioranza qualificata dell’85% dei voti11. In tal modo gli Stati Uniti hanno continuato sino ad oggi a bloccare l’ascesa della Cina e di altri paesi emergenti in seno al Fmi, a beneficio del Giappone e dei paesi europei.
Una situazione che ha scatenato recenti forti tensioni fra XI Jimping e Lula, da un lato, e gli Stati Uniti, dall’altro, nel round negoziale iniziato nel 2023, il quale, nonostante tutto, il 7 novembre scorso è scaturito in un accordo in seno al Consiglio esecutivo del Fondo che prevede un aumento del 50% della quota contributiva di ciascun membro, senza tuttavia modificare i rapporti di partecipazione preesistenti. La delibera dovrà passare al vaglio dell’approvazione con una maggioranza dell’85% dei voti ma, dati i rapporti di forza esistenti, sussistono pochi dubbi sul fatto che venga respinta. Una decisione che sta alimentando ulteriori tensioni fra Washington e i Brics e che ignora le richieste del Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres, il quale senza mezzi termini aveva invitato ad un riallineamento delle quote alle mutate condizioni geoeconomiche mondiali, essendo a suo dire necessario “riformare un’architettura finanziaria internazionale che è obsoleta, disfunzionale e ingiusta”12.
La mission strategica delle nuove Istituzioni finanziare internazionali, si legge nel sito della Ndb13, è quella di “finanziare progetti e trovare soluzioni su misura per contribuire a costruire un futuro più inclusivo, resiliente e sostenibile per il pianeta” tramite la creazione di partnership al fine di “integrare gli sforzi istituzioni finanziarie multilaterali e regionali per sostenere la crescita e lo sviluppo globali”.
La grande innovazione introdotta dalle nuove istituzioni, tuttavia, è costituita dal diverso approccio nell’erogazione dei finanziamenti che, infatti, vengono concessi sia ai paesi emergenti che alle altre economie sviluppate, individuandone di concerto gli obiettivi, in genere infrastrutturali, ma, soprattutto, senza subordinarli all’imposizione di vincoli e di politiche neoliberiste, le quali fino ad oggi hanno contribuito al peggioramento delle condizioni economiche e soprattutto sociali dei paesi “beneficiari”. L’Argentina ne costituisce un fulgido esempio sia in relazione ai prestiti concessi durante la presidenza Menem, in cambio del cosiddetto “Washington Consensus”14, poi sfociati nel default del 200115, sia quello del 2018 sotto la presidenza Macri di ben 45 miliardi di $, il più imponente della storia del Fmi, che ha spianato la strada all’attuale crisi economico-sociale e all’ascesa del populista di estrema destra, Milei alla guida del Paese.
La sede della Ndb è stata stabilita fin dalla fondazione a Shangai, in virtù della maggior contribuzione di capitale da parte della Cina, ed è divenuta operativa l’anno successivo nel 2016, con grandi prospettive e attese da parte dei paesi in via di sviluppo, anche alla luce della dotazione di un capitale autorizzato16 di 100 miliardi di $.
Il fondo di riserva, attivato in parallelo con Ndb, ha assunto la denominazione di Contingent Reserve Arrangement (Cra) ed ha come obiettivo primario la riduzione della dipendenza dei paesi Brics da fonti esterne di finanziamento, cercando di offrire un’alternativa al Fmi in qualità di prestatore di ultima istanza17. In sostanza, fornisce due tipi strumenti, di liquidità e precauzionali, per far fronte a pressioni a breve termine, reali o potenziali, sulla bilancia dei pagamenti.
Il Cra, prevede un impegno finanziario di 100 miliardi di $, al quale la Cina contribuisce per 41 miliardi, Russia, India e Brasile per 18 miliardi e Sudafrica per 518 (tabella 2). Tuttavia, l’accesso massimo ai fondi che i membri possono richiedere è della metà del capitale conferito per la Cina (21 miliardi), corrispondente per Russia, India e Brasile (18 miliardi) e del doppio per il Sudafrica (10 miliardi).
Tabella 2: Contingent Reserve Arrangement: capitale versato, accesso massimo ai fondi e diritti di voto19.
| Paese | Apporto di capitale (miliardi di $) | Accesso ai fondi (miliardi di $) | Diritti di voto (%) |
| Brasile | 18 | 18 | 18.10 |
| Cina | 41 | 21 | 39,95 |
| India | 18 | 18 | 18.10 |
| Russia | 18 | 18 | 18.10 |
| Sudafrica | 5 | 10 | 5,75 |
| Somma totale | 100 | 85 | 100,00 |
Il carattere plurilaterale ed inclusivo delle nuove istituzioni emerge anche dalle finalità strategiche prefissate dai fondatori che risultano, non tanto di apportare una semplice rottura nell’ordine finanziario internazionale a guida statunitense, quanto di creare una possibile alternativa sia a livello di gestione dei prestiti che in merito al Sistema Monetaria Internazionale (Sim) incentrato sull’egemonia del dollaro. Contemplano, inoltre, un significativo sforzo per promuovere l’integrazione economica e la cooperazione tra le economie emergenti in un ottica di sviluppo delle relazioni internazionali all’interno di un quadro multipolare.
Andrea Vento – 6 gennaio 2023
Gruppo Insegnanti di geografia Autorganizzati
NOTE:
1 “The World Needs Better Economic BRICs” nella serie “Global Economic Paper” di Goldman Sachs, sulle quattro economie emergenti “BRIC”: Brasile , Russia , India e Cina
2 L’interscambio commerciale fra i Paesi del Brics nel 2002 ammontava a soli 27,3 miliardi di $, nel 2021 era aumentato di 10 volte a 282 e nel 2015 addirittura 500.
3 https://it.wikipedia.org/wiki/Risoluzione_1973_del_Consiglio_di_sicurezza_delle_Nazioni_Unite
4 https://www.aljazeera.com/economy/2016/5/24/indian-iran-and-afghanistan-sign-trade-corridor-deal
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Ashgabat_Agreement
6 https://en.wikipedia.org/wiki/International_North%E2%80%93South_Transport_Corridor
L’AMBIZIOSO PROGETTO DEL CORRIDOIO NORD-SUD: la cooperazione Russia-India-Iran in risposta all’Occidente
7 https://www.tehrantimes.com/news/474677/INSTC-A-sanction-proof-route-with-great-economic-prospects
8Diritti Speciali di Prelievo – DSP (Special Drawing Rights, SDR), ovvero nell’unità di conto del FMI (determinata secondo un paniere ponderato di cinque valute: dollaro USA, Euro, Yen, Sterlina, Renminbi).
9 Fonte: Ministero degli affari esteri – https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/organizzazioni_internazionali/fora-organizzazioni-economiche-internazionali/fondomonetariointernazionale/
10 https://www.visualcapitalist.com/100-trillion-global-economy/
11 Gli Usa: 17,43% del capitale e 16,50% dei voti Giappone (6,14% dei voti), Cina (6,08%), Germania (5,31%), Francia, Regno Unito (4,03% entrambi), Italia (3,02%), India (2,63%), Russia (2,59%) e Brasile (2,22%) sono i dieci Paesi più rappresentati nel voto. https://www.imf.org/en/About/executive-board/members-quotas
12 https://www.agenzianova.com/a/654b32202629a2.85252497/4650775/2023-11-08/fmi-approvata-proposta-di-revisione-quote-partecipative
14 L’espressione Washington consensus è stata coniata nel 1989 dall’economista John Wiliamson per descrivere un insieme di 10 direttive di politica economica neoliberista che egli considerava come il pacchetto standard da destinare ai paesi in via di sviluppo che si fossero trovati in crisi economica. Queste direttive erano promosse da organizzazioni internazionali con sede a Washington, come Fmi e Banca mondiale Bm e anche dal Dipartimento del Tesoro Usa. Tra le direttive del “pacchetto” standard, vi sono riforme nella stabilizzazione macroeconomica, l’apertura agli investimenti e alle attività commerciali, e l’espansione del mercato nell’economia del paese che avesse richiesto l’aiuto di una delle tre organizzazioni https://it.wikipedia.org/wiki/Washington_consensus
15 https://startingfinance.com/approfondimenti/la-terribile-crisi-argentina-del-2001/
16 Il capitale autorizzato rappresenta la quantità massima di capitale che una società è autorizzata a raccogliere attraverso l’emissioni di azioni ai suoi azionisti e costituisce un fattore importante per valutare la salute finanziaria e la stabilità dell’organizzazione. Ad esempio, se una società ha un capitale autorizzato di un milione di $ ma ha ricevuto solo 500.000 $ come capitale versato dai suoi azionisti, ciò significa che può raccoglierne altri 500.000 se necessario
17https://fastercapital.com/it/contenuto/Integrazione-finanziaria–BRICS–creare-una-piu-forte-integrazione-finanziaria.html
18 https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=c&dotcache=refresh
19 https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS_Contingent_Reserve_Arrangement
L’egemonia statunitense e lo spettro del mondo multipolare
di Marco Consolo

Il mondo sta cambiando ad una velocità mai conosciuta prima verso una nuova e accelerata riorganizzazione multipolare.
Non c’è dubbio che la fase aperta con l’implosione della URSS e la caduta del muro di Berlino stia rapidamente volgendo al termine. In questa accelerata transizione si sta chiudendo la fase in cui gli Stati Uniti erano l’unica superpotenza mondiale, con una indiscutibile egemonia planetaria. Ma come ricordava il nostro Antonio Gramsci, “La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati” [1] e in questa transizione in chiaroscuro nascono i mostri. La crisi di governance planetaria è squadernata davanti ai nostri occhi.
In un mondo in aperta transizione, una delle differenze con il passato è la presenza di una crisi globale multifattoriale, soprattutto economica, ambientale e alimentare. Si tratta di una crisi di lunga data, notevolmente aggravata prima con la pandemia e poi con la guerra in Ucraina.
Nessun Paese ne è indenne e il continente latino-americano è tra i più esposti, per vari motivi. La Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi delle Nazioni Unite (CEPAL) prevede un tasso di crescita di appena l’1% nel 2023. In un quadro di leggi fiscali fortemente regressive e in assenza di riforme profonde del sistema fiscale, le risorse disponibili (e il margine di manovra) per politiche pubbliche in grado di ridurre il divario sociale sono quindi fortemente ridotte.
Il baricentro della geo-politica si sta inesorabilmente spostando verso il continente asiatico.
Fascismo e guerra
Come nel caso della crisi del 1929, il capitale cerca di superare le proprie crisi attraverso due strumenti complementari: il fascismo (che oggi riprende fiato seppur con caratteristiche diverse dal passato) e la guerra. Entrambi appaiono come i mostri del giorno d’oggi (e dell’immediato futuro).
La guerra è presente in quasi tutti i continenti e, dopo quella nella ex-Jugoslavia, nel cuore dell’Europa la guerra in Ucraina è un altro importante tassello di questo sconvolgimento globale. La narrazione occidentale non è più egemone sulle cause e sulle responsabilità della guerra che non sono condivise a livello mondiale. Viceversa, la visione che si fa avanti è quella di una guerra degli Stati Uniti e della NATO alla Russia (ed all’Europa?), come ammettono gli stessi dirigenti politici che, da prima dello scoppio del conflitto, dichiarano di volere la caduta del governo Putin. Ed il fallimento della controffensiva ucraina contro la Russia rappresenta una sconfitta della strategia della NATO, che in questa guerra è coinvolta sin da prima che iniziasse.
Mentre scrivo questo pezzo, sulle sponde del Mediterraneo è in atto l’ennesima carneficina contro il popolo palestinese, un tentativo di “pulizia etnica” per mano del governo di Israele. Una situazione che non può essere definita di guerra, vista anche la sproporzione di forze in campo. Ed anche in questo caso, la narrazione occidentale a difesa di Israele perde forza ed egemonia di fronte al genocidio in atto a Gaza.
Negli Stati Uniti (anche se una guerra in appoggio a Israele ha maggiore consenso di quella ucraina), affrontare la lunga campagna elettorale per le presidenziali, con due conflitti aperti o sulle spalle, non è certamente la migliore opzione, né per Biden, né per il Partito Democratico. La paziente tessitura messa in piedi da Washington per ricucire i rapporti tra Israele, Arabia Saudita ed altri Paesi arabi (con i cosiddetti “Accordi di Abramo”), si è dissolta come neve al sole. Nei Paesi musulmani è riemerso il mai sopito sentimento anti-USA, identificati come i protettori di Israele.
Nel frattempo, nel quadrante dell’Asia-Pacifico e dei suoi importanti corridoi marittimi, cresce la tensione e gli Stati Uniti sperimentano ballon d’essai per preparare il conflitto con il pretesto di Taiwan.
Questa tendenza di fondo alla guerra (e quindi all’instabilità), di cui la NATO è la principale locomotiva, si intreccia fortemente con la crisi degli equilibri planetari usciti dalla IIa guerra mondiale e con il tentativo dell’Occidente globale di impedirne a tuti i costi la modifica.
Dalla caduta del muro di Berlino ad oggi, la globalizzazione neo-liberista ha esteso su scala planetaria i rapporti socio-economici capitalistici ed accentuato il predominio dei Paesi occidentali e in particolare degli Stati Uniti. Mentre con la presidenza Trump avevamo assistito a un certo ripiegamento “deglobalizzante” verso l’interno, viceversa l’amministrazione Biden ha riproposto il ruolo centrale ed egemone degli Stati Uniti sullo scacchiere globale. Allo stesso tempo, ha approfondito il sistema delle cosiddette “sanzioni” (più correttamente “misure coercitive unilaterali” fuori dal sistema ONU), tra cui quelle contro la Russia nel quadro della guerra in Ucraina.
Le attuali élite al potere negli Stati Uniti e nei suoi satelliti sono i principali beneficiari dell’instabilità globale che usano per ricavarne profitto, con una chiara strategia di destabilizzazione. Sono i colpi di coda di un impero in fase di declino commerciale, economico e politico che farà l’impossibile per non perdere i propri privilegi come superpotenza globale. Gli Stati Uniti non sono disposti ad accettarlo e cercano viceversa di preservare ed estendere il loro dominio, perché ritengono che questo caos li aiuterà a contenere e destabilizzare i loro rivali geopolitici, ovvero i nuovi poli di crescita globale, integrati da Paesi sovrani indipendenti, non più disposti a inginocchiarsi nel ruolo di maggiordomi.
Allo stesso tempo, l’irresistibile ascesa della Cina (prima economica, ora sempre più politica e in parte anche militare), il paradossale rafforzamento della Russia e il suo nuovo protagonismo, l’emergere di vari organismi internazionali basati su questi due Paesi, come la Shangai Cooperation Organization (SCO) [2] e soprattutto i BRICS+ (con l’ingresso di altri importanti Paesi) stanno contribuendo a mettere in discussione l’egemonia degli USA, e a creare un forte contrappeso assente da decenni, con una modifica profonda dei rapporti di forza mondiali.
Uno spettro si aggira per il mondo: i Brics+
Da parte sua, l’Occidente ha sbandierato una serie di successi, come l’allargamento della Nato in Europa (ed in America Latina con la Colombia come “alleato strategico”) ed il presunto isolamento della Russia nello scacchiere mondiale. In realtà, il conflitto in Ucraina, ha rafforzato il multipolarismo e la crescita di diversi attori internazionali non in linea con la narrativa occidentale.
In questo nuovo quadro in transizione, un fantasma si aggira per il mondo: l’alleanza dei Paesi Brics. Un nuovo blocco economico e politico, alternativo al “giardino europeo” (Josep Borrell dixit) ed occidentale, in cerca di un nuovo ordine mondiale e un maggior equilibrio economico e geo-politico. Sul versante non occidentale è la realtà più solida. L’alleanza BRIC, formata nel 2009 (inizialmente da Brasile, Russia, India, Cina), si è ingrandita con il Sudafrica nel 2010 prendendo il nome di BRICS. Nel loro ultimo vertice a Johannesburg (agosto 2023), i Brics hanno deciso di espandersi ulteriormente con l’entrata di Arabia Saudita, Iran, Etiopia, Egitto, Argentina [3] ed Emirati Arabi Uniti, a partire dal gennaio 2024 (dando vita ai Brics+). Un “evento storico” secondo il Presidente cinese Xi Jinping, che viene al culmine di un processo maturato lentamente, ma che paradossalmente la guerra in Ucraina ha accelerato ed ampliato, con la presenza di più di 60 Paesi invitati.
I BRICS+ sono quindi un’alleanza delle maggiori potenze economiche non occidentali e dei principali Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente, che ridisegna i rapporti di forza planetari. Come ha ricordato il presidente brasiliano Lula da Silva, “rappresenteranno il 36% del Pil mondiale e il 47% della popolazione dell’intero pianeta”. Ed “a questa prima fase se ne aggiungerà un’altra di ulteriore ampliamento” verso un nuovo ordine mondiale che appare sempre più affrancato da Stati Uniti e NATO. Oggi, alla porta dei Brics+ bussano più di 20 Paesi interessati a far parte di una organizzazione capitanata dalla Cina (avversario strategico degli Stati Uniti e della Nato) e di cui nel 2024 la Russia avrà la presidenza.
Come è del tutto evidente, i Brics+ sono Paesi molto diversi tra loro, ma uniti dall’obiettivo comune della cooperazione economica e della lotta all’unilateralismo. Lungi dall’essere una debolezza (come vociferano i suoi detrattori), la eterogeneità politica dei suoi governi ne rappresenta la forza intrinseca, non basata su una sintonia ideologica. Una parte importante dei Paesi del Sud globale non è più disposta a farsi impoverire dall’Occidente e dalle condizioni capestro delle sue istituzioni (a cominciare dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dal Club di Parigi). Questi Paesi ritengono che il loro sviluppo economico e sociale non possa dipendere principalmente (o quasi esclusivamente) dal rapporto con l’Occidente ed propongono una politica concreta di cooperazione mondiale alternativa alla globalizzazione a trazione statunitense ed occidentale.
Allo stesso tempo, i Brics si appellano all’ONU per riforme politiche e un maggiore dialogo, mentre sostengono una redistribuzione del potere nella governance globale, monetaria e politica, affinché il Sud globale sia equamente rappresentato.
Su quale debba essere il ruolo politico dei Brics (e dei Brics+), il dibattito interno è comunque aperto. Al momento prevale la visione di chi pensa più a un blocco non allineato per favorire gli interessi economici dei “Paesi in via di sviluppo”, più che a una alleanza politica di sfida aperta all’Occidente. La stessa Cina continua ad avere un atteggiamento prudente e pragmatico, mentre lavora incessantemente per il suo rafforzamento. Nonostante ciò, i Brics+ hanno buone possibilità di cambiare la direzione della Storia, e già oggi sono parte attiva di una nuova architettura politica, economica e finanziaria ancora in nuce, ma che sta provando a chiudere la fase del mondo unipolare a trazione Usa. L’obiettivo è avanzare verso un mondo multipolare, per sua natura obbligato al dialogo.
Data la complessiva potenza economica, industriale e tecnologica di questa alleanza e le immense risorse naturali a disposizione, l’emergere dei BRICS+ segna l’accelerazione del declino dell’unipolarismo statunitense, favorisce la transizione ad un ordine mondiale multipolare ed accelera il processo di de-dollarizzazione.
Sganciarsi dal dollaro
Lo strapotere occidentale e più di recente la guerra hanno obbligato questi Paesi a tessere una rete di rapporti diversificati, rafforzando la messa a punto di modalità di commercio alternative a quelle esistenti con la divisa statunitense, incrementandone la possibilità di perdere la sua posizione di valuta di scambio e di riserva internazionale.
Infatti, è bene ricordare che dagli accordi di Bretton Woods del 1944 fino ad oggi, il dollaro è stata la moneta di gran lunga più utilizzata nel commercio internazionale. Il suo ruolo dominante è stato rafforzato dall’avere anche avuto la funzione di valuta di riserva internazionale. Un dominio accresciuto dopo il 1971, quando l’amministrazione statunitense di Richard Nixon ha abolito la convertibilità (e rimborsabilità) del dollaro in oro (il cosiddetto Gold standard) secondo un rapporto di cambio fisso. In altri termini, dal 1971 ciò ha significato una vantaggiosa posizione di rendita in quanto gli Stati Uniti erano liberi di stampare la moneta usata a livello mondiale senza garanzia, cioè senza l’obbligo di possedere una quantità d’oro pari ai biglietti verdi in circolazione e senza doverne rispondere. Un privilegio esclusivo che ha permesso agli Stati Uniti di comprare (e consumare) merci prodotte altrove senza rispondere dei propri debiti, ma semplicemente stampando dollari, ed inondandone il mondo, in base alle loro necessità.
Sul versante monetario, seppure fino ad oggi i Brics non hanno una loro valuta autonoma, cresce nel blocco la volontà di un progressivo sganciamento dal dollaro, con l’utilizzo di valute locali, di unità di conto monetarie, di misure di compensazione. Come ha dichiarato a Johannesburg il Presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, i governi dei Brics “hanno incaricato i loro ministri delle Finanze e governatori delle Banche centrali, di considerare la questione di valute locali, strumenti di pagamento e piattaforme e di riferire agli stessi leader dei Brics nel prossimo vertice”.
Nel frattempo, i governi dei Paesi Brics non sono stati con le mani in mano e ormai da qualche anno commerciano utilizzando valute diverse dal dollaro.
Non c’è da stupirsi se, sin dall’inizio di questo percorso, i media occidentali hanno fatto a gara per cercare di minimizzarne l’impatto sul monopolio del biglietto verde. Ma, al contrario di quanto affermano, il lancio di una moneta comune da parte dei Brics+ potrebbe significare la fine dell’egemonia del dollaro ed un terremoto mondiale, con contraccolpi innanzitutto negli Stati Uniti.
Come si ricorderà, è stato proprio l’ennesimo rifiuto degli Stati Uniti di cedere una parte del potere nella gestione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) a far traboccare il vaso e nel 2014 i Brics decisero di creare una propria banca, la Nuova Banca di Sviluppo, autonoma ed alternativa al FMI. Alla sua guida c’è oggi Dilma Roussef, ex-Presidente del Brasile. In altre parole, da quella data i Brics hanno lavorato per costruire una alternativa concreta alle istituzioni economiche internazionali, gestite da Washington e dai suoi alleati occidentali, anche in campo finanziario, di esclusivo predominio anglo-statunitense dalla fine del secondo conflitto mondiale.
Da Marco Polo alla Nuova via della Seta
Nel 2023 compie dieci anni l’iniziativa della Repubblica Popolare Cinese nota come One Belt, One Road Initiative, o anche come “Nuova Via della Seta”, lanciata da Xi Jinping nel 2013.
La Nuova Via della Seta è volta a migliorare i corridoi commerciali internazionali esistenti e a crearne di nuovi. Comprende diverse aree come, tra le altre, la Cintura economica della Via della Seta e la Via della Seta marittima. Il suo obiettivo iniziale era quello di costruire infrastrutture e collegare i Paesi eurasiatici, ma tra i più recenti obiettivi dichiarati c’è anche quello di garantire la sicurezza e la stabilità nel continente.
Come si ricorderà, il percorso della Belt and Road è iniziato con il primo Forum di cooperazione internazionale tenutosi a Pechino nel maggio 2017. Il secondo Forum si è svolto nella capitale cinese due anni dopo (aprile 2019), con un crescendo di presenze di capi di Stato e di governo. Dopo la pausa obbligata della pandemia del Covid19, il terzo Forum della Belt and Road si è di nuovo riunito a Pechino (17-18 ottobre 2023). In questa ultima occasione hanno partecipato delegazioni di oltre 140 Paesi e di più di 30 organizzazioni internazionali, e il numero di partecipanti ha superato le 4.000 presenze [4].
Risultati dell’iniziativa cinese
Il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese ha recentemente pubblicato un “Libro bianco sull’attuazione dell’Iniziativa della Nuova Via della Seta” [5].
Secondo il Libro bianco, negli ultimi 10 anni l’iniziativa ha attirato quasi 1.000 miliardi di dollari di investimenti e ha dato vita a più di 3.000 progetti di cooperazione congiunta. Secondo Pechino, ha creato 420.000 posti di lavoro di aziende cinesi nei Paesi lungo la Belt and Road. Nell’iniziativa sono coinvolti in totale più di 150 Paesi e più di 30 organizzazioni internazionali, con cui la Cina ha firmato circa 200 accordi di cooperazione, oltre a 28 “Trattati di Libero Commercio” tra la Cina ed altrettanti Paesi e regioni.
Il Libro bianco sostiene che l’iniziativa Belt and Road rende i Paesi partecipanti più attraenti per gli investimenti delle grandi imprese globali. Ad esempio, i flussi di investimenti diretti transfrontalieri nel Sud-est asiatico, in Asia centrale e in altre regioni, dove la maggior parte degli Stati ha aderito all’iniziativa cinese, sono in costante aumento. Nel 2022 gli investimenti diretti esteri (IDE) nel Sud-est asiatico hanno rappresentato il 17,2% del totale globale, con un aumento del 9% rispetto al 2013.
Sempre secondo Pechino, il commercio tra i Paesi partecipanti sta crescendo: dal 2013 al 2022, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni tra la Cina e gli altri Paesi aderenti al progetto ha raggiunto i 19,1 trilioni di dollari, con un tasso di crescita medio annuo del 6,4% [6].
E secondo il Consiglio di Stato della Repubblica Popolare Cinese, il “Fondo per la Via della Seta”, che si occupa dell’attuazione dell’iniziativa, ha firmato accordi su 75 progetti.
Uno dei risultati concreti raggiunti negli anni è stato il lancio del treno container Cina-Europa, con un percorso che collega più di 20 Paesi [7].
Quali prospettive ?
Ci troviamo quindi di fronte a una situazione internazionale che obbliga a ripensare le strategie di partenariato globali e regionali e ad attribuire maggiore rilevanza ai legami Sud-Sud nel commercio, negli Investimenti Diretti Esteri (IDE) e nella cooperazione.
È chiara l’importanza che ha la Cina per l’economia globale. Il gigante asiatico è diventato il primo esportatore e il secondo importatore al mondo. Secondo la Banca Mondiale [8], nonostante le sue politiche rigorose, l’economia cinese è piuttosto aperta al commercio estero, un settore che negli ultimi anni ha rappresentato circa il 35% del suo Prodotto Interno Lordo, e i suoi principali partner commerciali sono attualmente gli Stati Uniti, Hong Kong, Giappone, Corea del Sud, Vietnam, Australia e Germania. I suoi principali prodotti di esportazione includono apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchinari vari, reattori nucleari, produzione di pannelli solari, edifici prefabbricati, plastica, tessuti confezionati, strumenti tecnici e medici e veicoli.
Le importazioni comprendono apparecchiature elettriche ed elettroniche, carburanti, minerali, oli, prodotti di distillazione.
La crescente presenza della Cina nell’economia mondiale e la sua ascesa come potenza globale continuano a generare diverse preoccupazioni e più di una tensione nelle relazioni commerciali con gli Stati Uniti e le altre economie occidentali.
In effetti, il rafforzamento della presenza cinese rappresenta sempre più una sfida allo status quo internazionale ed alle potenze egemoniche esistenti in quanto al controllo di importanti aree del mondo. Il reclamo territoriale sulle isole nel Mar Cinese Meridionale e l’uso di vecchie e nuove rotte commerciali attraverso la “Nuova via della Seta” sono sfide “non dichiarate” a questo ordine mondiale e parte delle attuali tensioni con gli Stati Uniti.
Per quanto riguarda gli aspetti puramente economici e commerciali, l’evoluzione dell’apparato produttivo cinese negli ultimi anni ha permesso alle sue aziende di inserirsi nelle diverse filiere produttive globali. Così, sono passate da una produzione iniziale a scarso valore aggiunto a competere con successo nei settori più sofisticati e ad alta intensità tecnologica. È in questo processo che la Cina è diventata, per gli Stati Uniti e l’Unione Europea, un’economia rivale, dando così inizio ai diversi capitoli di una guerra commerciale [9]. Come afferma Broggi (2021) [10], i dati sono conclusivi: “nell’ultimo decennio, la Cina ha sostituito gli Stati Uniti come principale fornitore nella maggior parte dei Paesi dell’Asia, dell’Africa, dell’Europa e del Sud America”. Appare chiaro che, più prima che poi, un nuovo ordine internazionale dovrà adattarsi a questa nuova realtà.
Anche se oggi siamo lontani dal periodo di crescita a due cifre, la posizione della Cina come potenza economica globale ha continuato a consolidarsi. Questo nonostante la battuta d’arresto rappresentata dalla pandemia e dalle politiche di forti restrizioni e di “Covid zero” che il governo di Xi Jinping ha applicato, chiudendo intere province che sono importanti centri economici, come Shanghai, Shenzhen e Chengdu.
In questo quadro complesso dobbiamo considerare anche gli impatti economici della guerra in Ucraina che ha rafforzato i rapporti con la Russia di Putin.
Il risultato del 2022 vede l’economia cinese crescere del 3%, uno dei valori più bassi degli ultimi decenni, mentre per il 2023 si prevede una crescita tra il 5% e il 6% [11]. Queste proiezioni si basano sulla ripresa dei consumi interni, con la crescita del credito, sugli investimenti infrastrutturali e su vari stimoli fiscali. Tuttavia, sarà necessario monitorare l’evoluzione del Covid e le risposte del governo cinese a un’eventuale sua ripresa.
Sul fronte esterno, oltre a uno scenario complicato in cui i suoi principali partner commerciali continueranno a rallentare le loro economie con politiche di contrazione della domanda, la Cina continuerà ad affrontare una guerra commerciale guidata dagli Stati Uniti, caratterizzata da forti restrizioni all’accesso alla tecnologia e da vari meccanismi di protezione. Ma nonostante questo scenario, è chiaro che la strategia di espansione della Cina continuerà a godere di un importante sostegno finanziario statale che garantirà una notevole autonomia.
In questo contesto generale, piaccia o meno, l’economia mondiale continuerà a dipendere in larga misura dal motore economico cinese.
E l’Europa ?
Per l’Europa il futuro è incerto, debole e pieno di ombre, nella misura in cui è in balia dei poteri forti e dei governi a loro alleati.
A partire dalla guerra in Ucraina, le “sanzioni” economiche, la rottura delle relazioni commerciali tra l’Unione Europea e la Russia, insieme all’attentato ad hoc al gasdotto North Stream, hanno pesantemente penalizzato l’economia europea e in particolare quella tedesca, che aveva, come uno degli elementi della sua competitività, l’approvvigionamento di materie prime a basso costo. Ma anche nel “Belpaese” le imprese italiane hanno subito forti perdite, in particolare per quanto riguarda l’export tricolore di prodotti chimici, alimentari, macchinari, abbigliamento e mobili, con pesanti crolli di fatturato [12].
Invece di seguire il cammino pragmatico dell’integrazione euro-asiatica e rafforzare i vincoli economici mutuamente vantaggiosi con la Russia e con la Cina, la UE si è imbarcata in una missione suicida per conto dei suoi curatori (fallimentari ?) di Washington nel tentativo, condannato al fracasso, di indebolire la Russia e contenere la Cina. Oggi l’Unione Europea si trova economicamente indebolita, senza un forte baricentro di governo, più divisa che nel passato e maggiormente subalterna alla volontà degli Usa.
Dopo essere stati condannati all’irrilevanza politica sullo scacchiere mondiale, i Paesi europei sono chiamati a pagare il conto delle ambizioni imperiali degli Stati Uniti e a fornire assistenza militare, visto che la strategia militare di Washington non dispone di mezzi sufficienti per farsene carico autonomamente [13]. E le “politiche di difesa e sicurezza” dell’Unione Europea sono sempre più una fotocopia di quelle della NATO (di cui ormai è un’appendice) che fa pressioni per destinare almeno il 2% del PIL dei diversi Paesi alla spesa militare.
Lungi dall’essere un attore geo-politico indipendente o una “potenza geo-politica” (nonostante i deliri di onnipotenza della sig.ra Von der Leyen e di Borrell), la attuale UE ha significato la riduzione del potere degli Stati membri con l’erosione delle proprie sovranità nazionali, in modo da non rappresentare una sfida per gli interessi ed il potere degli Stati Uniti.
I segnali di una profonda crisi del progetto di integrazione europea si sono moltiplicati e la Brexit è stata solo il segnale più evidente. Il potenziale di crescita economica sembra esaurito (almeno in questa fase) e la maggioranza dei membri del blocco hanno un cronico deficit di bilancio ed un debito eccessivo. Il livello di vita (ed il potere d’acquisto) delle popolazioni continua ad abbassarsi, mentre le promesse di prosperità e benessere del “giardino europeo” appartengono al passato. Cresce, quindi, la disillusione e lo scontento tra la popolazione.
E nella profonda crisi di identità europea, nell’insicurezza e la paura del presente, nell’incertezza del futuro, cresce anche il neo-fascismo del XXI° secolo, con caratteristiche diverse dal passato. Un fenomeno che trascende le frontiere europee e con cui l’orizzonte dell’Utopia dovrà fare i conti.
Note
[1] A. Gramsci, Quaderni dal carcere (Q 3, §34, p. 311)
[3] Nel caso dell’Argentina, l’entrata nei BRICS era stata decisa dal governo di Alberto Fernandez. Ma la vittoria nel novembre 2023 di Javier Milei, fino ad oggi fortemente contrario, potrebbe segnare una battuta d’arresto. D’altra parte, Brasile, Cina e India rappresentano quasi il 30% dell’export totale argentino.
[4] https://sputniknews.lat/20231017/las-claves-del-tercer-foro-de-cooperacion-internacional-de-la-franja-y-la-ruta-en-pekin-1144799870.html
[5] https://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/202310/10/content_WS6524b55fc6d0868f4e8e014c.html
[6] Ibidem
[7] https://it.euronews.com/2022/07/31/treno-merci-cina-europa-primo-viaggio-hefei-budapest
[8] https://www.worldbank.org/en/country/china/publication/china-economic-update-december-2022
[9] Nel 2018, l’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha imposto dazi su una serie di prodotti cinesi.
[10] Brasó Broggi, Carles (2021): Algunas causas de la guerra comercial entre China y Los Estados Unidos. Universitá Oberta de Catalunya. Barcelona.
[11] https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/06/14/priority-reforms-key-for-sustaining-growth-and-achieving-china-s-long-term-goals-world-bank-report
[12] https://www.infomercatiesteri.it/scambi_commerciali.php?id_paesi=88#
[13] https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/11/inflection-point-how-to-reverse-the-erosion-of-us-and.html
FONTE: https://marcoconsolo.altervista.org/legemonia-statunitense-e-lo-spettro-del-mondo-multipolare/
Le nuove alleanze militari di Washington nell’area Asia-Pacifico (Economia di guerra oggi, parte VIII)
di Andrea Vento
All’interno della la zolla geopolitica statunitense, posizionata a levante della frattura geopolitica presente ai bordi orientali della massa continentale euroasiatica1, il trend dell’impennata delle spese militari ricalca, seppur in tono leggermente minore, la traiettoria di crescita della Repubblica Popolare Cinese (tabella 1). L’incremento in corso risulta riconducibile anche all’impulso impresso dalle alleanze militari, tese al rafforzamento della cintura anticinese nell’Indo-Pacifico2, rivitalizzate e recentemente create dagli Stati Uniti nell’area, a partire dal Quad (Quadrilateral Security Dialogue) e dall’Aukus (Australia, United Kingdom, United States Security Teatry).
Tabella1: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023
| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||
| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |
| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |
| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |
| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |
| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |
| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |
| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |
| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |
| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |
| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |
| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |
| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |
| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |
| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |
| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |
| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |
| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||
| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||
Il Quadrilateral Security Dialogue
Il Dialogo Quadrilaterale di Sicurezza (Quad) fondato nel 2007 da Stati Uniti, Giappone, Australia e India, allo scopo di stabilire un sedicente “Arco asiatico della democrazia” avrebbe dovuto comprendere anche gli Stati centro-asiatici, la Mongolia, la Corea del Sud, il Giappone e altri del Sud-Est asiatico, “praticamente tutti i Paesi ai confini della Cina, ad eccezione della Cina stessa”3. Rimasta tuttavia sin dalla nascita scarsamente operativa per la rinuncia dell’Australia nel 2007 e successive divergenze interne, torna a nuova vita su input dei quattro Paesi fondatori a seguito dell’incontro a margine del vertice dei Paesi Asean4 di Manila del 2017, nel cui contesto viene anche stabilita una sinergia militare anticinese con quest’ultima organizzazione.
Dal 2017 il Quad ha quindi progressivamente incrementato le proprie attività, soprattutto in termini di cooperazione ed esercitazioni militari congiunte, fornendo nuova linfa all’inasprimento del confronto globale Usa-Cina che proprio nel Sud-Est asiatico trova uno dei due principali suoi epicentri.
Il nuovo corso del Quad, trae ispirazione dalla strategia di Hillary Clinton dell’ “Indo-Pacifico libero e aperto” e costituisce un progetto di contenimento della Cina in risposta alle “Vie della seta”, non casualmente definito dall’ex funzionario del Dipartimento di stato Usa, Morton Abramowitz, come “una mossa anti-cinese”5.
Strategia di accerchiamento che ha spinto Pechino alle contromisure geopolitiche come il rafforzamento e l’ampliamento dello Sco, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai. Quest’ultimo, già creato nel 2001 da Cina, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan, in risposta registra, infatti, l’ingresso di India e Pakistan nel 2017 e dell’Iran nel luglio 2023.
Gli alleati strategici di Washington nell’area aumentano le spese militari
Nella dinamicità dello scenario appena tratteggiato, sta acquisendo nuovo status geopolitico il Giappone. Secondo il direttore di Limes, Lucio Caracciolo, l’ex potenza imperiale rappresenta infatti l’architrave del disegno strategico Usa nella regione. Tokyo ha ormai abbandonato la sua tradizionale politica non interventista e non militarista, sancita dall’articolo 9 della sua Costituzione6, tant’è che, senza essere stato modificato, il governo nipponico ha recentemente intrapreso una nuova corsa al riarmo in conseguenza della discontinuità sancita dalla “Nuova strategia di sicurezza nazionale”. Pubblicata nel 2022, quest’ultima, “Definisce piani ambiziosi per aumentare la capacità militare del Paese nel prossimo decennio in risposta alle crescenti minacce percepite da Cina, Corea del Nord e Russia”. In sostanza si tratta di una mutazione genetica della tradizionale postura pacifista imposta al Paese dagli Stati Uniti dopo la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale7 che il ricercatore del Sipri, Xiao Liang, ha così puntualizzato: “Il Giappone sta attraversando un profondo cambiamento nella sua politica militare. Le restrizioni imposte al Giappone nel dopoguerra alle sue spese militari e alle sue capacità militari sembrano allentarsi”.
Un cambiamento di rotta pilotato da Washington il quale, accertata l’affidabilità dell’alleato, ha deciso per il suo riarmo8 in funzione del contenimento cinese, elevandolo ad asse portante della struttura militare erta ai bordi del mar Cinese Orientale, l’altro principale epicentro di instabilità nello scontro Usa-Cina.
L’analisi dell’andamento delle spese militari di Tokyo effettuate dal Sipri (tabella 1) confermano che il capovolgimento della sua politica militare ha origini molto recenti: al cospetto di un aumento nell’ultimo decennio del “solo” 18%, buona parte si è verificato nel 2022 quando l’incremento è risultato del 5,6%. Lo scorso anno, le uscite militari di Tokyo sono così salite a 46 miliardi di $, pari all’1,1% del Pil.
L’altro tradizionale alleato di Washington nella macroregione, la Corea del Sud, che ospita 8 basi militari statunitensi dalla guerra di Corea (1950-53), risulta, al pari del suo omologo del Nord, una delle zone più militarizzate del pianeta, in considerazione del passaggio della frattura geopolitica in questione lungo il 38° parallelo, la linea di armistizio sulla quale si concluse all’epoca il conflitto. Rappresentando la penisola coreana, l’unico tratto nel quale la linea di faglia scorre su territorio continentale, vi è stata creata una fascia smilitarizzata lunga 250 km e larga 4 km al fine di ammortizzare le tensioni fra le due zolle9 (carta 1). Nonostante la massiccia militarizzazione del territorio già in essere, nel decennio 2013-22, Seul ha aumentato le spese militari di ben il 37% attestandosi al nono posto nella graduatoria mondiale subito davanti al Giappone, con un esborso di 46,4 miliardi di $ nel 2022, pari al 2,7% del Pil.
Carta 1: la situazione militare nella penisola di Corea con la fascia smilitarizzata di separazione

Taiwan divenuto principale teatro di scontro fra Usa e Cina ad inizio agosto del 2022, dopo la visita della Speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi che ha scatenato la reazione di Pechino, ha anch’essa intrapreso la strada del riarmo già alla fine dello stesso mese quando il governo ha apportato una proposta di revisione al rialzo del budget militare per l’anno 2023 di ben il 13,9%, stanziando fondi anche per l’acquisto di nuovi caccia. La spesa militare di Taiwan dovrebbe quindi salire nel 2023 a 19,4 miliardi $, portando il Paese nella poco edificante Top20 mondiale, a ridosso della Spagna (grafico 1). Le spese militari rappresenteranno un crescente fardello per le casse pubbliche di Taipei visto che, secondo le previsioni, arriveranno ad assorbire ben il 14,6% del budget statale dell’anno in corso10.
Cifre più da economia di guerra che da tempi di distensione.
Grafico 1: previsioni di spesa militare nel 2023

A rendere più complicata la situazione nello stretto di Taiwan nell’ambito dello scontro fra la Repubblica Popolare e la Repubblica di Cina, risulta la delicata posizione geostrategica di alcuni arcipelaghi di Taipei localizzati in prossimità della costa continentale. In particolare, si tratta principalmente degli arcipelaghi Kinmen (Quemoy) e Matsu che trovandosi, il primo a 2 soli km di fronte alla metropoli cinese di Xiamen, nella provincia di Fujian, e l’altro, in posizione più settentrionale a 19 km dalle coste della stessa provincia cinese, potrebbero costituire elemento di criticità per entrambi i Paesi, in caso di ulteriore inasprimento della tensione (carta 2).
Carta 2: gli arcipelaghi taiwanesi a ridosso delle coste della Repubblica Popolare

Per la Cina, appurata l’estrema vicinanza alle proprie coste, rappresenterebbero una spina nel fianco, dall’altro per Taiwan risulterebbero difficilmente difendibili in caso di un ipotetico attacco. Soprattutto l’arcipelago Matsu, essendo dotato di un sito missilistico contrariamente al più popoloso Kinmen, secondo il ministero della difesa di Taipei costituisce uno dei primissimi obiettivi sensibili. Si tratta di foschi ma tutto sommato improbabili scenari che infatti non turbano la vita e i pensieri degli abitanti dei due arcipelaghi, i quali mantengono buone relazioni con la Repubblica Popolare: “La popolazione di Matsu si è sempre sentita appartenente a una sola famiglia, quella cinese”11. Una convinzione abbastanza diffusa fra gli abitanti di Matsu anche in considerazione del fatto che lo stesso Arcipelago fa parte della contea di Lienchiang, il cui territorio è diviso fra la parte amministrata dalle Matsu, quindi sotto Taipei, e una parte sotto il controllo della provincia di Fujian.
Il consolidamento del potere dell’Anglosfera tramite l’Aukus
L’altra alleanza militare, l’Aukus, lanciata da Washington il 15 settembre 2021 ha caratteristiche imperialistiche più marcate, appurato che raccoglie 3 dei Five eyes12 anglofoni, nell’ordine: Australia, unico presente geograficamente nella macroregione, Regno Unito e Stati Uniti.
Il programma dell’Aukus è incentrato sull’ammodernamento della flotta australiana di sottomarini con mezzi strategici a propulsione nucleare e rientra nel quadro di rafforzamento delle alleanze in funzione anticinese, per il mantenimento dell’ordine internazionale a guida statunitense (carta 3).
Carta 3: la dotazione di sottomarini da parte dei tre Paesi Aukus e della Cina

In sostanza si tratta di una strategia per fornire a Canberra sottomarini di progettazione statunitense, affinché l’Australia possa ampliare la profondità strategica della propria potenza navale13. L’annuncio della costituzione dell’Aukus è stato accompagnato da un clamoroso dietrofront dell’Australia che, pur avendo già sottoscritto contratti di fornitura di sommergibili a propulsione diesel-elettrico con la Francia stimati fra 40 e 55 miliardi di euro, non ha esitato a rinunciarvi a favore dei più potenti e tecnologicamente avanzati statunitensi. Mossa spregiudicata che ha indispettito non poco Parigi al punto di imbastirvi un caso diplomatico14, richiamando pro tempore gli ambasciatori a Washington e Canberra per consultazioni15 (immagine 1).
Immagine 1: la nascita dell’Aukus in funzione anticinese con risentimento francese e dell’Ue

La politica di riarmo dell’Australia, in linea con gli altri Paesi dell’area, risulta tuttavia aver origini precedenti rispetto al varo dell’Aukus, appurato che nel decennio 2013-22 l’incremento delle spese militari è risultato il terzo più elevato nella Top15 mondiale col +47%, a una corta incollatura da un altro Five eyes, il Canada (+49%), e a qualche lunghezza di distanza dalla Cina che detiene il triste primato con +63%, al netto del particolare caso dell’Ucraina (+1.661%) da un decennio in fase di massiccio potenziamento militare (tabella 1).
Trovandosi i contratti dei sottomarini nucleari statunitensi ancora in fase progettuale, le spese militari di Canberra lo scorso anno hanno registrato solo un modesto incremento dello 0,3%, con scarsa incidenza sul deciso trend di crescita decennale che ha portato nel 2022 le uscite a 32,3 miliardi di $, facendo attestare il Paese al 13° posto della graduatoria mondiale, davanti al Canada con 26,9 miliardi di $.
L’Australia alla luce del riarmo in corso, sottomarini nucleari compresi, e delle potenzialità di proiezione militare che scaturiscono dall’Aukus, sta acquisendo un ruolo geopolitico-militare di crescente importanza sia nello scacchiere Asia-Pacifico, sia su scala mondiale. A livello continentale, invece, l’Australia gode del tradizionale status di potenza egemone, appurato che nel 2022 da sola ha rappresentato il 91,5% delle spese militari totali dell’Oceania (35,2 miliardi di $).
L’India fedele alla politica di non allineamento
Ampliando lo sguardo su tutto lo scacchiere Asia-Pacifico, la partecipazione dell’India al Patto di Sicurezza Quadripartito, il Quad, ha determinato l’affermazione del concetto geostrategico, nato in seno all’Anglosfera, di Indo-Pacifico come area di propria influenza geopolitica. Progetto riguardante nello specifico l’ampliamento della fascia statunitense di contenimento dell’espansione cinese dal Giappone fino all’Oceano indiano, passando per l’Australia (carta 3). Una strategia di accerchiamento che ha indotto Pechino a dotarsi di infrastrutture di trasporto terrestri per raggiungere i porti nell’Oceano Indiano a occidente della penisola indiana: come il “corridoio Cina-Pakistan”16 che dallo Xinjang raggiunge Islamabad e trova conclusione nello strategico terminale di Gwadar sul Mar Arabico, in Pakistan. Paese quest’ultimo con il quale Pechino va consolidando alleanza e relazioni economiche.
L’India è, tuttavia, riluttante a sposare la linea dura del contenimento cinese, attuata da Washington e alleati17, e, fedele alla propria tradizione di Paese “non allineato”, non intende deteriorare, nonostante vari fronti di attrito e di scontro, i rapporti con Pechino. Il governo nazionalista indù di Narendra Modi seppur interessato a cooperare con i Paesi occidentali su tecnologia, armamenti e mantenimento dello status-quo nell’Indo-Pacifico, non sembra intenzionato ad elevare il livello dello scontro con la Cina in quanto New Delhi, nell’attuale scenario geopolitico in fase di trasformazione, è riuscita a conseguire una rendita di posizione internazionale che le consente di avere mano libera per tessere la tela su più fronti.
Il ruolo di battitore libero ritagliatosi dall’India risulta particolarmente propizio per i vantaggi economici che sta riuscendo a ricavarne. Fra le varie rileviamo come in base ai calcoli effettuati dall’agenzia russa Ria Novosti rielaborando i dati ufficiali Eurostat, nei primi 9 mesi del 2023 New Delhi sarebbe diventata il secondo fornitore di prodotti petroliferi raffinati all’Unione Europea, dietro solo all’Arabia Saudita18. L’aspetto singolare, oltre che beffardo, è rappresentato dal fatto che il 40% del petrolio raffinato dall’India e venduto all’Ue proviene dalla Russia19, con buona pace delle sanzioni e delle sue ricadute negative sui committenti europei.
La contemporanea adesione dell’India all’Organizzazione della Cooperazione di Shangai (Sco) e al Quad, solo ad un approccio superficiale può essere definito come semplice doppiogiochismo. Ad una analisi più approfondita, anche sulla scorta del sostegno all’allargamento dei Brics ad altri 6 Paesi all’ultimo vertice in Sud-Africa e dell’incremento delle relazioni commerciali con la Russia dopo il febbraio 202220, emerge infatti che New Delhi sta implementando una politica di potenza autonoma tesa ad accrescere il proprio status internazionale non solo dal punto di vista economico, ma anche militare e geopolitico. Inoltre, ponendosi insieme alla Cina a guida del Sud globale, tali potenze emergenti, di concerto con Russia e Brasile, tramite l’allargamento dei Brics ambiscono alla realizzazione di un ordine internazionale multipolare e al superamento della struttura economico-finanziaria incentrata sul dollaro sancita a Bretton Woods nel 1944-45.
La storica ostilità di New Delhi con il Pakistan, entrambi dotati di ordigni nucleari, ha da tempo comportato un aumento delle spese militari, contribuendo alla scalata dell’India al quarto posto nella graduatoria mondiale dietro a Usa, Cina e Russia. Nel 2022 le uscite indiane per la difesa sono ammontate a 81,4 miliardi di $, pari al 2,4% del Pil, quando erano solo 14,7 miliardi di $ nel 200221, nel cui contesto, il corposo aumento del 6% rispetto all’anno precedente va ricondotto ad una accelerazione nella politica di perseguimento dello status di potenza militare di livello mondiale.
Conclusioni
Il clima da nuova “Guerra fredda” che sta imperversando a livello internazionale, col suo progressivo carico di tensioni e scontri, sta inevitabilmente facendo da traino all’aumento tendenziale delle spese militari mondiali, i cui picchi vengono registrati dal Sipri proprio nei Paesi ai margini delle due principali faglie geopolitico-militari (tabella 2): quella nell’Est Europa fra Usa-Nato e Russia, deflagrata in conflitto militare, e l’altra ai bordi del continente asiatico fra Usa e suoi vari alleati, da un lato, e Cina e, secondariamente, Corea del Nord e Russia, dall’altro.
Nello scontro in atto fra il tenace tentativo degli Stati Uniti di mantenere il potere geopolitico unilaterale mondiale e le potenze emergenti che da parte loro hanno iniziato a realizzare un nuovo ordine internazionale multipolare, l’Occidente globale a guida statunitense continua a mantenere ancora nettamente, seppur in traiettoria declinante, il primato mondiale in campo militare.
Nel complesso, i Paesi della Nato nel 2022 hanno, infatti, totalizzato ben 1.232 miliardi di $ di spese militari, pari al 55,1% del totale mondiale, con un aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. Di gran lunga in testa alla graduatoria mondiale sono saldamente attestati gli Stati Uniti, (tabella 1) con una spesa di ben 887 miliardi di $, pari al 39% delle spese mondiali, seguiti dai suoi principali partner europei tutti insediati nella Top15: il Regno Unito 6° con 68,5 miliardi, la Germania, anch’essa sulla via del riarmo con +33% nell’ultimo decennio, in settima posizione con 55,8 miliardi, seguite dalla Francia al 8° posto con 53,6 miliardi, dall’Italia al 12° con 33,5 miliardi di dollari e dal Canada al 14°.
Al fine di quantificare l’entità reale della potenza militare dell’Occidente globale occorre aggiungere le spese degli altri principali alleati statunitensi nei vari scenari regionali: Arabia Saudita 5° posto con 75 miliardi di $, Corea del Sud al 9° con 46,4, Giappone al 10° con 46,0, Australia al 13° (32,3) e Israele al 15° (23,2). Conseguentemente, considerando anche questi Paesi, la spesa complessiva della cosiddetta “Nato globale” sale a 1.455 miliardi di $, pari al 69,9% del totale mondiale.
La scelta strategica di Washington, teorizzata nei vari documenti annuali dell’Agenzia di Sicurezza Nazionale (Nsa), di perseguire la strada del contenimento di Russia e Cina, principali due Potenze Emergenti, tramite l’opzione militarista sta aumentando le tensioni internazionali e alimentando focolai di scontro e addirittura di guerra, come in Ucraina.
Il conseguente incremento irrefrenabile delle spese militari a livello globale pari a +19% nell’ultimo decennio (tabella 2) risulta da un lato foriero di venti di guerra e dall’altro finisce inevitabilmente per impattare sui bilanci statali riflettendosi in tagli alle spese sanitarie, all’istruzione e all’assistenza sociale, nonché agli investimenti produttivi.
Tabella 2: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023
| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||
| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |
| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |
| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |
| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | 0,9 |
| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |
| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |
| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |
| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |
| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |
| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |
| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |
| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |
| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |
| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |
| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |
| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |
| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |
| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |
| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |
Il tutto, amplificato dal sensibile rallentamento delle economie europee causato dall’adozione delle sanzioni alla Russia e dai suoi nefasti effetti collaterali, quali aumento delle quotazioni delle materie prime, fiammata inflazionistica e rialzo dei tassi22.
L’aspetto maggiormente inquietante a nostro avviso, tuttavia, risulta rappresentato dal fatto che i governi, in linea con i principi dell’economia di guerra, stanno affrontando i problemi di bilancio tagliando la spesa sociale e gli investimenti, invece di diminuire i budget per la difesa.
Una politica scellerata che sta avendo pesanti ripercussioni sia nel ciclo economico che nelle condizioni sociali, già gravemente deterioratesi negli ultimi decenni di dominio del dogma neoliberista. Fase storica contrassegnata da crisi economiche cicliche dalle quali la ristrutturazione capitalistica in atto cerca di uscire rilanciando la finanziarizzazione, i conflitti e l’economia di guerra.
Come interrompere la spirale liberismo – spese militari – guerre rappresenta l’ineludibile questione che tutti noi dovremmo affrontare.
Andrea Vento – 10 dicembre 2023 – Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1 L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico
2 Indo-Pacifico: termine geografico reso noto dallo studioso tedesco di geopolitica Karl Hushofer che lo utilizzò in molte sue opere negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso. A partire dal 2010 è stato sempre più frequentemente utilizzato, a partire dagli Stati Uniti, nelle analisi geopolitiche. Viene ipotizzato che la sua accezione geopolitica potrebbe condurre ad una ridefinizione geostrategica delle macroregioni terrestri, in quanto la sua adozione e diffusione risulta correlata all’istituzione del “Dialogo quadrilaterale di sicurezza” (Quad), un’alleanza informale tra Stati Uniti, Giappone, Australia e India, il quale, oltre ad ampliarsi fino all’oceano indiano, offre una visione geopolitica diversa rispetto al concetto di Asia-Pacifico. In sostanza il Quad consiste in un’ampia cintura di contenimento intorno alla Cina che attraversa parzialmente i due oceani in questione
3 Frank Ching, Asian Arc of Democracy su The Korea Times 224 febbraio 2008
4 Asean, l’Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico è stata fondata l’8 agosto 1967 a Bangkok, Thailandia, con la firma della Dichiarazione ASEAN (Dichiarazione di Bangkok) da parte dei Padri Fondatori dell’ASEAN: Indonesia, Malesia, Filippine, Singapore e Thailandia. Il Brunei Darussalam è entrato a far parte dell’ASEAN il 7 gennaio 1984, seguito dal Vietnam il 28 luglio 1995, dal Laos e dal Myanmar il 23 luglio 1997 e dalla Cambogia il 30 aprile 1999, formando quelli che oggi sono i dieci Stati membri dell’ASEAN. https://asean.org/about-asean
5 https://it.wikipedia.org/wiki/Dialogo_quadrilaterale_di_sicurezza#cite_note-Ching-17
6Art. 9. – Aspirando sinceramente ad una pace internazionale fondata sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinunzia per sempre alla guerra, quale diritto sovrano della Nazione, ed alla minaccia o all’uso della forza, quale mezzo per risolvere le controversie internazionali.
7 https://www.ilsole24ore.com/art/giappone-addio-pacifismo-tokyo-accelera-corsa-riarmo-AEXje4eB
8 https://www.analisidifesa.it/2022/07/il-giappone-gonfia-le-spese-militari-al-2-per-cento-del-pil-in-5-anni/
9 https://lospiegone.com/2017/03/13/usa-corea-del-sud-tra-propaganda-e-realta/
10 https://www.agi.it/estero/news/2022-08-25/taiwan-aumento-record-spesa-militare-17851034/#:~:text=AGI%20%2D%20Taiwan%20intende%20aumentare%20il,%2C4%20miliardi%20di%20dollari).
11 https://www.internazionale.it/reportage/lorenzo-lamperti/2022/04/24/isole-matsu-cina-taiwan
12 Five Eyes in inglese, acronimo: FVEY. I Cinque Occhi è un’alleanza di sorveglianza che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti . Questi paesi fanno parte dell’accordo UKUSA, un trattato di cooperazione congiunta in materia di intelligence dei segnali
13 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/aukus-e-la-corsa-al-riarmo-sottomarino-nellindo-pacifico-132662
14 https://it.insideover.com/difesa/lalleanza-del-pacifico-che-fa-infuriare-la-francia.html
15 https://www.ilsole24ore.com/art/la-francia-richiama-due-ambasciatori-AERdbbj
16 https://www.limesonline.com/corridoio-cina-pakistan/96725
17 https://www.geopolitica.info/india-politica-estera-usa/
18 Tra gennaio e settembre di quest’anno l’UE ha importato 7,9 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati dall’India, una cifra più che doppia rispetto all’anno precedente e tripla rispetto al 2021. Secondo il rapporto, il volume di prodotti petroliferi raffinati di quest’anno ha catapultato l’India dal sesto posto del 2022 al primo posto del 2023, con Francia, Paesi Bassi e Italia come tre maggiori importatori, seguiti da Croazia, Lettonia, Romania e Germania.
19 La Russia è il secondo esportatore nella UE di prodotti petroliferi, attraverso l’India (scenarieconomici.it)
20 Secondo un rapporto della BBC, le importazioni di petrolio dell’India sono aumentate di dieci volte, raggiungendo i 2,2 milioni di barili al giorno in aprile rispetto alla media pre-invasione di 0,2 milioni di barili al giorno.
21 https://it.tradingeconomics.com/india/military-expenditure
22 Economia di guerra oggi, parte VII. Ormai il re è nudo. Bce: la recessione resta uno scenario possibile
Argentina: la motosega del neo-fascismo ultraliberista

di Marco Consolo (da Buenos Aires)
In America Latina non si ferma l’ondata della destra e del neo-fascismo del secolo XXI, quel fascismo neo-liberista 2.0 “in doppiopetto” e a tratti violento che per ora sembra inarrestabile.
Al ballottaggio delle elezioni presidenziali, Javier Milei con il suo partito “La libertà avanza” ha vinto nettamente con il 55,69% (14.476.462 voti), rispetto 44,30% (11.516.142) di Sergio Massa, attuale ministro dell’Economia, a cui la maggioranza dei votanti ha passato il conto con una partecipazione del 76% dell’elettorato.
La terza economia dell’America Latina attraversa un periodo difficile, con un’inflazione a tre cifre (143% in un anno), il 40% della popolazione al di sotto della soglia di povertà, un livello di indebitamento preoccupante e una moneta in seria difficoltà. La popolazione argentina è alle prese con prezzi che aumentano ogni settimana, mentre il salario minimo è di 146.000 pesos (400 dollari), ma solo per i lavoratori salariati. Gli affitti sono alle stelle ed è riapparso il baratto, come nella traumatica crisi del 2001, mentre cresce la criminalità organizzata e la presenza del narcotraffico con i suoi tentacoli nella poitica. E secondo uno studio dell’Università di Buenos Aires pubblicato all’inizio dell’anno, il 68% dei giovani tra i 18 e i 29 anni emigrerebbe se potesse.
In questo quadro era difficile poter vincere con un candidato come Massa, a carico del dicastero dell’economia ed il suo 44% di appoggio è dovuto più al voto “anti-Milei” che al suo magro consenso.
La crisi economica e sociale, la stanchezza politica ed il disincanto di gran parte della popolazione sono stati i principali alleati di Milei. Dopo il governo di destra guidato da Mauricio Macri (2015-2019), con un bilancio finale di povertà, inflazione e debito record, il timido governo peronista di Alberto Fernández (2019-2023) non ha redistribuito la ricchezza.
È utile ed opportuno ricordare che il Paese è sottoposto alla pesante ipoteca delle condizioni capestro del Fondo Monetario Internazionale (FMI), al quale l’Argentina sta ripagando dolorosamente un gigantesco prestito di 44 miliardi di dollari concesso nel 2018 al governo ultraconservatore di Mauricio Macri.
La parola magica del “cambiamento” e della eliminazione della “casta politica parassitaria” ha funzionato ancora una volta nei dibattiti in televisione e negli algoritmi del Big data e delle reti sociali che hanno seminato odio e violenza irrazionale.
Il risultato è stato il “voto castigo” di una popolazione allo stremo, contro una gestione economica dell’attuale governo che non ha saputo dare risposte ad una crisi sempre più profonda. Così, la maggioranza degli elettori ha optato per un “cambiamento radicale” con Milei, un personaggio profondamente misogino, che ha proposto la vendita di organi, l’eliminazione della Banca Centrale, la dollarizzazione dell’economia e la privatizzazione della sanità e dell’istruzione (che però dipende in parte dalle province), della Tv pubblica e della agenzia di notizie statale Telam, in nome della “libertà di mercato”.
Gli spin doctors gli hanno evidentemente suggerito di moderare l’immagine fortemente aggressiva che ha avuto in campagna elettorale e ieri Milei è apparso in televisione tranquillo, senza la motosega (cinese) con cui prometteva eliminare la “casta”. Ha ratificato la linea dell’aggiustamento strutturale e la ristrutturazione economica, la volontà di dare seguito all’accordo con il FMI e di “fare a pezzi” lo “Stato nemico”, mentre ha glissato sulla sua proposta di dollarizzazione fatta in campagna elettorale. Ha sorvolato anche sulla promessa rottura dei rapporti diplomatici e commerciali con Brasile e Cina, rispettivamente primo e secondo partner commerciale dell’Argentina, una proposta vista con preoccupazione dai settori esportatori del Paese. C’è da aspettarsi anche un tentativo di riforma dei rapporti di lavoro, delle pensioni, in una linea regressiva di ristrutturazione dell’ordine capitalista. Milei è andato oltre nel suo discorso, respingendo l’idea di “unità nazionale” proposta da Massa, e facendo appello a tutti gli “argentini per bene” a far parte del suo progetto. In altre parole, una subordinazione degli altri settori al suo progetto di estrema destra, “con misure drastiche senza mezze misure” per realizzare ciò che non si è potuto portare a termine nel governo Macri.
Ratificando il suo programma di governo, neo-liberista e “libertario”, Milei ha minacciato la repressione “implacabile” contro tutti “i violenti” che si opporranno al programma del suo prossimo governo, “nel rispetto delle leggi”.
“Il modello di casta impoverente è finito” ha continuato Milei. “Oggi adottiamo il modello della libertà, per tornare a essere una potenza mondiale”. E nel quartier generale della sua campagna, tra musica hard rock e la popolare murga, centinaia di persone hanno cantato e scandito lo slogan preferito dal candidato: “La casta ha paura”.
Il nuovo presidente eletto è anche un dichiarato negazionista climatico, che sostiene che il cambiamento climatico non sia una responsabilità umana, ma una “bugia del socialismo”.
Con queste proposte ha catturato la rabbia che ha orientato il voto dei più giovani che non vedono prospettive di futuro, le paure del ceto medio impoverito e anche di settori popolari tradizionalmente peronisti. È stata un’ennesima espressione delle periodiche esplosioni sociali (oggi in chiave elettorale) che si scatenano in Argentina, conseguenza di un modello di sviluppo che, se da una parte cerca di proteggere la produzione nazionale e di favorire i più poveri ed esclusi, dall’altra non può e/o non vuole affrontare i cambiamenti strutturali necessari. Un modello che rimane ancorato e subordinato a un’economia dominata dal capitale finanziario e dai gruppi multinazionali su scala globale.
E a proposito di capitale finanziario, lunedì è giorno festivo in Argentina e mentre scrivo i mercati locali sono chiusi. Nel frattempo, continua la speculazione finanziaria e anche oggi il dollaro parallelo superava i 1000 pesos al cambio (poco meno del triplo del cambio ufficiale). Vedremo martedì cosa succederà nel mercato finanziario argentino ed internazionale.
Dopo il Brasile con Bolsonaro, El Salvador con Bukele, l’Ecuador con il milionario Noboa, oggi è il turno dell’Argentina con Milei, mentre in Cile il pinochetista Kast bussa alla porta. Si tratta di personaggi “dell’antipolitica” che si presentano come svincolati dai partiti tradizionali (di destra, di centro-destra o progressisti), incolpandoli delle crisi economiche e delle loro conseguenze sociali.
L’accordo con Macri per il ballottaggio
Sul piano interno, ha funzionato l’accordo per il ballottaggio con Macri e Bullrich, rappresentanti della odiata “casta” sconfitti al primo turno. Infatti, dal primo turno Milei ha aumentato il suo consenso dal 30% al 55% di oggi grazie al passaggio di voti dalla destra neo-liberista di Macri e Bullrich, buona parte dei voti di Juan Schiaretti, governatore di Cordoba della destra peronista (conosciuto anche come El Gringo), ed alla conferma dell’appoggio dell’estrema destra fascista e della “famiglia militare”.
Lo scorso agosto, Milei è stato la grande sorpresa delle elezioni primarie, conquistando il primo posto con il 30% dei voti e affermandosi così, a tempo di record, come uno dei politici emblematici dell’ultradestra latino-americana. Questa leadership era impensabile per un uomo che tre anni fa era considerato solo un personaggio popolare dei media che lo invitavano nei salotti televisivi visto che l’odio garantisce audience. Ma contro ogni previsione, Milei è diventato deputato nazionale nel 2021. Da allora, a poco a poco, e senza che nessun sondaggio lo prevedesse, ha spiazzato le coalizioni che hanno dominato la politica argentina negli ultimi due decenni in termini di voti.
In Argentina si ristruttura il quadro politico, l’estrema destra e la destra si riallineano con una nuova leadership, a partire dall’alleanza Macri-Milei, che trascina Bullrich. Vedremo come si concretizzerà negli incarichi di governo e nel programma a partire dal 10 dicembre.
L’odio per il kirchnerismo ed il declino del peronismo
Da tempo, l’obiettivo della destra fascista e di quella conservatrice era quello di eliminare alla radice il kirchnerismo, espressione dell’odiata ala progressista del peronismo che ha eletto due presidenti, prima Nestor Kirchner e poi in due occasioni Cristina Fernandez, oggi vice-presidente. Con una pesantissima ed incessante artiglieria mediatica, le destre hanno fatto l’impossibile affinché Cristina non potesse partecipare alla sfida elettorale, prima con una guerra giudiziaria a tutto campo, poi con un tentativo frustrato di assassinarla. Cristina si è tenuta distante dagli scenari elettorali ed oggi il kirchnerismo è molto più debole.
Continua così la lunga agonia del peronismo, come complesso fenomeno politico e sociale specifico di questo Paese. Un fenomeno che fuori dall’Argentina si è sempre faticato a comprendere. Al declino dell’egemonia politica e culturale ha contribuito l’attuale presidente, Alberto Fernandez, un “peronista” che aveva suscitato molte speranze, ma che i suoi stessi compagni di partito hanno spedito in Cina in piena campagna elettorale.
Le prospettive economiche del capitale
A differenza del Paese, per il capitalismo argentino ci sono discrete prospettive economiche, anche grazie alla probabile maggiore entrata di valuta per la vendita di energia. Se lo scorso anno è stato un anno di deficit energetico con una forte importazione, per il prossimo anno si prevede un equilibrio della bilancia commerciale energetica. Infatti, al tradizionale export primario (soia, grano, mais), si aggiunge l’energia (principalmente il gas del giacimento di Vaca muerta). Sarà quindi più facile ottenere un superavit consolidando le riserve internazionali, con maggiori risorse per pagare le alte scadenze del debito sia con il FMI, che con i creditori privati. Oltre a ciò, il governo di Milei stimolerà l’export di litio, rame, oro, approfondendo il modello primario-esportatore estrattivista, rafforzando il potere delle multinazionali petrolifere e minerarie e quello delle grandi imprese nazionali di alimenti e di biotecnologia.
Il movimento popolare nella nuova fase
Non c’è dubbio che con questo voto si apre una nuova fase politica in Argentina. Così come il 2001 è stato uno spartiacque che ha esaurito la logica del bi-partitismo, oggi sembra chiudersi la fase delle “bi-coalizioni” (rappresentata dal Macrismo da un lato e dal kirchnerismo dall’altro) con entrambe le coalizioni al cui interno esistevano le espressioni tradizionali del peronismo e del “radicalismo”. È apparso un nuovo attore, Milei, che ha prima disordinato e poi riordinato la strategia della destra.
A questo dovrebbe corrispondere una nuova e diversa strategia della sinistra e dello stesso “peronismo progressista”. E sarà da vedere la risposta del movimento popolare e sindacale che oggi è obbligato a ripensarsi e riorganizzarsi, insieme alla sinistra, sia quella con presenza parlamentare che quella senza. Appare urgente una riflessione autocritica per ricostruire un movimento popolare di massa, cosciente, con una prospettiva di trasformazione, di conflitto con il potere economico e oligarchico e con il FMI.
Più in generale, quello che è successo affonda le sue radici nel cambio del capitalismo su scala mondiale con la dura offensiva capitalista ed i nuovi progetti della destra. Ma fino ad oggi, non solo in Argentina, il “campo popolare” ha offerto vecchie soluzioni a nuovi problemi.
A partire da questa pesante sconfitta, vedremo se da parte della sinistra e del movimento popolare ci sarà una capacità di leggere queste trasformazioni nel capitalismo mondiale e di queste nuove destre, per riuscire a creare le condizioni per una proposta politica alternativa. Una proposta che deve fare i conti con il fatto che sono stati i settori impoveriti a marcare la differenza e dare luce verde al progetto dell’ultradestra in sintonia con quanto accaduto con Trump negli Stati Uniti, Bolsonaro in Brasile, Meloni in Italia, etc.
Sono queste alcune delle novità che arrivano dall’Argentina: una ristrutturazione della politica che cerca di consolidare una ristrutturazione economica, cosa che la stessa dittatura militare non era riuscita a fare, a differenza dell’epoca di Menem (come dirigente della destra peronista). Non è riuscito a farlo neanche Macri ed ora tocca a Milei (insieme a Macri) cercare di avanzare in questo progetto. Non bisogna quindi sottovalutare l’alleanza Macri-Milei, visto che, nel frattempo, Macri è riuscito a piazzare il fratello al governo della città di Buenos Aires, ed ora mette le mani sulla presidenza con l’idea di consolidare questo progetto.
Il grande interrogativo è se queste destre riusciranno a mantenere il consenso con questo programma di governo o si creeranno le condizioni di resistenza già viste in Argentina prima con il menemismo e poi con De la Rua nello scontro del 2001. Milei arriva al governo senza maggioranza parlamentare, senza l’appoggio di molti governatori e con ampli settori della popolazione contro di lui e contro la sua vicepresidente Victoria Villarruel, figlia di un conosciuto militare, negazionista e nostalgica della dittatura e del passato criminale. Quello della dittatura e dei 30.000 desaparecidos è un tema molto sensibile in Argentina, ma il negazionismo si fa strada anche in questo Paese.
Lo scenario è quindi di forte incertezza, a breve e medio termine. Parafrasando una conosciuta affermazione di Mao Tse-tung, grande è il disordine sotto il cielo, ma per i progetti di trasformazione la situazione è lungi dall’essere eccellente.
FONTE: https://marcoconsolo.altervista.org/argentina-e-la-motosega-del-neo-fascismo-ultraliberista/
L’aumento delle tensioni e delle spese militari nello scacchiere Asia-Pacifico (Economia di guerra – Parte VI°)
di Andrea Vento
Lo scacchiere Asia-Pacifico, comprendente, al netto del Medio Oriente, Asia ed Oceania, a causa delle crescenti tensioni geopolitiche in atto da ormai un decennio, è divenuta da alcuni anni la seconda macroregione/continente terrestre per spese militari raggiungendo, nel 2022, i 575 miliardi di $, dietro solo al Nord America, primo con 904 miliardi, nel cui contesto gli Stati Uniti coprono ben il 98% del totale. La poco confortante corsa al riarmo dell’area Asia-Pacifico è testimoniata dai dati del Sipri (tabella 1) i quali evidenziano il più cospicuo aumento delle spese militari nel decennio 2013-22 fra le macroregioni terrestri, ben il 48%, con l’Europa seconda al 38%, non causalmente l’altro principale teatro di scontro degli Stati Uniti per il mantenimento della sua declinante egemonia mondiale unilaterale (carta 1).
Tabella 1: ripartizione della spesa militare mondiale espressa in miliardi di $ per continenti e macroregioni terrestri e variazioni 2021-22 e 2013-22. Fonte: Sipri 2023
| Ripartizione della spesa militare per continenti e macroregioni | ||||
| Continenti e macroregioni | Spesa militare 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | % di spesa mondiale |
| Totale mondiale | 2.240 | 3,7 | 19 | 100 |
| Africa | 39,4 | -5,3 | -6,4 | 1,8 |
| Africa Settentrionale | 19,1 | -3,2 | 11 | O,9 |
| Africa Sub-sahariana | 20,3 | -7,3 | -18 | 0,9 |
| Americhe | 961 | 0,3 | 3,5 | 43 |
| America Settentrionale | 904 | 0,7 | 3,7 | 40 |
| America Centrale | 11,2 | -6,2 | 38 | 0,5 |
| America Meridionale | 46,1 | -6,1 | -5,4 | 2,1 |
| Asia e Oceania | 575 | 2,7 | 47 | 26 |
| Asia Centrale | 1,4 | -29 | -20 | 0,1 |
| Asia Orientale | 397 | 3,5 | 50 | 18 |
| Asia Sud-Orientale | 43,1 | -4,0 | 13 | 1,9 |
| Asia Meridionale | 98,3 | 4,0 | 46 | 4,4 |
| Oceania | 35,3 | 0,5 | 48 | 1,6 |
| Europa | 480 | 13 | 38 | 21 |
| Europa Centro-Occiden | 345 | 3,6 | 30 | 15 |
| Europa Orientale | 135 | 58 | 72 | 6 |
| Medio Oriente | 184 | 3,2 | -1,5 | 8,2 |
Carta 1: lo scenario europeo e quello dell’indo-Pacifico teatri di scontro mondiali

Le “due catene di isole” statunitensi presidiano la faglia geopolitica dell’Estremo oriente
La specificità della macroregione che in ambienti statunitensi viene definita Indo-Pacifico, è determinata dalla profonda frattura geopolitica che scorre ai bordi del mar Cinese Orientale e di quello Meridionale separando, in Estremo Oriente, la zona d’influenza cinese da quella statunitense, con quest’ultima che si articola in due linee fortificate tramite una fitta rete di basi militari, distanti mediamente dai 1.000 ai 2.000 km e all’incirca con lo stesso andamento nord-sud (carta 2 e 3).
La “prima catena di isole” come viene definita la linea più ravvicinata al continente, attraversa l’arcipelago giapponese passando per lo strategico avamposto militare di Okinawa, scorre sul confine tra le due Coree, lambisce Taiwan da levante, per poi inglobare nella zolla statunitense Indonesia, Malesia e Vietnam, delimitando entrambi i mari prospicienti le coste cinese.
L’altra linea fortificata, la “seconda catena di isole”, origina anch’essa dal Giappone nei pressi di Tokyo, raggiunge l’isola di Guam, fondamentale roccaforte Usa dotata di numerose basi navali e aree1, e termina nell’estremità nord-occidentale della Nuova Guinea, in territorio indonesiano.
La doppia linea fortificata creata dagli Stati Uniti in collaborazione con i suoi alleati regionali, ha creato una superiorità marittima su una vasta area, corrispondente al mar cinese meridionale, sulla quale Washington fino a pochi or sono esercitava un sostanziale controllo della navigazione (carta 2 e 3).
Carta 2: la carta geopolitica dell’Indo-Pacifico con basi militari Usa. Fonte: Limes

La strategia espansionistica di Pechino nel mar Cinese Meridionale
La Repubblica Popolare, con l’acuirsi delle tensioni, ha percepito la superiorità del potere marittimo statunitense come un crescente pericolo sia militare, anche alla luce delle alleanze militari strette da Washington nell’area, sia per la sicurezza della navigazione mercantile nel mar Cinese Meridionale, che ha come rotta ineludibile verso Occidente lo stretto di Malacca, un passaggio di particolare fragilità geopolitica per l’arteria commerciale dell’economia cinese, in quanto controllato da Washington tramite una base navale a Singapore (carta 2 e 3).
In considerazione di ciò, a Pechino sussiste il non infondato timore che in caso di uno scontro con gli Stati Uniti, questi ultimi si troverebbero nelle condizioni di imporre un blocco navale nello stretto di Malacca e di interrompere gli approvvigionamenti di materie prime e i flussi commerciali in uscita creando in tal modo gravi problemi all’economia cinese. Pertanto, per la Cina il controllo dei due mari prospicienti le sue coste costituisce un elemento imprescindibile, sia in chiave economica, che di sicurezza nazionale, oltre ad un forte valore simbolico per un Paese che ambisce ad un ruolo geopolitico proporzionale alla levatura economica.
Carta 3: Mar cinese orientale e meridionale e le due cinture insulari fortificate create dagli Usa in funzione anti Pechino. Autore: Alberto Bellotto

Il governo cinese, quindi, da alcuni ha anni iniziato a reclamare il controllo di circa l’80% del mar Cinese Meridionale e a presidiarlo tramite pattugliamenti aerei e navali. Vi ha, inoltre, costruito la base militare di Yulin nella propria isola meridionale di Hannan e avamposti militari su isole artificiali negli arcipelaghi Paracel e Spratly, tutt’oggi oggetto di contenzioso con vari Stati rivieraschi, soprattutto il Vietnam (carta 4). Il mar Cinese Meridionale è divenuto, ormai da alcuni anni, una delicata area geostrategica di scontro, anche per la presenza di risorse ittiche e ed energetiche, fra Cina e Vietnam, Filippine, Malesia, Brunei e, addirittura, Taiwan, tutti Paesi a vario titolo alleati di Washington, con alcuni che ospitano basi militari Usa sul proprio territorio2.
Per Pechino il quadrante in questione rappresenta un’area di tale vitale importanza da aver indotto il governo a varare un’apposita dottrina, l’Anti-access/area-denial (Ad/a2)3, che teorizza l’interdizione delle forze avversarie dall’area compresa tra le proprie coste e la parte centro-meridionale della “prima catena di isole”, dove sono localizzate numerose basi statunitensi.
Al contempo gli Stati Uniti hanno intensificato i pattugliamenti nel mar Cinese Meridionale4, le visite di importanti esponenti politici a Taiwan e le forniture di armi a Taipei5, progettato nuove basi e stretto nuove alleanze militari, facendo salire ulteriormente la tensione, soprattutto in merito allo status dell’isola che Pechino aspira a riunificare in qualità di sua 22esima provincia. Isola che, invece, gli Stati Uniti stanno riarmando nella prospettiva di impedirne il ritorno alla Cina e di trasformarla in un caposaldo fortificato, al pari della vicina Okinawa, della “prima catena di isole”. Conseguentemente alle tensioni, nell’area dell’indo-Pacifico sono sensibilmente aumentate anche le esercitazioni militari sia di singoli Stati, come quelle cinesi nei pressi di Taiwan, che congiunte fra Paesi che hanno convergenze di interessi nell’area, come Russia e Cina, da un lato, e Usa con Vietnam6 e Filippine7, dall’altro.
La pressione statunitense nel mar Cinese Orientale
A nord di Taiwan, la frattura geopolitico-militare, che fiancheggia il mar Cinese Orientale, attraversando l’arco delle isole minori giapponesi per poi raggiungere le quattro maggiori, rappresenta una struttura militare fortificata avversaria che sta creando problematiche ancor maggiori a Pechino, anche per la presenza di due stretti “alleati” degli Stati Uniti, come Giappone8 e Corea del Sud9 dove ha impiantato una fitta rete di basi militari, vi effettua esercitazioni congiunte e vi sta aumentando le forniture di armamenti10.
Tramite la disputa per le strategiche isole Diaoyu/Senkaku attualmente sotto controllo amministrativo di Tokyo, la Cina cerca di contendere al Giappone il controllo della porzione del mar Cinese Orientale (carta 4) a occidente delle suddette isole11. I rapporti di forza sfavorevoli a Pechino, anche per la vicinanza alle proprie coste della “prima catena di isole” in questo mare, lo hanno indotto a indirizzare la propria strategia verso il controllo del bacino marittimo del Sud-Est asiatico, principale rotta del commercio marittimo mondiale nonché base di espansione della sua potenza militare nella macroregione.
Carta 4: le rivendicazioni marittime e le dispute insulari cinesi

L’aumento delle spese militari alimentano i venti di guerra
L’area circostante la profonda faglia in questione rappresenta, insieme all’Europa Orientale, una dei due principali teatri di scontro a livello mondiale le cui crescenti tensioni hanno alimentato la politica di riarmo in tutti gli attori geopolitici regionali a partire dalla Cina. Pechino, infatti, registrando il 28° anno consecutivo di aumento delle spese, è salita a 292 miliardi nel 2022 con una crescita record del 63% nel decennio 2013-22.
Tuttavia, la Repubblica Popolare seppur secondo Paese per spese militari in valore assoluto a livello mondiale, evidenzia un rapporto delle stesse col Pil dell’1,6% inferiore a quello di Stati Uniti 3,5%, Russia 4,1% e India 2,6%, oltre ad altri importanti player mondiali, che le riserva la possibilità di espanderle ulteriormente senza gravare eccessivamente sulla ricchezza nazionale e sul bilancio statale (tab. 2).
Tabella 2: i primi 15 stati per spese militari nel 2022. Fonte Sipri 2023
| I primi 15 stati per spese militari nel 2022 | |||||
| Stato | Spesa militare in miliardi di $ | % di spesa globale | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil |
| Stati Uniti | 887,0 | 39,0 | 0,7 | 2,7 | 3,5 |
| Cina | 292,0 | 13,0 | 4,2 | 63 | 1,6 |
| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 4,1 |
| India | 81,4 | 3,6 | 6,0 | 4,7 | 2,4 |
| Arabia Saudita | 75,0 | 3,3 | 16,0 | -2,7 | 7,4 |
| Regno Unito | 68,5 | 3,1 | 3,7 | 9,7 | 2,2 |
| Germania | 55,8 | 2,5 | 2,3 | 33 | 1,4 |
| Francia | 53,6 | 2,4 | 0,6 | 15 | 1,9 |
| Corea del Sud | 46,4 | 2,1 | -2,5 | 37 | 2,7 |
| Giappone | 46,0 | 2,1 | 5,9 | 18 | 1,1 |
| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 34,0 |
| Italia | 33,5 | 1,5 | -4,5 | 24 | 1,7 |
| Australia | 32,3 | 1,4 | 0,3 | 47 | 1,9 |
| Canada | 26,9 | 1,2 | 3,0 | 49 | 1,2 |
| Israele | 23,4 | 1,0 | -4,2 | 26 | 4,5 |
| Totale primi 15 | 1.842,0 | 82,0 | |||
| Restanti stati | 398,0 | 18,0 | |||
| Totale globale | 2.240,0 | 100,0 | 3,7 | 19 | 2,2 |
Anche in questo delicato scacchiere geopolitico, l’aumento delle tensioni legate alla politica statunitense di contenimento della, tutto sommato legittima, strategia di espansione dell’influenza cinese nei mari adiacenti le proprie coste, sta pericolosamente trainando al rialzo le spese militari degli attori regionali. L’Asia Orientale, rappresenta infatti la seconda macroregione terrestre ad aver registrato il più cospicuo aumento delle spese militari nel decenni 20013-2022, pari a +50%, solo dietro all’Europa dell’Est che detiene il poco invidiabile primato mondiale con +72% (tab. 1)
Una trama ormai tristemente famosa, e da noi recentemente analizzata nel saggio “Lo scontro strategico per l’egemonia globale sospinge l’aumento delle spese militari”12, che lascia intravedere lo stesso drammatico finale verificatosi nell’est europeo, una volta terminata la guerra in Ucraina. Tuttavia, a complicare ulteriormente i piani di Washington per il mantenimento dell’egemonia globale affrontando militarmente in modo separato prima con la Russia e, successivamente, con la Cina, è involontariamente intervenuta la guerra a Gaza, che col rischio di allargamento del conflitto ad altri attori regionali, ha costretto gli Stati Uniti a spostare corposi gruppi navali dotati di portaerei nel Mediterraneo Occidentale e nel golfo Persico. Al cospetto dell’esito non favorevole della guerra in Ucraina, il doversi impegnare militarmente su più fronti contemporaneamente, sia direttamente che indirettamente, potrebbe rivelarsi una situazione complessa anche per la superpotenza mondiale. Situazione della quale sono perfettamente consapevoli al Pentagono, la speranza è che lo siano altrettanto alla Casa Bianca.
Andrea Vento – 4 novembre 2023
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1 L’isola di Guam fondamentale per la strategia degli Stati Uniti nell’Indo-Pacifico. https://nododigordio.org/breaking-news/lisola-di-guam-fondamentale-per-la-strategia-degli-stati-uniti-nellindo-pacifico/
2 https://www.analisidifesa.it/2022/11/nuove-basi-americane-nelle-filippine-in-equilibrio-tra-usa-e-cina/
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-access/area_denial#:~:text=Anti%2DAccess%2FArea%20Denial%20(,from%20entering%20an%20operational%20area.
4 https://www.agi.it/estero/news/2023-04-17/taiwan_nave_guerra_usa_nello_stretto_condanna_pechino-20998526/
5 https://www.atlanteguerre.it/armi-usa-a-taiwan-una-bomba-a-orologeria/
6 https://www.china-files.com/esercitazione-navale-congiunta-vietnam-usa-innervosisce-pechino/
7 https://www.china-files.com/al-via-la-piu-grande-esercitazione-tra-usa-e-filippine/
8 https://www.asianews.it/notizie-it/Con-uno-sguardo-alla-Cina,-Tokyo-si-unir%C3%A0-alle-esercitazioni-militari-di-Jakarta-e-Washington-56354.html
9 https://www.ilsole24ore.com/art/usa-corea-sud-riprendono-esercitazioni-militari-quattro-anni-AENWVhuB
10 https://www.ilsole24ore.com/art/corsa-riarmo-giappone-usa-nuova-commessa-militare-aerei-sorveglianza-AEV2me2C
11 https://it.wikipedia.org/wiki/Crisi_sino-giapponese_per_le_isole_Senkaku
12 https://cambiailmondo.org/2023/10/23/economia-di-guerra-parte-v-lo-scontro-strategico-per-legemonia-globale-sospinge-laumento-delle-spese-militari/
La soluzione finale di Israele per i palestinesi
Quando gli estremisti ebrei, i sionisti fanatici, i fanatici religiosi, gli ultranazionalisti e i cripto-fascisti dello Stato di apartheid di Israele dicono di voler cancellare Gaza dalla faccia della terra, credetegli.
di Chris Hedges

Ho seguito la nascita del fascismo ebraico in Israele. Ho raccontato dell’estremista Meir Kahane, a cui fu impedito di candidarsi e il cui partito Kach fu messo fuori legge nel 1994 e dichiarato organizzazione terroristica da Israele e dagli Stati Uniti. Ho assistito ai comizi politici di Benjamin Netanyahu, che riceveva lauti finanziamenti dagli americani di destra, quando si candidò contro Yitzhak Rabin, che stava negoziando un accordo di pace con i palestinesi. I sostenitori di Netanyahu cantavano “Morte a Rabin”. Bruciarono un’effigie di Rabin vestito con un’uniforme nazista. Netanyahu marciò davanti a un finto funerale di Rabin.
Il primo ministro Rabin fu assassinato il 4 novembre 1995 da un fanatico ebreo. La vedova di Rabin, Lehea, incolpò Netanyahu e i suoi sostenitori per l’omicidio del marito.
Netanyahu, che è diventato primo ministro nel 1996, ha trascorso la sua carriera politica alimentando estremisti ebrei, tra cui Avigdor Lieberman, Gideon Sa’ar, Naftali Bennett e Ayelet Shaked. Suo padre, Benzion – che lavorò come assistente del pioniere sionista Vladimir Jabotinsky, che Benito Mussolini definì “un buon fascista” – era un leader del partito Herut che chiedeva allo Stato ebraico di impadronirsi di tutta la terra della Palestina storica. Molti di coloro che costituivano il partito Herut compirono attacchi terroristici durante la guerra del 1948 che istituì lo Stato di Israele. Albert Einstein, Hannah Arendt, Sidney Hook e altri intellettuali ebrei descrissero il Partito Herut in una dichiarazione pubblicata dal New York Times come un “partito politico molto simile per organizzazione, metodi, filosofia politica e attrattiva sociale ai partiti nazista e fascista”.
C’è sempre stato un ceppo di fascismo ebraico all’interno del progetto sionista. Ora ha preso il controllo dello Stato israeliano.
“La sinistra non è più in grado di superare l’ultranazionalismo tossico che si è sviluppato qui”, ha avvertito nel 2018 Zeev Sternhell, sopravvissuto all’Olocausto e massima autorità israeliana in materia di fascismo, “il tipo di fascismo di ceppo europeo ha quasi spazzato via la maggioranza del popolo ebraico”. Sternhell ha aggiunto: “Non vediamo solo un fascismo israeliano in crescita, ma un razzismo simile al nazismo nelle sue fasi iniziali”.
La decisione di cancellare Gaza è stata a lungo il sogno dei cripto-fascisti israeliani, eredi del movimento di Kahane. Questi estremisti ebrei, che compongono il governo di coalizione al potere, stanno orchestrando il genocidio a Gaza, dove centinaia di palestinesi muoiono ogni giorno. Essi sostengono l’iconografia e il linguaggio del loro fascismo nazionale. L’identità ebraica e il nazionalismo ebraico sono la versione sionista del sangue e del suolo. La supremazia ebraica è santificata da Dio, così come il massacro dei palestinesi, che Netanyahu ha paragonato ai biblici Ammoniti, massacrati dagli israeliti. I nemici – di solito musulmani – destinati all’estinzione sono subumani che incarnano il male. La violenza e la minaccia di violenza sono le uniche forme di comunicazione che comprendono coloro che sono al di fuori del cerchio magico del nazionalismo ebraico. Milioni di musulmani e cristiani, compresi quelli con cittadinanza israeliana, devono essere epurati.
Un documento trapelato di 10 pagine del Ministero dell’Intelligence israeliana, datato 13 ottobre 2023, raccomanda il trasferimento forzato e permanente dei 2,3 milioni di residenti palestinesi della Striscia di Gaza nella penisola del Sinai in Egitto.
È un grave errore non prendere sul serio gli appelli sanguinari allo sradicamento e alla pulizia etnica dei palestinesi. Questa retorica non è iperbolica. È una prescrizione letterale. Netanyahu in un tweet, poi rimosso, ha descritto la battaglia con Hamas come una “lotta tra i figli della luce e i figli delle tenebre, tra l’umanità e la legge della giungla”.
Questi fanatici ebrei hanno iniziato la loro versione della soluzione finale alla questione palestinese. Hanno sganciato 12.000 tonnellate di esplosivo su Gaza nelle prime due settimane di assalto per cancellare almeno il 45% delle unità abitative di Gaza, secondo l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite. Non hanno intenzione di essere distolti, nemmeno da Washington.
“È diventato evidente ai funzionari statunitensi che i leader israeliani ritenevano che le vittime civili di massa fossero un prezzo accettabile nella campagna militare”, ha riferito il New York Times.
“In conversazioni private con le controparti americane, i funzionari israeliani hanno fatto riferimento al modo in cui gli Stati Uniti e le altre potenze alleate hanno fatto ricorso a bombardamenti devastanti in Germania e Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale – compreso il lancio delle due testate atomiche a Hiroshima e Nagasaki – per cercare di sconfiggere quei Paesi”, ha continuato il giornale.
L’obiettivo è un Israele “puro”, ripulito dalle contaminazioni palestinesi. Gaza deve diventare una terra desolata. I palestinesi di Gaza saranno uccisi o costretti a rifugiarsi in campi profughi oltre il confine, in Egitto. La redenzione messianica avrà luogo una volta che i palestinesi saranno stati espulsi. Gli estremisti ebrei chiedono la demolizione della moschea di Al-Aqsa, il terzo santuario più sacro per i musulmani, costruito (ma non ci sono prove storiche, ndt) sulle rovine del Secondo Tempio ebraico, distrutto nel 70 d.C. dall’esercito romano. La moschea sarà sostituita da un “Terzo” Tempio ebraico, una mossa che infiammerà il mondo musulmano. La Cisgiordania, che gli zeloti chiamano “Giudea e Samaria”, sarà formalmente annessa da Israele. Israele, governato dalle leggi religiose imposte dai partiti ultraortodossi Shas e United Torah Judaism, sarà una versione ebraica dell’Iran (che però è uno stato multietnico e plurilingue, ndt).
Il passo verso il controllo totale di Israele sulla terra palestinese è breve. Gli insediamenti ebraici illegali di Israele, le zone militari riservate, le autostrade chiuse e i recinti dell’esercito si sono impadroniti di oltre il 60% della Cisgiordania, trasformando le città e i villaggi palestinesi in ghetti inanellati. Ci sono oltre 65 leggi che discriminano direttamente o indirettamente i cittadini palestinesi di Israele e quelli che vivono nei territori occupati. La campagna di uccisioni indiscriminate di palestinesi in Cisgiordania, molte delle quali ad opera di milizie ebraiche disoneste, insieme alla demolizione di case e scuole e alla confisca delle terre palestinesi rimaste, esploderà. Oltre 133 palestinesi sono stati uccisi in Cisgiordania dall’esercito israeliano e dai coloni ebrei dall’incursione di Hamas del 7 ottobre e migliaia di palestinesi sono stati radunati dall’esercito israeliano, picchiati, umiliati e imprigionati.
Israele, allo stesso tempo, si sta scagliando contro i “traditori ebrei” che si rifiutano di abbracciare la visione demenziale dei fascisti ebrei al potere e che denunciano l’orribile violenza dello Stato. I nemici familiari del fascismo – giornalisti, sostenitori dei diritti umani, intellettuali, artisti, femministe, liberali, di sinistra, omosessuali e pacifisti – sono già stati presi di mira. La magistratura, secondo i piani presentati da Netanyahu, sarà neutralizzata. Il dibattito pubblico si inaridirà. La società civile e lo Stato di diritto cesseranno di esistere. Coloro che sono stati etichettati come “sleali” saranno deportati.
I fascisti non rispettano la sacralità della vita. Gli esseri umani, anche quelli della loro stessa tribù, sono sacrificabili per costruire la loro squilibrata utopia. I fanatici al potere in Israele avrebbero potuto scambiare gli ostaggi detenuti da Hamas con le migliaia di ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane, motivo per cui gli ostaggi israeliani sono stati sequestrati. E ci sono prove che nei caotici combattimenti che hanno avuto luogo una volta che i militanti di Hamas sono entrati in Israele, l’esercito israeliano ha deciso di colpire non solo i combattenti di Hamas, ma anche i prigionieri israeliani con loro.
“Diverse nuove testimonianze di testimoni israeliani dell’attacco a sorpresa di Hamas del 7 ottobre contro il sud di Israele si aggiungono alle prove crescenti che l’esercito israeliano ha ucciso i propri cittadini mentre combatteva per neutralizzare gli uomini armati palestinesi”, scrive Max Blumenthal su The Grayzone.
Tuval Escapa, un membro della squadra di sicurezza del kibbutz Be’eri, osserva Blumenthal, ha istituito una linea telefonica diretta per coordinare i residenti del kibbutz e l’esercito israeliano.
Escapa ha raccontato al quotidiano israeliano Haaretz che, quando la disperazione ha iniziato a farsi sentire, “i comandanti sul campo hanno preso decisioni difficili, tra cui quella di bombardare le case e i loro occupanti per eliminare i terroristi insieme agli ostaggi”.
Il giornale ha riferito che i comandanti israeliani sono stati “costretti a richiedere un attacco aereo” contro la propria struttura all’interno del valico di Erez a Gaza “per respingere i terroristi” che avevano preso il controllo. La base ospitava ufficiali e soldati dell’Amministrazione civile israeliana.
Israele, nel 1986, ha istituito una politica militare chiamata Direttiva Annibale, apparentemente dal nome del generale cartaginese che si avvelenò piuttosto che essere catturato dai Romani, in seguito alla cattura di due soldati israeliani da parte di Hezbollah. La direttiva è stata concepita per evitare che le truppe israeliane cadano nelle mani del nemico attraverso il massimo uso della forza, anche a costo di uccidere i soldati e i civili catturati.
La direttiva è stata eseguita durante l’assalto israeliano del 2014 a Gaza, noto come Operazione Protective Edge. Il 1° agosto 2014 i combattenti di Hamas catturarono un ufficiale israeliano, il tenente Hadar Goldin. In risposta, Israele sganciò più di 2.000 bombe, missili e granate sull’area in cui era detenuto. Goldin fu ucciso insieme a oltre 100 civili palestinesi. La direttiva sarebbe stata revocata nel 2016.
Gaza è l’inizio. La Cisgiordania è la prossima.
Gli israeliani che si rallegrano dell’incubo palestinese presto subiranno un incubo tutto loro.
FONTE: https://chrishedges.substack.com/p/israels-final-solution-for-the-palestinians
Traduzione: Cambiailmondo.org
Le élite occidentali in declino sono diventate il principale ostacolo allo sviluppo dell’umanità
Il modo in cui i media affrontano il massacro di Gaza è un salto di qualità morale.

di PAOLO FERRERO
Di fronte all’ennesimo atto del genocidio in corso in Palestina, il sentimento che ci attanaglia è di drammatica impotenza, di sgomento per un orrore a cui assistiamo in tempo reale con la drammatica impressione di non poter fare nulla. Ci rimane una cosa: dire cosa ne pensiamo, cercare di comunicare agli altri umani il nostro pensiero. Questo mi appresto a fare.
Il modo in cui i principali apparati – statuali, militari, informativi – occidentali trattano il massacro in corso a Gaza da parte delle truppe occupanti israeliane rappresenta un salto di qualità morale che parla del degrado assassino delle élite occidentali. Due mi paiono le caratteristiche principali. Le costruzione di una narrazione fondata integralmente sulle menzogne. Non è solo il problema delle singole bugie – che pure sono rilevanti – dalla ipotetica decapitazione dei bambini alle accuse ad Hamas di aver bombardato l’ospedale battista di Gaza. E’ il complesso della narrazione che rovescia la realtà, descrivendo gli occupanti, ipertecnologici e iperarmati, che hanno violato per decenni tutte le risoluzioni della Nazioni Unite come le povere vittime, mentre i palestinesi sono descritti come barbari violenti e bruti, non umani, come ha detto senza avere grandi reazioni negative il ministro della Difesa israeliano.
I non umani, questa razza inferiore che abusivamente occupa da secoli i propri territori, viene infatti sottoposto ad apartheid dallo stato israeliano senza che questo faccia problema ai potentati occidentali. Anzi questi ultimi considerano e dipingono questo stato fondato sull’apartheid e sul razzismo come un baluardo della democrazia. Sull’accettazione di questo stato di fatto l’occidente costruisce una narrazione fondata integralmente su un doppio standard valutativo: gli israeliani vengono barbaramente assassinati, i palestinesi muoiono; gli uni si difendono, gli altri sono sadici criminali, e così via.
Non voglio proseguire oltre perché qualunque persona dotata di una qualche capacità critica nell’uso della propria intelligenza è in grado di rintracciare altre decine di esempi. Il nodo è cogliere il punto di fondo che a mio parere emerge: le élite occidentali in declino sono diventate il principale ostacolo allo sviluppo dell’umanità nella sua accezione più ampia. Stanno perdendo il primato economico, quello tecnologico e quello finanziario. In particolare quelle statunitensi ritengono che il tempo e la pace giochino a loro sfavore e che solo la guerra possa ristabilire il dominio di un occidente in declino. E’ l’occidente a mettere in discussione la pace mondiale e la Nato è stata ristrutturata nel corso dell’ultimo anno per essere lo strumento operativo attraverso cui perseguire la strategia di guerra a livello mondiale.
La Cina e tutte le potenze emergenti del Sud del mondo, che viaggiano a velocità doppia dell’occidente, sono interessate ad avere la pace. Perché grazie alla pace possono sovvertire le gerarchie mondiali. Anche la Russia, che a causa del cambio climatico vedrà la Siberia diventare il granaio del mondo nei prossimi decenni (due terzi delle terre coltivabili mondiali) ed è un autentico forziere di materie prime con una una popolazione assai ridotta, ha tutto da guadagnare in una situazione di pace. Le élite occidentali, che nella pace vedono la perdita del proprio potere e dei propri privilegi, sono interessate alla guerra. Per questo l’unica strada è il decoupling, il disaccoppiamento. Non tra l’economia occidentale e quella cinese, ma tra i popoli occidentali e le élite che le dominano colonizzando integralmente l’immaginario.
Rendere evidente che gli interessi dei popoli occidentali – sempre più impoveriti – non hanno nulla a che vedere con quelli delle élite occidentali e che i valori della civiltà occidentale non hanno nulla a che vedere con quelli propagandati dalle élite mi pare il vero compito che abbiamo, qui ed ora in occidente. Produrre una consapevolezza che i nostri nemici non hanno gli occhi a mandorla o la pelle scura, ma sono “i nostri” che ci sfruttano cercando di ammaestrarci blandendoci e manipolando la realtà.
Proprio in questa ora buia, la protesta di centinaia di ebrei statunitensi che insieme ad altri hanno occupato il Campidoglio per manifestare contro il governo israeliano e per il cessate il fuoco ci indicano che questa strada è possibile. Nella protesta dei nostri fratelli con la kippah in testa che hanno chiesto che gli Stati Uniti la smettano di finanziare il genocidio israeliano nei Territori palestinesi e che per questo sono stati arrestati, vediamo la speranza e la strada da seguire: la più netta, radicale separazione e contrapposizione alle élite che dicono di rappresentarci. Not in my name non è solo uno slogan ma deve diventare il punto di partenza del nostro modo di pensare e di agire. Di essere.
Ai miei amici israeliani: ecco perché sostengo i palestinesi – di Ilan Pappé

Non è sempre facile attenersi alla propria bussola morale, ma se punta a nord – verso la decolonizzazione e la liberazione – allora molto probabilmente essa ci guiderà attraverso la nebbia della propaganda velenosa.
di Ilan Pappé*
È difficile mantenere la propria bussola morale quando la società a cui si appartiene – sia i leader che i media – si arroga il primato morale e si aspetta che si condivida con loro la stessa giusta furia con cui hanno reagito agli eventi dello scorso sabato 7 ottobre.
C’è solo un modo per resistere alla tentazione di unirsi a loro: se a un certo punto della vostra vita – anche come cittadini ebrei di Israele – avete compreso la natura coloniale del sionismo e siete rimasti inorriditi dalle sue politiche contro la popolazione indigena della Palestina.
Se avete avuto questa consapevolezza, allora non vacillerete, anche se i messaggi velenosi descrivono i palestinesi come animali o “animali umani”. Queste stesse persone insistono nel descrivere ciò che è avvenuto sabato scorso come un “Olocausto”, abusando così della memoria di una grande tragedia. Questi sentimenti vengono trasmessi giorno e notte dai media e dai politici israeliani.
È questa bussola morale che ha portato me, e altri nella nostra società, a stare al fianco del popolo palestinese in ogni modo possibile; e che ci permette, allo stesso tempo, di ammirare il coraggio dei combattenti palestinesi che hanno conquistato una dozzina di basi militari, superando l’esercito più forte del Medio Oriente.
Inoltre, persone come me non possono fare a meno di interrogarsi sul valore morale o strategico di alcune delle azioni che hanno accompagnato questa operazione.
Poiché abbiamo sempre sostenuto la decolonizzazione della Palestina, sapevamo che quanto più a lungo fosse continuata l’oppressione israeliana, tanto meno la lotta di liberazione sarebbe stata “sterile” – come è accaduto in ogni giusta lotta di liberazione del passato, ovunque nel mondo.
Questo non significa che non si debba tenere d’occhio il quadro generale, nemmeno per un minuto. Il quadro è quello di un popolo colonizzato che lotta per la sopravvivenza, in un momento in cui i suoi oppressori hanno eletto un governo deciso ad accelerare la distruzione, anzi l’eliminazione del popolo palestinese – o addirittura della sua stessa pretesa di essere un popolo.
Hamas doveva agire, e in fretta.
È difficile dare voce a queste controargomentazioni perché i media e i politici occidentali hanno assecondato il discorso e la narrazione israeliana, per quanto problematica fosse.
Mi chiedo quanti di coloro che hanno deciso di vestire il Palazzo del Parlamento di Londra e la Torre Eiffel di Parigi con i colori della bandiera israeliana capiscano veramente come questo gesto apparentemente simbolico venga accolto in Israele.
Persino i sionisti liberali, con un minimo di decenza, hanno letto questo gesto come un’assoluzione totale di tutti i crimini che gli israeliani hanno commesso contro il popolo palestinese a partire dal 1948; e quindi come una carta bianca per continuare il genocidio che Israele sta ora perpetrando contro la popolazione di Gaza.
Fortunatamente, ci sono state anche reazioni diverse agli eventi che si sono svolti negli ultimi giorni.
Come in passato, ampi settori della società civile occidentale non si lasciano facilmente ingannare da questa ipocrisia, già in bella mostra nel caso dell’Ucraina.
Molti sanno che dal giugno 1967 un milione di palestinesi è stato imprigionato almeno una volta nella vita. E con l’imprigionamento arrivano anche gli abusi, le torture e la detenzione permanente senza processo.
Queste stesse persone conoscono anche l’orribile realtà che Israele ha creato nella Striscia di Gaza quando ha sigillato la regione, imponendo un assedio ermetico, a partire dal 2007, accompagnato dall’incessante uccisione di bambini nella Cisgiordania occupata. Questa violenza non è un fenomeno nuovo, poiché è il volto permanente del sionismo fin dalla fondazione di Israele nel 1948.
Proprio grazie a questa società civile, cari amici israeliani, il vostro governo e i vostri media saranno alla fine smentiti, perché non potranno rivendicare il ruolo di vittime, ricevere un sostegno incondizionato e farla franca con i loro crimini.
Alla fine, il quadro generale emergerà, nonostante i media occidentali siano intrinsecamente parziali.
La grande domanda, tuttavia, è la seguente: anche voi, amici israeliani, sarete in grado di vedere chiaramente questo quadro generale? Nonostante anni di indottrinamento e ingegneria sociale?
E, non meno importante, sarete in grado di imparare l’altra importante lezione – che si può trarre dagli eventi recenti – che la forza pura e semplice non può trovare l’equilibrio tra un regime giusto da un lato e un progetto politico immorale dall’altro?
Ma c’è un’alternativa. Anzi, c’è sempre stata:
Una Palestina de-sionizzata, liberata e democratica dal fiume al mare; una Palestina che riaccolga i rifugiati e costruisca una società che non discrimini sulla base della cultura, della religione o dell’etnia.
Questo nuovo Stato si impegnerebbe a correggere, per quanto possibile, i mali del passato, in termini di disuguaglianza economica, furto di proprietà e negazione dei diritti. Questo potrebbe annunciare una nuova alba per tutto il Medio Oriente.
Non è sempre facile attenersi alla propria bussola morale, ma se questa punta a nord – verso la decolonizzazione e la liberazione – allora molto probabilmente vi guiderà attraverso la nebbia della propaganda velenosa, delle politiche ipocrite e della disumanità, spesso perpetrata in nome dei “nostri comuni valori occidentali”.
Originale in Inglese Qui
* Ilan Pappé è docente presso at the University of Exeter ed ex docente di scienze politiche presso l’Università di Haifa.
Pubblicazioni: La Pulizia Etnica della Palestina, Storia della Palestina Moderna, 10 Miti su Israele, La prigione più grande del mondo,
Ilan Pappé è uno dei ‘nuovi storici’ israeliani che, dopo la pubblicazione di documenti britannici e israeliani nei primi anni ’80, hanno contribuito a riscrivere la storia della creazione di Israele nel 1948.
FONTE: https://www.palestinechronicle.com/my-israeli-friends-this-is-why-i-support-palestinians-ilan-pappe/
Leggi anche:
Ilan Pappe: la Palestina è stata distrutta in 12 mesi, ma la Nakba dura da 75 anni
L’economia di guerra in Russia e nell’Eurozona (IV Parte)

L’economia di guerra parziale russa “tiene”, mentre l’Eurozona rallenta e la Germania scende in recessione
di Andrea Vento*
Negli ultimi mesi Mosca sta evidenziando un ciclo economico in ripresa, ordinativi industriali in aumento e un regime di cambio controllato, al cospetto di una lieve ripresa dell’inflazione, un rialzo dei tassi e una riduzione del saldo commerciale.
* * * *
L’economia russa dopo la moderata, rispetto alle catastrofiche previsioni iniziali (-8,5%), recessione del -2,1% del 2022 e le prospettive di crescita per l’anno in corso dell’Outlook Fmi di luglio del 1,5% (tabella 1), grazie e non solo a un surplus commerciale positivo seppur in diminuzione (tabella 2), sembrerebbe evidenziare, benché non priva di criticità, una sostanziale tenuta, sia per l’anno in corso che nei due successivi.
Tabella 1: previsioni e dati definitivi in % anni 2022, 2023 e 2024 degli Word Economic Outlook Fmi
| Tipologia di dati | Previsioni 2022 | Previsioni 2022 | Definitivo 2022 | Previsioni 2023 | Previsioni 2023 | Previsioni 2023 | Previsioni 2024 |
| Economic Outlook Fmi emesso a: | Aprile 2022 | Ottobre 2022 | Luglio 2023 | Gennaio 2023 | Aprile 2023 | Luglio 2023 | Luglio 2023 |
| Economia mondiale | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,0 |
| Russia | -8,5 | -3,4 | -2,1 | 0,3 | 0,7 | 1,5 | 1,3 |
| Stati Uniti | 3,7 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| Germania | 2,1 | 1,5 | 1,8 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | 1,3 |
| Italia | 2,3 | 3,2 | 3,7 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 0,9 |
| Cina | 4,4 | 3,2 | 3,0 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,5 |
| India | 8,2 | 6,8 | 7,2 | 6,1 | 5,7 | 6,1 | 6,3 |
Il deficit di bilancio e la strategia di ripianamento
Per Mosca, eventuali rischi potrebbero essere invece legati alla sostenibilità del deficit nel medio-lungo periodo, nell’eventualità in cui la solidità fiscale venga messa a rischio dalla riduzione delle entrate derivanti dal gas e dal petrolio nel caso dovessero scendere e permanere al di sotto della soglia di base fissata per la stabilità di bilancio. Situazione alquanto improbabile per il petrolio il cui prezzo, grazie alla convergenza strategica delineatasi in seno all’Opec+ sull’asse Mosca-Riyad, a seguito dei recenti tagli apportati alla produzione si mantiene da inizio luglio fra gli 80 e 100 $ al barile (grafico 1).
Stante la sostanziale solidità patrimoniale attuale della Federazione Russa, con riserve auree pari 2.330 tonnellate1 oltre a quelle monetarie, i deficit di bilancio, previsto dal ministro delle finanze per l’anno in corso al 2-2,5%2, vengono ripianati, come in passato, attingendo dal Fondo patrimoniale nazionale (NWF)3 senza particolari problematiche visto che il 1° aprile di quest’anno l’entità dello stesso ammontava a 154,5 miliardi di dollari, pari al 7,9% del PIL nazionale e, oltretutto, risultava in crescita di 7 miliardi, rispetto ai 147,2 del 1° marzo4.
Tabella 2: interscambio commerciale globale Russia anni 2020-23. Fonte: http://www.infomercatiesteri5
| Interscambio commerciale Russia | |||||
| 2020 Dati rilevati | 2021 Dati rilevati | 2022 Dati stimati | 2023 Previsioni a maggio 2023 | 2023 Previsioni al 4/10/2023 | |
| Valore export totale (mld €) | 301,1 | 431 | 495,4 | 418,9 | 386,7 |
| Valore import totale (mld €) | 206,9 | 257 | 228,8 | 236,5 | 279,1 |
| Saldo bilancia commerciale (mld €) | 94,2 | 174 | 266,6 | 182,4 | 99,2 |
Grafico 1: quotazione del Brent fra luglio e il 6 ottobre 2023.
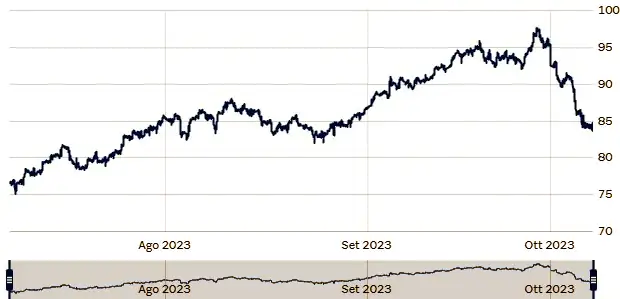
Nonostante il rapporto deficit/Pil previsto per il 2023 risulti sostanzialmente in linea col 2,3% dello scorso anno, alla luce della ritorno alla crescita, il deficit di bilancio in valore assoluto, sulla spinta dell’aumento delle spese militari, registrerà a fine anno sicuramente un incremento, intorno ai 55 miliardi di $ (tabella 3).
Tabella 3: le spese di bilancio dello Federazione Russa nel I semestre 2023 in miliardi di $
| Uscite di bilancio | Spesa militare | % di spesa pubblica | Deficit di bilancio | Rapporto Deficit/Pil | |
| I semestre 2023 dati rilevati | 162 | 60,5 | 37,3% | 29,3 (gennaio-luglio6) | 1,8% (gennaio-luglio) |
| Anno 2022 dati rilevati | 477 | 2,3% |
La fase espansiva dell’economia russa
A conferma della fase espansiva evidenziata dagli Outlook del Fmi per l’economia russa per l’anno in corso, sussiste il trend dell’indice Pmi manifatturiero8 a settembre salito a 54,59 nonché da gennaio stabilmente al di sopra della soglia dei 50 punti, lo spartiacque fra espansione e contrazione dell’attività economica (tabella 4),
Tabella 4: valori dell’indice Pmi manifatturiero gennaio-settembre 2023 di Russia, Eurozona, Germania e Italia.
| 2023 | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre |
| Russia10 | 52,6 | 53,6 | 53,2 | 52,6 | 53,5 | 52,6 | 52,1 | 52,7 | 54,5 |
| Eurozona11 | 48,4 | 48,5 | 47,3 | 45,8 | 44,8 | 43,4 | 42,7 | 43,5 | 43,4 |
| Germania | 47,3 | 46,3 | 44,4 | 44,5 | 42,9 | 40,6 | 38,8 | 39,1 | 39,6 |
| Italia | 48,8 | 48,5 | 51,1 | 46,8 | 45,9 | 44,5 | 45,4 | 45,8 | 46,8 |
La produzione industriale russa, sta decisamente procedendo a ritmo sostenuto con i nuovi ordinativi che hanno registrato il maggior incremento dal gennaio 2017. La fase industriale espansiva risulta sospinta dalla domanda interna, in particolare dagli ordinativi pubblici indotti dallo sforzo bellico e, seppur in minor misura, anche da parte della domanda privata, in crescita grazie all’aumento delle retribuzioni, mentre hanno registrato solo un modesto incremento gli ordinativi esteri a causa di un contesto geoecomico avverso sui mercati occidentali a seguito delle sanzioni. In Russia la domanda di input produttivi sta sensibilmente aumentando a seguito del ripristino delle scorte di armamenti necessari a garantire la difesa e a sostenere l’impegno militare sul fronte ucraino, oltre che a soddisfare la domanda privata. Conseguentemente negli ultimi trimestri sono aumentati sia l’occupazione, che ha raggiunto il valore più elevato dal novembre 2020 e registrato il più elevato tasso di crescita degli ultimi 23 anni12, sia i salari, sull’onda dell’incremento della domanda di lavoro13. In trend decrescente, il tasso di disoccupazione si è quindi attestato al 3,1% in estate.
L’andamento dell’economia russa per il 2023 è conseguentemente certificato in fase espansiva da tutti gli Outllook del Fmi: dal + 0,3% di gennaio, al + 0,7% di aprile fino all’1,5% di luglio (tabella 1) in attesa di quello in ulteriore crescita di ottobre, stimato intorno al 2%, con previsioni per il 2024 del 2,3%, secondo i dati del governo russo diramati a metà settembre14, mentre la Banca Centrale russa, confermando la sua tradizionale prudenza, indica un aumento del Pil fra 0,5% e 1,5%15.
Il rallentamento economico dell’Eurozona con recessione della “locomotiva tedesca”
L’andamento economico dell’Eurozona risulta invece in chiara fase di rallentamento a causa delle ricadute negative delle sanzioni alla Russia, del Piano REPowerEU, dell’aumento del costo dell’energia, dell’inflazione e, soprattutto, del rialzo dei tassi. La variazione del Pil è già risultata non positiva in Germania (0,0%) e Italia (-0,3%)16 nel secondo trimestre 2023, con aspettative analoghe per il terzo, le quali, nel caso fossero confermate, decreterebbero lo stato di recessione tecnica per le due principali manifatture europee. Inoltre, le previsioni della Commissione Europea di contrazione del Pil dello -0,4% per Berlino a fine anno, conclamerebbero lo stato di recessione della “locomotiva tedesca”, situazione che, sempre secondo la Commissione, produrrà inevitabili ripercussioni sull’intera economia dell’Eurozona, prevista in rallentamento a +0,8% a settembre dal precedente 1,1%17. Tendenza quest’ultima, in linea con le previsioni che scaturiscono dai valori del indice Pmi degli ordinativi della manifattura che nell’Eurozona risultano in chiara fase declinante con lo stesso indice sceso dal 48,5 di febbraio a 43,418 di settembre (tabella 4), il valore più basso dal 201219. Particolarmente critica la contrazione dell’industria tedesca, principalmente a causa della perdita di competitività prodotta dall’aumento del costo dell’energia, dopo la rinuncia al conveniente gas russo col piano REPowerEU e il sabotaggio dei gasdotti del Baltico, come certificato dalla contrazione dell’indice Pmi passato dal 47,3 di gennaio al 39,1 di agosto, poi leggermente risalito al 39,6 di settembre. Valori corrispondenti ad uno stato di recessione.
Inflazione, quotazione del rublo e manovra sui tassi
Il tasso di inflazione in Russia, dopo essere stato in doppia cifra dall’inizio dell’escalation militare fino a febbraio 2023, dal mese successivo ha registrato una marcata contrazione fino ad una media mensile intorno al 3%, addirittura 2,3% ad aprile, per poi risalire a luglio al 4,3%20, al 5,2%21 ad agosto e al 5,5% a settembre. Un valore non particolarmente elevato per un Paese sotto sanzioni e impegnato in un conflitto militare, nonché fino a due mesi or sono sostanzialmente in linea con quello dell’Eurozona, quest’ultimo attestatosi al 5,2% a luglio e al 5,3% ad agosto, per poi ripiegare sotto il rialzo dei tassi da parte della Bce, ormai giunti al 4,5%, ad un valore previsto del 4,3%-4,5%22 a settembre23.
A fine febbraio dello scorso anno l’avvio dell’operazione militare speciale russa e le prime tranche di sanzioni, comprendenti il congelamento delle riserve della Banca Centrale russa depositate presso Usa, Germania e Francia, hanno immediatamente creato un clima di sfiducia nei confronti anche della valuta russa, la quale ha inevitabilmente subito un rapido deprezzamento che l’ha portata a quasi dimezzare il suo valore in un mese, dai 77 rubli per 1 dollaro dell’11 febbraio ai 134 rubli dell’11 marzo, subendo addirittura una svalutazione del 30% il solo 28 febbraio (grafico 2).
Grafico 2: andamento cambio dollaro-rublo fra dicembre 2021 e 5 ottobre 2023
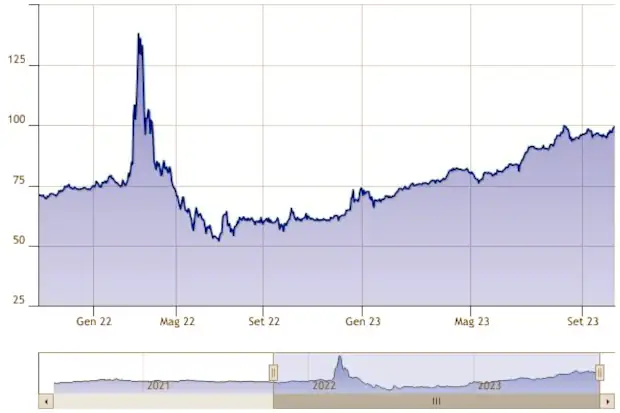
Nell’intento di arginare la grave situazione finanziaria, la Banca Centrale di Russia (Bank of Russia) ha tempestivamente introdotto i seguenti provvedimenti straordinari: il raddoppio dei tassi dal 9,5% al 20% (grafico 3), il sostegno alla propria moneta tramite le non indifferenti riserve in valuta estera all’epoca ancora disponibili, visto il congelamento di circa la metà dei 642 miliardi di $, ma soprattutto, l’obbligo per i cosiddetti “paesi ostili” di provvedere al pagamento degli acquisti di materie prime e prodotti energetici in rubli. Quest’ultimo provvedimento, appurata la scarsità di rubli in circolazione sui mercati internazionali, è stato attuato imponendo agli operatori stranieri dei 37 Paesi che avevano comminato le sanzioni a Moca, di aprire un conto speciale nel quale versare il corrispettivo in dollari o euro, poi convertiti dalla Banca Centrale in rubli per procedere all’espletamento dei pagamenti. Nella sostanza, quest’ultima vende i rubli necessari ad onorare le transazioni, acquisendo preziosa valuta straniera.
Grafico 3: tassi d’interesse della Banca Centrale russa fra febbraio 2013 e settembre 202324

Le misure adottate dalla Governatrice Elvira Nabiullina sono riuscite nel breve termine non solo ad evitare il collasso del rublo, ma anche a sospingerne il corso verso il rialzo, arrivando a toccare i 52 rubli per un dollaro il 30 giugno 2022. Rivalutazione trainata, oltre che dall’aumento della domanda di rubli indotta dalle nuove regole, anche dall’incremento delle entrate dell’export, sostenute dal forte rialzo delle quotazioni del petrolio e soprattutto del gas (grafico 4 – tabella 2).
L’assestamento dell’inflazione intorno al 12-15% e il cospicuo aumento del valore dell’export ha, quindi, indotto la Banca Centrale russa già a partire da aprile 2022 ad intraprendere una rapida riduzione dei tassi25 dal 9,5% di giugno, all’8% di luglio26 fino al 7,5% di settembre (grafico 2), nell’intento di ridare fiato agli investimenti. Conseguentemente, dall’estate 2022 il rublo ha subito un lento ma costante processo di svalutazione, favorito anche dalla riduzione del surplus commerciale (tabella 2), il quale, nonostante il rialzo dei tassi all’8,5% di luglio scorso, è arrivato ad cambio di 102 per dollaro il 10 agosto (grafico 2), data in cui, in base a quanto precedentemente comunicato, la Banca Centrale russa avrebbe cessato gli acquisti di valuta straniera a sostegno della propria divisa. A questo punto, il 15 agosto, la Governatrice Nabiullina è intervenuta con nuove misure di sostegno, le cui ricadute prevedevano orizzonti temporali diversificati: nell’immediato, un nuovo rialzo dei tassi al 12,0%27 (grafico 3) i cui effetti hanno rapidamente riportato il cambio col dollaro sotto quota 100 (grafico 2) e, in prospettiva, ha avviato il progetto del rublo digitale con l’obiettivo di effettuare transazioni internazionali aggirando le sanzioni contro il proprio sistema bancario. Alla riunione della Banca Centrale russa era presente anche il ministro delle finanze, nel cui ambito ha presentato un piano di misure indirizzate agli esportatori nazionali concernenti, fra le varie, l’obbligo di rimettere in circolazione all’interno del Paese fino all’80% dei guadagni ottenuti dalle vendite in valuta estera, al fine di evitarne la tesaurizzazione e l’impiego oltreconfine. In sostanza la ripresa, seppur non drammatica, dell’inflazione sommata al deprezzamento del rublo ha indotto la Banca centrale ad intervenire prontamente sin da agosto.
Grafico 4: andamento della quotazione del gas sul mercato TTF fra ottobre 2021 e 3 ottobre 2023
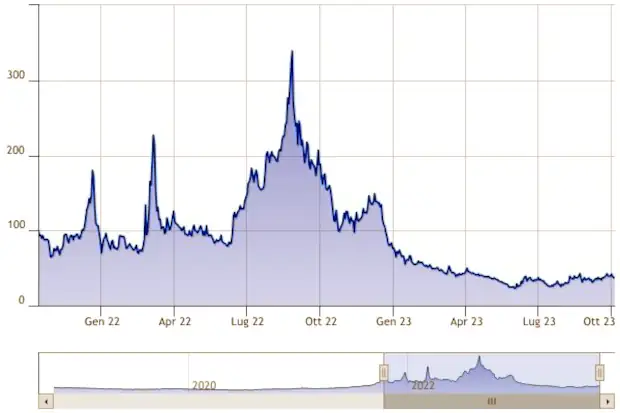
Bank Rossii28, la Banca Centrale russa, nel suo comunicato al termine della riunione di Ferragosto ha specificato le finalità dei provvedimenti adottati: “La decisione della Banca di Russia è volta a plasmare le condizioni monetarie e la dinamica complessiva necessarie per riportare l’inflazione al 4% nel 2024. Andando avanti, nel suo processo decisionale sui tassi chiave, la Banca di Russia terrà conto delle dinamiche dell’inflazione effettiva e attesa relative all’obiettivo e ai processi di trasformazione economica, nonché dei rischi posti dalle condizioni interne ed esterne e dalla reazione dei mercati finanziari”29. Conseguentemente a tali linee di politica monetaria e di controllo dell’inflazione, la Banca Centrale russa ha apportato un ulteriore ritocco, innalzando il 15 settembre il tasso al 13% (grafico 3), sostenendo il corso della propria valuta, la quale infatti si è mantenuto sotto la soglia di conversione dei 100 rubli per dollaro (grafico 2).
Secondo l’analisi del sito specializzato teleborsa.it30, la Banca Centrale russa avrebbe adottato efficaci politiche di gestione della propria valuta tramite un regime di “cambio controllato” che ha generato un rafforzamento del rublo di fronte al clima di sfiducia creatosi a fine febbraio 2022. Le prime misure di emergenza adottate in quella fase, come visto, avevano scongiurato il crollo del rublo, mentre successivamente è stato necessario pilotarne il cambio al fine di stabilizzare il mercato, tramite un deprezzamento governato, in modo da farlo scendere a livelli tali da massimizzare i proventi in rubli derivanti dalle esportazioni, oltre a disincentivare le importazioni, le quali non casualmente nel corso del 2022 hanno registrato una diminuzione rispetto all’anno precedente (tabella 2).
La situazione economico-finanziaria della Russia, dal febbraio 2022 ad oggi, a nostro avviso è stata inquadrata efficacemente, e fuori da preconcetti ideologici, dall’economista Chris Weafer, profondo conoscitore della Russia dove ha lavorato per 15 anni anche in qualità di Chief Strategist alla Sberbank, la principale banca russa: “Mentre le sanzioni eroderanno la crescita economica a lungo termine, il rublo recentemente più debole non implica una crisi economica di fondo, non suggerisce che la Russia stia per cadere in un precipizio. Anzi, fino ad ora il declino del rublo ha soddisfatto il governo perché ha aumentato la quantità di rubli per ogni dollaro di entrate energetiche, aiutando il Cremlino a mantenere la spesa per i programmi militari e le agenzie governative. In generale possiamo dire che la debolezza generale era pianificata, ma è andata oltre le aspettative, e per questo la Banca Centrale è intervenuta per aumentare i tassi di interesse”31.
Sulla scorta della nostra analisi, sembrerebbero dunque piuttosto improbabili tracolli dell’economia, della valuta e del bilancio statale della Federazione Russa, la cui economia di guerra parziale, adottata gradualmente nell’ultimo anno e mezzo, sta facendo fronte sia allo sforzo bellico, con le spese militari che nel primo semestre di quest’anno sono salite al 37,3% delle uscite di bilancio, ma solo al 5% del Pil (grafico 5), sia alle undici tranche di sanzioni comminate dall’Occidente globale a partire dal 22 febbraio 2022, giorno successivo al riconoscimento delle Repubbliche Popolari di Donetsk e di Lugansk da parte di Mosca. Draconiani provvedimenti restrittivi che sino ad oggi hanno tuttavia creato maggiori ripercussioni negative nei Paesi Ue di quanto non sia al momento avvenuto in Russia, come emerso anche dalle nostre analisi precedenti323334.
Grafico 5: l’incidenza percentuale delle spese per la difesa sul Pil in Russia dal 2000 ad oggi
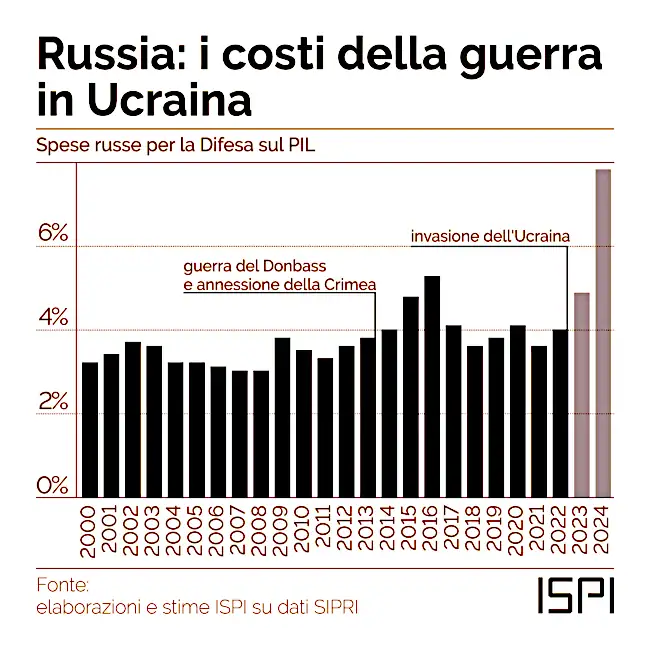
Conclusioni
Di fronte al totale fallimento della controffensiva ucraina e alle pesanti ricadute sulle economie occidentali, europee in primis, anche il fronte del sostegno incondizionato alla guerra ad oltranza, iniziato già in estate a vacillare a seguito delle dichiarazioni del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Statunitensi, Mark Milley, sulla tenuta delle linee difensive russe35, si è definitivamente incrinato in queste settimane, prima con la dichiarazione del governo polacco di cessazione degli aiuti all’Ucraina e poi con una serie di Paesi “sostenitori” che hanno iniziato a mostrare crescente insofferenza verso nuove forniture di armi a Kiev. In primis, l’accordo negli Usa fra democratici e repubblicani del 30 settembre che ha evitato lo shutdown, il blocco delle attività della Pubblica amministrazione, col quale questi ultimi, sempre più recalcitranti verso il proseguimento della guerra, hanno ottenuto lo stop a nuovi aiuti all’Ucraina. Oltre alla consolidata posizione avversa dell’Ungheria di Orban, la vittoria in Slovacchia alle presidenziali del 30 settembre dell’ex premier Robert Fico che in campagna elettorale aveva promesso la fine degli aiuti a Kiev, ha dato la stura a tutta una serie di dichiarazioni da parte di politici occidentali, fra cui quello del nostro ministro della difesa Crosetto, le quali indicano chiaramente che la stagione della guerra a oltranza è ormai in fase declinante sotto il peso dell’effetto boomerang delle sanzioni, le quali le stanno pagando i ceti popolari in Occidente, e della definitiva presa di coscienza in merito alla tenuta delle forze armate, dell’economia e del bilancio statale della Russia. Quest’ultimo, considerato in Occidente l’elemento di maggior debolezza di Mosca, in realtà nonostante l’incremento del deficit per l’anno in corso (tabella 2), verrà ripianato senza alcun problema sia quello relativo all’anno in corso, sia quelli dei due anni successivi, ricorrendo, come effettuato sino ad oggi, al Fondo patrimoniale nazionale (NWF).
La perversa strategia statunitense di fomentare e condurre guerre in giro per il Pianeta e poi di abbandonare il campo quando la situazione volge al peggio, lascandosi alle spalle Paesi disastrati, morti e instabilità politica, è evidentemente ancora la bussola alla quale si ispirano le amministrazioni di Washington nell’espletamento della loro politica di potenza. Per informazioni fresche in merito chiedere al popolo afghano, l’ultimo in ordine di tempo a subire il trattamento.
Il capolavoro statunitense è che nel caso della guerra incorso, il conto, oltre che il popolo ucraino, in termini economici lo pagano i ceti popolari europei al posto loro, come ha finalmente ammesso due giorni fa anche il nostro ministro dell’economia Giorgetti: “Il prezzo economicamente maggiore lo stiamo pagando noi. La guerra (evitando accuratamente di citare le sanzioni e il piano REPowerEU, ndr) ha generato un’esplosione di costi energetici che si è riflessa in un’inflazione trasferita poi su tutti i settori. Ciò ha generato una politica monetaria restrittiva per combattere l’inflazione e l’aumento dei tassi di interesse sta generando un processo recessivo”.
Il Re è finalmente nudo e sotto gli occhi di tutti.
* Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
Note:
1 https://legrandcontinent.eu/it/2023/09/27/economia-russa-il-rublo-ai-livelli-piu-bassi-dallinizio-della-guerra/
2 https://interfax.com/newsroom/top-stories/93522/
3 NWF è un fondo sovrano controllato dal Ministero delle finanze fondato nel 2008 e composto dai proventi energetici accumulati negli anni.
4 https://it.marketscreener.com/quotazioni/azione/AEROFLOT-6494676/attualita/Il-Fondo-di-ricchezza-nazionale-della-Russia-e-aumentato-di-7-miliardi-di-dollari-a-154-5-miliardi-d-43436704/
5 https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_paesi=88#
6 https://www.reuters.com/article/russia-economy-budget-idUSL8N39O2TO
7 https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_10.01.2023_18.19_52610526
8 L’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) è un indicatore macro-economico riferibile separatamente a 3 settori manifatturiero, dei servizi e delle costruzioni. Per risalire al PMI si svolge un’indagine su un campione di aziende alle quali vengono poste domande in relazione ai diversi aspetti come ad esempio l’andamento della produzione, gli ordinativi ricevuti, i prezzi, le aspettative future etc. Le risposte ottenute vengono poi riportate in forma statistica per cui l’indice PMI assumerà un valore compreso tra 0.0 e 100.0. I valori al di sopra del 50.0 indicano l’espansione del settore d’indagine, mentre i valori inferiori al 50.0 ne rivelano lo stato di contrazione. Gli indici PMI vengono interpretati come indicatori dello stato di salute dell’economia, per questo hanno forte impatto sui mercati.
9https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2023/10/02/in-russia-migliora-il-manifatturiero-indice-pmi-a-545_a5ed57ae-7038-4dc0-a0c3-3c66ed2a8102.html
10 https://it.tradingeconomics.com/russia/manufacturing-pmi
11 https://lab24.ilsole24ore.com/recessione-dati-grafici/
12 https://it.marketscreener.com/notizie/ultimo/Russia-balzo-Pmi-industria-su-crescita-domanda-interna–44962823/
13https://www.milanofinanza.it/news/russia-l-indice-pmi-manifatturiero-sale-ai-massimi-dal-2017-202310021517082152
14 https://it.euronews.com/2023/09/16/leconomia-russa-e-sullorlo-dellabisso
15 https://www.veritaeaffari.it/economia/russia-banca-centrale-alza-tassi-dinteresse-al-13/
16 https://www.ansa.it/nuova_europa/it/notizie/rubriche/economia/2023/07/31/nel-ii-trimestre-il-pil-italia-peggio-di-germania-e-francia_ada5fd26-cc27-4cae-a961-2c4842bf9f98.html
17 https://www.ilsole24ore.com/art/pil-ue-rivede-ribasso-stime-2023-europa-08percento-e-italia-09percento-AF2alXo
18https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/e20-a-settembre-indice-pmi-manifatturiero-in-lieve-calo-a-434-punti-rco-nRC_02102023_1026_224200049.html
19 https://borsaefinanza.it/pmi-crolla-la-manifattura-delleurozona-a-settembre/
20 https://it.tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
21 https://it.tradingeconomics.com/russia/inflation-cpi
22 oldionline.it/notizie/macroeconomia/inflazione-europa-2023#:~:text=Su%20base%20mensile%20i%20prezzi,aumento%20dello%200%2C3%25.
23 https://www.borse.it/articolo/ultime-notizie/inflazione-eurozona-invariata-ad-agosto-allarme-per-la-bce
24 https://it.tradingeconomics.com/russia/interest-rate
25 https://www.ilsole24ore.com/art/russia-banca-centrale-taglia-tassi-e-prevede-recessione-pil-dell-8-10percento-AE1NOHVB
26 https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2022/07/22/banca-centrale-russa-taglia-tassi-all8-nel-2022-pil-4/6_5e23f580-ca77-45dc-8ea6-b6a28547e073.html
27 https://www.global-rates.com/it/tassi-di-interesse/banche-centrali/4/interesse-russo-cbr-key-rate/
28 https://www.cbr.ru/eng/
29 https://www.milanofinanza.it/news/russia-la-banca-centrale-alza-i-tassi-al-12-per-salvare-il-rublo-pesano-l-inflazione-e-l-effetto-delle-202308151350496837?refresh_cens
30 https://www.teleborsa.it/Editoriali/2023/08/17/rublo-una-svalutazione-pilotata-1.html
31 https://www.quotidiano.net/cronaca/il-crollo-del-rublo-le-sanzioni-funzionano-e-ora-mosca-si-aggrappa-alla-moneta-digitale-28c20184
32 https://magazine.cisp.unipi.it/guerra-ucraina-un-primo-bilancio-delle-sanzioni-contro-la-russia/
33 https://cambiailmondo.org/2022/12/21/approvata-la-nona-tranche-di-sanzioni-alla-russia-nonostante-leconomia-italiana-vada-incontro-a-nuova-recessione-e-unulteriore-crisi-social/
34 https://codice-rosso.net/crisi-ucraina-solo-la-mobilitazione-popolare-puo-fermare-la-guerra/
35 https://strumentipolitici.it/americani-e-britannici-ammettono-le-capacita-dei-russi-e-limpasse-della-controffensiva-ucraina/
I palestinesi parlano il linguaggio della violenza insegnato loro da Israele

di Chris Hedges
Le uccisioni indiscriminate di israeliani da parte di Hamas e di altre organizzazioni di resistenza palestinese, il rapimento di civili, la raffica di razzi su Israele, gli attacchi dei droni su una varietà di obiettivi, dai carri armati alle postazioni di mitragliatrici automatiche, sono il linguaggio familiare dell’occupante israeliano. Israele parla questo linguaggio di violenza intriso di sangue ai palestinesi da quando le milizie sioniste si sono impadronite di oltre il 78% della Palestina storica, hanno distrutto circa 530 villaggi e città palestinesi e hanno ucciso circa 15.000 palestinesi in più di 70 massacri. Circa 750.000 palestinesi sono stati “ripuliti” etnicamente tra il 1947 e il 1949 per creare lo Stato di Israele nel 1948.
La risposta di Israele a queste incursioni armate sarà un assalto genocida a Gaza. Israele ucciderà decine di palestinesi per ogni israeliano ucciso. Centinaia di palestinesi sono già morti negli assalti aerei di Israele dal momento del lancio dell'”Operazione Al-Aqsa Flood” di sabato mattina, che ha causato 700 morti israeliani.
Il Primo Ministro Netanyahu ha avvertito domenica i palestinesi a Gaza di “andarsene subito”, perché Israele “trasformerà in macerie tutti i nascondigli di Hamas”.
Ma dove dovrebbero andare i palestinesi di Gaza? Israele ed Egitto bloccano i confini terrestri. Non c’è uscita per via aerea o marittima, che sono controllate da Israele.
La punizione collettiva contro gli innocenti è una tattica familiare utilizzata dai governanti coloniali. Noi l’abbiamo usata contro i nativi americani e poi nelle Filippine e in Vietnam. I tedeschi l’hanno usata contro gli Herero e i Namaqua in Namibia. Gli inglesi in Kenya e in Malesia. I nazisti l’hanno usata nelle aree occupate in Unione Sovietica, nell’Europa orientale e centrale. Israele segue lo stesso schema. Morte per morte. Atrocità per atrocità. Ma è sempre l’occupante a dare inizio a questa danza macabra e a scambiare mucchi di cadaveri con altri mucchi di cadaveri.
Non si tratta di difendere i crimini di guerra dell’una o dell’altra parte. Non si tratta di rallegrarsi degli attacchi. Ho visto abbastanza violenza nei territori occupati da Israele, dove ho seguito il conflitto per sette anni, da detestare la violenza. Ma questo è l’epilogo familiare di tutti i progetti coloniali. I regimi impiantati e mantenuti dalla violenza generano violenza. La guerra di liberazione di Haiti. I Mau Mau in Kenya. Il Congresso nazionale africano in Sudafrica. Queste rivolte non sempre hanno successo, ma seguono schemi familiari. I palestinesi, come tutti i popoli colonizzati, hanno il diritto alla resistenza armata secondo il diritto internazionale.
Cosa si aspetta Israele o la comunità mondiale? Come si possono intrappolare 2,3 milioni di persone a Gaza, metà delle quali disoccupate, in uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta per 16 anni, ridurre la vita dei suoi residenti, metà dei quali sono bambini, a un livello di sussistenza, privarli delle forniture mediche di base, del cibo, dell’acqua e dell’elettricità, usare aerei d’attacco, artiglieria, unità meccanizzate, missili, cannoni navali e unità di fanteria per massacrare a caso civili disarmati e non aspettarsi una risposta violenta? Israele sta attualmente effettuando ondate di assalti aerei su Gaza, sta preparando un’invasione di terra e ha tagliato la corrente elettrica a Gaza, che di solito funziona solo per due o quattro ore al giorno.
Molti dei combattenti della resistenza che si sono infiltrati in Israele sapevano senza dubbio che sarebbero stati uccisi. Ma come i combattenti della resistenza in altre guerre di liberazione, hanno deciso che se non potevano scegliere come vivere, avrebbero scelto come morire.
Israele non ha mai avuto alcun interesse a una soluzione equa con i palestinesi. Ha costruito uno Stato di apartheid e ha costantemente assorbito porzioni sempre più ampie di terra palestinese in una campagna di pulizia etnica al rallentatore. Nel 2007 ha trasformato Gaza nella più grande prigione a cielo aperto del mondo.
Sono stato amico intimo di Alina Margolis-Edelman, che faceva parte della resistenza armata nella rivolta del ghetto di Varsavia durante la Seconda guerra mondiale. Suo marito, Marek Edelman, era il vice comandante della rivolta e l’unico leader sopravvissuto alla guerra. I nazisti avevano sigillato 400.000 ebrei polacchi nel ghetto di Varsavia. Gli ebrei intrappolati morirono a migliaia, per fame, malattie e violenza indiscriminata. Quando i nazisti iniziarono a trasportare gli ebrei rimasti nei campi di sterminio, i combattenti della resistenza reagirono. Nessuno si aspettava di sopravvivere.
Dopo la guerra, Edelman condannò il sionismo come ideologia razzista usata per giustificare il furto della terra palestinese. Si schierò con i palestinesi, sostenne la loro resistenza armata e si incontrò spesso con i leader palestinesi. Ha tuonato contro l’appropriazione dell’Olocausto da parte di Israele per giustificare la repressione del popolo palestinese. Mentre Israele si nutriva della mitologia della rivolta del ghetto, trattava l’unico leader sopravvissuto della rivolta, che si rifiutava di lasciare la Polonia, come un paria. Edelman ha capito che la lezione dell’Olocausto e della rivolta del ghetto non è che gli ebrei siano moralmente superiori o vittime eterne. La storia, diceva Edelman, appartiene a tutti. Gli oppressi, compresi i palestinesi, avevano il diritto di lottare per l’uguaglianza, la dignità e la libertà.
“Essere ebreo significa stare sempre con gli oppressi e mai con gli oppressori”, ha detto Edelman.
La rivolta di Varsavia ha ispirato a lungo i palestinesi. I rappresentanti dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) sono soliti deporre una corona di fiori in occasione della commemorazione annuale della rivolta in Polonia presso il monumento del Ghetto di Varsavia.
Più il colonizzatore usa la violenza per sottomettere l’occupato, più si trasforma in un mostro. L’attuale governo di Israele è popolato da estremisti ebrei, sionisti fanatici e bigotti religiosi che stanno smantellando la democrazia israeliana e chiedono l’espulsione o l’uccisione di massa dei palestinesi, compresi quelli che vivono in Israele.
Il filosofo israeliano Yeshayahu Leibowitz, che Isiah Berlin ha definito “la coscienza di Israele”, aveva avvertito che se Israele non avesse separato la Chiesa dallo Stato, avrebbe dato origine a un rabbinato corrotto che avrebbe trasformato l’ebraismo in un culto fascista.
“Il nazionalismo religioso è per la religione ciò che il nazionalsocialismo è stato per il socialismo”, disse Leibowitz, morto nel 1994.
Aveva capito che la cieca venerazione dei militari, soprattutto dopo la guerra del 1967 che aveva conquistato il Sinai egiziano, Gaza, la Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) e le alture del Golan siriano, era pericolosa e avrebbe portato alla distruzione definitiva di Israele, insieme a qualsiasi speranza di democrazia.
“La nostra situazione si deteriorerà fino a diventare quella di un secondo Vietnam, una guerra in costante escalation senza prospettive di risoluzione finale”, ha avvertito.
Prevedeva che “gli arabi sarebbero stati il popolo lavoratore e gli ebrei gli amministratori, gli ispettori, i funzionari e la polizia, soprattutto la polizia segreta”. Uno Stato che governa una popolazione ostile di 1,5-2 milioni di stranieri diventerà necessariamente uno Stato di polizia segreta, con tutto ciò che ne consegue per l’istruzione, la libertà di parola e le istituzioni democratiche. La corruzione caratteristica di ogni regime coloniale avrebbe prevalso anche nello Stato di Israele. L’amministrazione avrebbe dovuto sopprimere l’insurrezione araba da un lato e acquisire quisling arabi dall’altro. C’è anche una buona ragione per temere che la Forza di Difesa di Israele, che finora è stata un esercito di popolo, in seguito alla trasformazione in un esercito di occupazione, degeneri, e i suoi comandanti, che saranno diventati governatori militari, assomiglino ai loro colleghi di altre nazioni”.
Egli vedeva che un’occupazione prolungata dei Palestinesi avrebbe inevitabilmente generato “campi di concentramento”.
“Israele”, ha detto, “non meriterebbe di esistere e non varrebbe la pena di conservarlo”.
La prossima fase di questa lotta sarà una massiccia campagna di massacri industriali a Gaza da parte di Israele, che è già iniziata. Israele è convinto che livelli maggiori di violenza schiacceranno definitivamente le aspirazioni palestinesi. Israele si sbaglia. Il terrore che Israele infligge è il terrore che otterrà.
FONTE: https://substack.com/
TRADUZIONE: CAMBIAILMONDO.ORG
L’economia di guerra nei Paesi direttamente coinvolti nel conflitto in Ucraina (Parte III°)

di Andrea Vento (*)
A partire dal febbraio 2022, l’escalation del conflitto in Ucraina ha finito per coinvolgere a vario titolo nello sforzo bellico, oltre ai contendenti “ufficiali”, anche un consistente numero di Paesi. Nella nostra analisi abbiamo individuato tre tipologie di Paesi: i belligeranti (Russia, Ucraina e Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk), i co-belligeranti che sostengono i primi due militarmente, finanziariamente e con attività di intelligence (soprattutto l’Ucraina da parte dei Paesi della Nato) e la restante maggioranza degli Stati, corrispondenti all’incirca a coloro che non hanno aderito alle sanzioni contro la Russia, che continuano a commerciare in genere con entrambi i blocchi e che, in diversi casi, hanno tratto giovamento dalla frattura geopolitica e dalla riorganizzazione geoeonomica. Fra questi, in primis: Cina, India, Arabia Saudita, Turchia e la maggioranza dei Paesi africani i quali, fra le varie, hanno ottenuto la promessa di forniture gratuite di grano da parte della Russia al recente “Vertice Russia – Africa” di San Pietroburgo di fine luglio1.
Per quanto riguarda nello specifico le relazione sino-russe, rileviamo come l’interscambio commerciale già nel corso del 2022 abbia registrato un aumento del 29,3% attestandosi alla cifra record di 190 miliardi di $, in base ai dati divulgati dall’Amministrazione Generale delle Dogane (GACC), agenzia statale cinese alle dirette dipendenze del Consiglio di Stato della Repubblica Popolare. Un trend crescente che è andato consolidandosi anche nel 2023, nel cui contesto nei primi sette mesi dell’anno (gennaio-luglio) è cresciuto del 36,5%, rispetto al corrispondete periodo dell’anno precedente, toccando i 134 miliardi di $. Dall’analisi disaggregata dei flussi emerge che l’export di Mosca verso Pechino ha registrato l’incremento più consistente, pari al 73,4%, grazie all’aumento sia dei volumi scambiati che dei costi delle materie prime energetiche, mente quello in direzione contraria del 15,1%, con un saldo commerciale a favore della Russia di 9,014 miliardi di dollari, frutto di un flusso in entrata di 71,559 miliardi di dollari e di 62,545 in uscita. Un’intensificazione strategica della sinergia fra le due economie che il governo cinese si è prefissato di portare a 250 miliardi di $ nel 20242 (tab. 1).
Tabella 1: interscambio commerciale Russia – Cina: 2022 e gennaio – luglio 2023 in miliardi $
| 2022 | Gennaio – luglio 2023 | Previsioni 2024 | Aumento % 2021/2022 | |
| Interscambio commerciale Russia – Cina | 190 | 134 | 250 | +29,3% |
| Export Russia in Cina | 71,559 (+73,4%) | Aumento % gen-lug 22/23 | ||
| Export Cina in Russia | 62,545 | +36,5% | ||
| Saldo positivo Russia | 9,014 |
Le specificità della situazione dell’Ucraina
Se i due contendenti sono necessariamente ricorsi entrambi all’adozione dell’economia di guerra, profonde differenze vengono rilevate tra le due situazioni: da un lato l’Ucraina, che benché sostenuta da 40 Stati oltre all’Ue3, nel 2022 ha registrato una pesante contrazione del Pil del 30,4% a causa sia della mobilitazione generale imposta dal governo che ha ridotto l’operatività delle industrie e dei servizi e ridimensionato le produzioni e le esportazioni agricole, sia delle distruzioni degli impianti industriali e delle infrastrutture provocate dal conflitto. In sostanza, l’economia di Kiev non è collassata esclusivamente a seguito del sostegno finanziario e logistico esterno e le forze armate ucraine mantengono vivo lo sforzo bellico grazie al supporto dei Paesi donatori, quelli Nato in primis.
Sulla scorta dei dati forniti dal database Ucraina Support Tracker del Kiel Institute4, l’entità totale delle varie tipologie di impegni, ripartiti fra finanziari, umanitari e militari, promessi dai governi sostenitori a Kiev, fra il 24 gennaio 2022 e il 31 luglio 2023, ammonta a 237,9 miliardi di euro, tripartiti fra Ue e stati membri (131,9 miliardi), Stati Uniti (69,5 miliardi) e altri Paesi (36,5 miliardi), con un brusca accelerazione nel mese di luglio, visto che al giorno 6 dello stesso mese gli aiuti totalizzavano 165,4 miliardi.
Dall’analisi dell’evoluzione temporale delle tipologie di sostegno emerge una tendenza verso l’aumento delle forniture militari: se nei primi 8 mesi del conflitto gli aiuti finanziari e militari risultavano abbastanza equilibrati, dall’ottobre del 2020 la quota dei secondi è andata gradualmente aumentando sino a raggiungere il 50% ad inizio 2023 e superare il 70% a maggio.
A livello di singoli Paesi donatori, rileviamo la sensibile crescita del supporto della Germania, salita al secondo posto dopo gli Usa nel corso del 2023, con 20,86 miliardi di euro per aiuti totali al 31 luglio, superando il Regno Unito (13,77 miliardi di euro). In forte aumento anche l’impegno della Norvegia che si attesta al quarto posto con 7,45 miliardi di euro, davanti al Giappone con 6,51 miliardi.
Per quanto riguarda l’Unione Europea nel suo complesso, constatiamo come negli ultimi mesi abbia incrementato lo “Strumento europeo per la pace” (European Peace Facility – EPF), sostanzialmente un fondo “fuori bilancio” per l’invio di aiuti militari istituito il 21 marzo 2021 con una dotazione di 5,692 miliardi di euro per il periodo 2021-27, finanziato proporzionalmente dagli stati comunitari in base al Pil, Danimarca esclusa, ufficialmente per rafforzare la proiezione estera dell’Ue5. All’indomani dell’escalation del conflitto, il 28 febbraio 2022, l’Unione Europea ha deciso di attivare l’EPF per sostenere militarmente l’Ucraina, arrivando ad impiegare nell’arco dello scorso anno ben l’86% dei fondi stanziati fino al 2027. In considerazione di ciò, il Consiglio dei ministri degli affari esteri dell’Ue, recependo la Decisione del 12 dicembre 2022, ha varato l’aumento degli stanziamenti di oltre due miliardi di euro, portando il massimale previsto sino al 2027 a 7,970 miliardi di euro6. Decisione che ha consentito ad un gongolante Josep Borrell, l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’Ue, di dichiarare al Consiglio di Difesa il 23 maggio scorso “grazie a questo fondo abbiamo mobilitato 10 miliardi di aiuti militari all’Ucraina, rispetto ai 3,5 miliardi di euro di rimborsi che abbiamo ricevuto (dai singoli Paesi donatori, ndr)”. Borrell probabilmente dimentica che il fondo assume la denominazione di “Strumento europeo per la pace” e che le armi non sono propriamente in linea con tale scopo, oltre ad evitare di specificare come verranno coperti i 6,5 miliardi di euro non rimborsati, visto anche il veto posto dall’Ungheria al rimborso di 500 milioni di euro, posizione che ha aperto un’incrinatura interna all’Ue7.
In relazione alle spese militari riconducibili direttamente al bilancio statale dell’Ucraina, peraltro in larga misura sostenute dai generosi finanziamenti esterni, il Sipri nel 2022 ha rilevato un incremento di ben il 640%, il più imponente aumento annuo mai registrato dall’istituto di Stoccolma in un anno e del 1.661% nel decennio 2013/22. A causa dell’escalation militare, quindi, la sola Ucraina ha fatto fronte a 44 miliardi di euro di spese militari, in rapporto al Pil passate dal 3,2% del 2021 a ben il 34% nel 20228 (tab. 2). Prodigi delle guerre.
Tabella 2: spese militari raffronto Russia – Ucraina. Fonte: Sipri 20239
| Spese militari Russia e Ucraina | ||||||
| Stato | Spesa militare in miliardi $ 2022 | % di spesa globale 2022 | % incremento 2021-2022 | % incremento 2013-2022 | Spesa militare in % sul Pil 2021 | Spesa militare in % sul Pil 2022 |
| Russia | 86,4 | 3,9 | 9,2 | 15 | 3,7 | 4,1 |
| Ucraina | 44,0 | 2,0 | 640 | 1.661 | 3,2 | 34,0 |
| Totale | 2.240,0 | 100,0 | 3,7 | 19 | 2,2 | |
La sostanziale tenuta dell’economia di guerra russa
Decisamente diversa la situazione della Russia, la quale, nonostante l’isolamento a Occidente, le 11 tranche di misure restrittive subite nell’ultimo anno e mezzo, il sabotaggio dei gasdotti del Baltico e le ingenti spese militari, è riuscita, da un lato, a riorganizzare le relazioni geoeconomiche e geopolitiche approfondendo i rapporti con i Brics e i Paesi Emergenti e, dall’altro, a convertire parzialmente l’economia a sostegno dello sforzo bellico, riuscendo in tal modo a conseguire un nuovo assetto per la propria economia. Nello specifico, dai dati in nostro possesso, di seguito esaminati, abbiamo rilevato come, a partire da inizio 2022, i fondamentali strutturali dell’economia russa avrebbero progressivamente assunto gli inequivocabili canoni di un’economia di guerra, appurato l’aumento del budget di bilancio e delle spese militari, con queste ultime che nel 2023 stanno assorbendo circa 1/3 delle uscite pubbliche, al cospetto di quote che erano oscillate fra un minimo del 13,9% e un massimo del 23%, fra il 2011 e il e 2022.
Sulla scorta, di un recente documento di programmazione economico-finanziaria del governo di Mosca, visionato e reso pubblico dall’agenzia britannica Reuters10, apprendiamo come le spese per la difesa, di fronte all’aumento delle forniture all’Ucraina decollato da ottobre 2022, siano aumentate inevitabilmente anche in Russia. Nel primo semestre di quest’anno, infatti, la spesa totale di bilancio è risultata superiore di 2.440 miliardi di rubli (26,5 miliardi di $) rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, con il 97,1% dell’incremento destinato al settore difesa, nel cui contesto, sempre nella prima metà del 2023, ha speso il 12% in più (600 miliardi di rubli) rispetto ai 4.980 miliardi di rubli (54 miliardi di $) originariamente prefissati.
La spesa militare nel primo semestre 2023 ammonta a 5.590 miliardi di rubli (60,5 miliardi di $) pari al 37,3% della spesa pubblica totale (14.970 miliardi di rubli) e al 57,4% dello stanziamento militare prefissato per l’intero 2023.
Mosca, che a seguito dell’escalation del conflitto aveva preventivamente aumentato il budget di spesa per la difesa per il 2023 portandolo a 100 miliardi di $, nel documento visionato da Reuters (tab. 3) ha rivisto al rialzo tale capitolo di spesa elevandolo a 9.700 miliardi di rubli (105 miliardi di $), il 33,4% della spesa pubblica totale, prevista in 29.050 miliardi di rubli (313 miliardi di $).
Tabella 3: le spese di bilancio della Russia I semestre 2023 in miliardi $. Fonte dati: Governo russo
| I semestre 2023 previsioni di spesa | I semestre 2023 dati rilevati | Revisione stanziamento anno 2023 | |
| Uscite di bilancio | 135,5 | 162 | 313 |
| Spesa militare | 54,0 | 60,5 | 105 |
| % di spesa pubblica | 39,8% | 37,3% | 33,4% |
L’aumento delle spese militari a scopo bellico stanno, ormai da diversi mesi, sostenendo la ripresa dell’economia russa, dopo la recessione del 2022 (-2,1%) causata dalle sanzioni, parallelamente a quanto verificatosi negli Stati Uniti dopo la flessione del 1937-38 con l’adozione dell’economia di guerra nel 1941. Contrazione del Pil, quella del 2022, peraltro nettamente ridimensionata rispetto alla previsione di -8,5% dello stesso istituto di Washington dell’aprile dello scorso anno, la prima dall’inizio dell’escalation. La spesa militare pubblica sta alimentando l’incremento della produzione industriale, con riflessi positivi sull’andamento del Pil, previsto a luglio dal Fmi per l’anno in corso a +1,5%, in sensibile crescita rispetto allo 0,3% stimato a gennaio e lo 0,7% di aprile.
Il vice primo ministro Denis Manturov sempre a luglio ha reso noto che l’industria militare nel 2023 ha prodotto ogni mese una quantità maggiore di munizioni rispetto ai corrispondenti mesi del 2022, confermando la solidità, anche in proiezione futura, dell’apparato bellico e della capacità produttiva industriale di Mosca.
In base ai dati diramati dalla Banca Centrale russa11, Mosca avrebbe registrato il quarto trimestre consecutivo di variazione positiva del Pil e la produzione industriale rivolta alla domanda interna avrebbe superato il livello antecedente febbraio 2022, in quanto, alla domanda pubblica militare si starebbe affiancando un incremento della domanda interna indotta dall’incremento dei salari.
L’economia di guerra russa grazie alla sua capacità di adattamento e resilienza, sembrerebbe quindi evidenziare una sostanziale tenuta, anche se sussistono inevitabili elementi di criticità per un Paese in guerra e sottoposto a sanzioni.
In primis, la rimodulazione della spesa pubblica verso le produzioni militari ha comportato una riduzione dei finanziamenti per istruzione, sanità e infrastrutture civili12.
E, in secondo luogo, il previsto raddoppio delle spese militari per l’anno in corso (tab. 3) e la riduzione dei proventi dell’export (tab. 4) delle società statali, causata della contrazione delle quotazioni delle commodity energetiche del -38% a luglio 2023 rispetto al corrispondente mese del 202213, produrranno un inevitabile sensibile aumento del deficit di bilancio rispetto ai 47 miliardi di euro del 2022, visti i 39 miliardi già accumulati nei primi 4 mesi del 2023 (tab. 5).
Tabella 4: interscambio commerciale globale Russia in miliardi di € anni 2020-23.
Fonte: http://www.infomercatiesteri14
| Interscambio commerciale Russia | ||||
| 2020 Dati rilevati | 2021 Dati rilevati | 2022 Dati stimati | 2023 Previsioni | |
| Valore export totale (mld €) | 301,1 | 431 | 495,4 | 418,9 |
| Valore import totale (mld €) | 206,9 | 257 | 228,8 | 236,5 |
| Saldo bilancia commerciale (mld €) | 94,2 | 174 | 266,6 | 182,4 |
Infine, una maggiore spesa di bilancio finisce per aumentare inevitabilmente il rischio di una impennata inflazionistica, tant’è che la Banca Centrale russa in luglio aveva già portato il tasso ufficiale all’8,5%15, per poi aumentarlo ulteriormente, anche a sostegno della caduta della quotazione del Rublo, in agosto al 12%16 e in settembre al 13%17.
Tabella 5: dati bilancio Russia 2022 e primo quadrimestre 2023 in miliardi di dollari
| Bilancio Russia 2022 | Bilancio Russia gennaio-aprile 2023 | |
| Deficit di bilancio 202218 | 47 | |
| in rapporto al Pil | 2,3% | |
| Deficit di bilancio gennaio-aprile 202319 | 39 | |
| Variazione Pil Russia Fonte: Fmi | -2,1 dato definitivo | +1,5% Outlook luglio |
(*) – Andrea Vento – 25 settembre 2023
Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati
NOTE:
1https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/07/29/putin-consegne-gratis-grano-russo-a-paesi-africani-in-3-4-mesi_a5d9e53e-8042-408e-81b4-73498c0a8930.html
2 https://www.farodiroma.it/il-commercio-tra-russia-e-cina-e-aumentato-del-293/
3I 40 paesi sostenitori risultano: gli Stati dell’UE, nonché altri membri del G7 come Usa, Giappone, Australia e Canada oltre a Corea del Sud, Turchia, Norvegia, Nuova Zelanda, Svizzera, Cina, Taiwan, India e Islanda, aggiuntasi di recente
4 Secondo l’Ucraina Support Tracker del Kiel Institute, il database degli aiuti militari, finanziari e umanitari all’ucraina
https://www.ifw-kiel.de/topics/war-against-ukraine/ukraine-support-tracker
5 https://fasi.eu/it/articoli/novita/23011-strumento-europeo-pace-2021-2027.html
6 https://it.wikipedia.org/wiki/Strumento_europeo_per_la_pace
7 https://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2023/05/23/-borrell-grazie-allepf-date-a-kiev-armi-per-10-miliardi-_b6c3f74a-a4b6-4cb5-8bdf-9ec332e40a04.html
8 https://www.sipri.org/media/press-release/2023/world-military-expenditure-reaches-new-record-high-european-spending-surges
9 Fonte Sipri: https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-04/2304_fs_milex_2022.pdf
10 https://www.reuters.com/world/europe/russia-doubles-2023-defence-spending-plan-war-costs-soar-document-2023-08-04/
11 lfattoquotidiano.it/2023/08/11/governo-russo-economia-verso-i-valori-pre-invasione-nel-secondo-trimestre-crescita-del-pil-del-46/7259113/
12 https://www.reuters.com/world/europe/surge-russias-defence-security-spending-means-cuts-schools-hospitals-2023-2022-11-22/
13 Grafico 3 https://www.pricepedia.it/it/magazine/article/2023/07/31/sui-prezzi-delle-commodity-prevale-ancora-la-fase-di-calo-della-domanda-mondiale/
14 https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_paesi=88#
15 nsa.it/sito/notizie/topnews/2023/07/21/la-banca-centrale-russa-alza-il-tasso-dinteresse-all85_0db77a65-de38-4408-a033-6d3f74ebce9b.html
16 https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2023/08/15/la-banca-centrale-alza-il-tasso-di-riferimento-al-12_a0471f13-c509-4602-8447-2ff8d4818f54.html
17 https://askanews.it/2023/09/15/la-banca-centrale-russa-alza-i-tassi-dinteresse-al-13/
18 https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_10.01.2023_18.19_52610526
19 https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_17.05.2023_18.52_60710607
UN ANNO DI BUGIE SUL NORD STREAM
L’amministrazione Biden non ha riconosciuto la propria responsabilità nell’attentato al gasdotto né lo scopo del sabotaggio.

di Seymour Hersh
Non so molto delle operazioni segrete della CIA – nessun estraneo può saperlo – ma so che la componente essenziale di tutte le missioni di successo è la totale occultabilità. Gli uomini e le donne americani che si sono mossi, sotto copertura, dentro e fuori la Norvegia nei mesi necessari per pianificare e portare a termine la distruzione di tre dei quattro gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico un anno fa, non hanno lasciato alcuna traccia – nemmeno un accenno all’esistenza della squadra – se non il successo della loro missione.
La negabilità, come opzione per il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri di politica estera, era fondamentale. Nessuna informazione significativa sulla missione è stata inserita in un computer, bensì digitata su una Royal o forse su una macchina da scrivere Smith Corona con una o due copie carbone, come se Internet e il resto del mondo online non fossero ancora stati inventati. La Casa Bianca era isolata dagli avvenimenti nei pressi di Oslo; i vari rapporti e aggiornamenti dal campo venivano forniti direttamente al direttore della CIA Bill Burns, che era l’unico collegamento tra i pianificatori e il presidente, il quale autorizzò la missione il 26 settembre 2022. Una volta completata la missione, i fogli dattiloscritti e i carboni sono stati distrutti, senza lasciare alcuna traccia fisica, nessuna prova che possa essere dissotterrata in seguito da un procuratore speciale o da uno storico presidenziale. Si potrebbe definire il crimine perfetto.
C’era una falla, un divario di comprensione tra coloro che hanno portato a termine la missione e il Presidente Biden, sul perché avesse ordinato la distruzione degli oleodotti quando l’ha fatto. Il mio rapporto iniziale di 5.200 parole, pubblicato all’inizio di febbraio, si concludeva in modo criptico citando un funzionario a conoscenza della missione che mi diceva: “Era una bella storia di copertura”. Il funzionario ha aggiunto: “L’unico difetto era la decisione di farlo”.
Questo è il primo resoconto di tale difetto, nel primo anniversario delle esplosioni, e non piacerà al presidente Biden e alla sua squadra di sicurezza nazionale.
Inevitabilmente, la mia storia iniziale ha suscitato scalpore, ma i principali media hanno enfatizzato le smentite della Casa Bianca e si sono basati su un vecchio trucco – il mio affidarmi a una fonte senza nome – per unirsi all’amministrazione nello sfatare l’idea che Joe Biden potesse avere a che fare con un simile attacco. Devo notare che nella mia carriera ho vinto letteralmente decine di premi per storie pubblicate sul New York Times e sul New Yorker che si basavano su una sola fonte non nominata. Nell’ultimo anno abbiamo assistito a una serie di articoli di giornale contrari, senza fonti di prima mano, che sostenevano che un gruppo ucraino dissidente avesse compiuto l’attacco tecnico subacqueo nel Mar Baltico attraverso uno yacht di 49 piedi noleggiato chiamato Andromeda.

Sono ora in grado di scrivere sul difetto inspiegabile citato dal funzionario non nominato. Si tratta ancora una volta del classico problema di cosa sia la Central Intelligence Agency: un problema sollevato da Richard Helms, che era a capo dell’agenzia durante gli anni tumultuosi della guerra del Vietnam e dello spionaggio segreto degli americani da parte della CIA, ordinato dal presidente Lyndon Johnson e sostenuto da Richard Nixon. Nel dicembre 1974 pubblicai sul Times un articolo su quello spionaggio che portò a un’audizione senza precedenti da parte del Senato sul ruolo dell’agenzia nei tentativi falliti, autorizzati dal presidente John F. Kennedy, di assassinare Fidel Castro a Cuba. Helms disse ai senatori che la questione era se lui, come direttore della CIA, lavorasse per la Costituzione o per la Corona, nelle persone dei presidenti Johnson e Nixon. Il Comitato Church lasciò la questione irrisolta, ma Helms chiarì che lui e la sua agenzia lavoravano per l’uomo di punta della Casa Bianca.
Torniamo al gasdotto Nord Stream: È importante capire che non c’era alcun flusso di gas russo verso la Germania attraverso i gasdotti Nord Stream quando Joe Biden ha ordinato di farli esplodere lo scorso 26 settembre. Il Nord Stream 1 forniva grandi quantità di gas naturale a basso costo alla Germania dal 2011, contribuendo a rafforzare lo status della Germania come colosso manifatturiero e industriale. Ma è stato chiuso da Putin alla fine di agosto 2022, mentre la guerra in Ucraina era, nella migliore delle ipotesi, in una situazione di stallo. Il Nord Stream 2 è stato completato nel settembre 2021, ma il governo tedesco guidato dal cancelliere Olaf Scholz ha bloccato la fornitura di gas due giorni prima dell’invasione russa dell’Ucraina.
Date le vaste riserve di gas naturale e di petrolio della Russia, i presidenti americani sin da John F. Kennedy sono stati attenti alla potenziale arma di queste risorse naturali per scopi politici. Questo punto di vista rimane dominante tra Biden e i suoi consiglieri di politica estera, il Segretario di Stato Antony Blinken, il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Jake Sullivan e Victoria Nuland, ora vice di Blinken.
Sullivan ha convocato una serie di riunioni di alto livello sulla sicurezza nazionale alla fine del 2021, mentre la Russia stava accumulando le sue forze lungo il confine con l’Ucraina, con un’invasione vista come quasi inevitabile. Il gruppo, che comprendeva anche rappresentanti della CIA, è stato invitato a presentare una proposta di azione che potesse fungere da deterrente per Putin. La missione di distruzione degli oleodotti era motivata dalla determinazione della Casa Bianca a sostenere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’obiettivo di Sullivan sembrava chiaro. “La politica della Casa Bianca era quella di dissuadere la Russia da un attacco”, mi ha detto il funzionario. “La sfida lanciata alla comunità dell’intelligence è stata quella di trovare un modo abbastanza potente per raggiungere questo obiettivo e per fare una forte dichiarazione di capacità americana”.
Ora so quello che non sapevo allora: il vero motivo per cui l’amministrazione Biden “ha tirato fuori il gasdotto Nord Stream”. Il funzionario mi ha recentemente spiegato che all’epoca la Russia forniva gas e petrolio in tutto il mondo attraverso più di una dozzina di gasdotti, ma il Nord Stream 1 e 2 passava direttamente dalla Russia attraverso il Mar Baltico per arrivare in Germania. “L’amministrazione ha messo sul tavolo il Nord Stream perché era l’unico a cui potevamo accedere e sarebbe stato totalmente negabile”, ha detto il funzionario. “Abbiamo risolto il problema in poche settimane, all’inizio di gennaio, e lo abbiamo comunicato alla Casa Bianca. La nostra ipotesi era che il Presidente avrebbe usato la minaccia contro Nord Stream come deterrente per evitare la guerra”.
Non fu una sorpresa per il gruppo di pianificazione segreto dell’agenzia quando il 27 gennaio 2022, la sicura e fiduciosa Nuland, allora sottosegretario di Stato per gli Affari Politici, avvertì con fermezza Putin che se avesse invaso l’Ucraina, come chiaramente aveva intenzione di fare, “in un modo o nell’altro il Nord Stream 2 non sarebbe andato avanti”. La frase ha suscitato grande attenzione, ma non le parole che hanno preceduto la minaccia. La trascrizione ufficiale del Dipartimento di Stato mostra che la ministra ha preceduto la sua minaccia dicendo che, per quanto riguarda il gasdotto: “Continuiamo ad avere conversazioni molto forti e chiare con i nostri alleati tedeschi”.
Alla domanda di un giornalista che le chiedeva come potesse affermare con certezza che i tedeschi sarebbero stati d’accordo “perché quello che i tedeschi hanno detto pubblicamente non corrisponde a quello che state dicendo voi”, la Nuland ha risposto con una sorprendente doppiezza: “Direi di tornare indietro e leggere il documento che abbiamo firmato nel luglio [del 2021], in cui si parlava molto chiaramente delle conseguenze per l’oleodotto in caso di ulteriore aggressione all’Ucraina da parte della Russia”. Ma quell’accordo, che è stato comunicato ai giornalisti, non specificava minacce o conseguenze, secondo quanto riportato dal Times, dal Washington Post e dalla Reuters. All’epoca dell’accordo, il 21 luglio 2021, Biden disse alla stampa che, poiché l’oleodotto era stato completato al 99%, “l’idea che si potesse dire o fare qualcosa per fermarlo non era possibile”. All’epoca i repubblicani, guidati dal senatore texano Ted Cruz, dipinsero la decisione di Biden di permettere il passaggio del gas russo come una “vittoria geopolitica generazionale” per Putin e “una catastrofe” per gli Stati Uniti e i suoi alleati.
Ma due settimane dopo la dichiarazione di Nuland, il 7 febbraio 2022, in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il visitatore Scholz, Biden ha segnalato di aver cambiato idea e di essersi unito a Nuland e ad altri consiglieri di politica estera ugualmente falchi nel parlare di fermare il gasdotto. Se la Russia invade – il che significa carri armati e truppe che attraversano di nuovo … il confine dell’Ucraina”, ha detto, “non ci sarà più il Nord Stream 2. Lo fermeremo”. Metteremo fine a tutto questo”. Alla domanda su come avrebbe potuto farlo, visto che il gasdotto è sotto il controllo della Germania, ha risposto: “Lo faremo, ve lo prometto, saremo in grado di farlo”.
Scholz, alla stessa domanda, ha risposto: “Stiamo agendo insieme. Siamo assolutamente uniti e non faremo passi diversi. Faremo gli stessi passi e saranno molto difficili per la Russia, che dovrebbe capire”. Il leader tedesco era considerato, allora e oggi, da alcuni membri del team della CIA, pienamente consapevole della pianificazione segreta in corso per distruggere gli oleodotti.
A questo punto, il team della CIA aveva preso i contatti necessari in Norvegia, i cui comandi della marina e delle forze speciali hanno una lunga storia di condivisione di compiti di copertura con l’agenzia. I marinai norvegesi e le motovedette della classe Nasty hanno contribuito a far entrare clandestinamente agenti americani di sabotaggio nel Vietnam del Nord all’inizio degli anni ’60, quando l’America, sia nell’amministrazione Kennedy che in quella Johnson, stava conducendo una guerra americana non dichiarata. Con l’aiuto della Norvegia, la CIA fece il suo lavoro e trovò il modo di fare ciò che la Casa Bianca di Biden voleva fare agli oleodotti.
All’epoca, la sfida per la comunità dei servizi segreti era quella di elaborare un piano che fosse abbastanza incisivo da dissuadere Putin dall’attaccare l’Ucraina. Il funzionario mi disse: “Ce l’abbiamo fatta. Abbiamo trovato un deterrente straordinario per il suo impatto economico sulla Russia. E Putin l’ha fatto nonostante la minaccia”. Ci sono voluti mesi di ricerche e di esercitazioni nelle acque agitate del Mar Baltico da parte dei due esperti sommozzatori della Marina statunitense reclutati per la missione, prima che questa fosse ritenuta possibile. I superbi marinai norvegesi hanno trovato il punto giusto per piazzare le bombe che avrebbero fatto esplodere i gasdotti. Gli alti funzionari di Svezia e Danimarca, che continuano a ribadire di non avere idea di cosa stesse accadendo nelle loro acque territoriali condivise, hanno chiuso un occhio sulle attività degli agenti americani e norvegesi. Il team americano di sommozzatori e il personale di supporto sulla nave madre della missione, un dragamine norvegese, sarebbe stato difficile da nascondere mentre i sommozzatori svolgevano il loro lavoro. La squadra avrebbe appreso solo dopo l’esplosione che Nord Stream 2 era stato chiuso con 750 miglia di gas naturale al suo interno.
Quello che non sapevo allora, ma che mi è stato raccontato di recente, è che dopo la straordinaria minaccia pubblica di Biden di far saltare in aria Nord Stream 2, con Scholz accanto a lui, al gruppo di pianificazione della CIA fu detto dalla Casa Bianca che non ci sarebbe stato un attacco immediato ai due gasdotti, ma che il gruppo avrebbe dovuto organizzarsi per piazzare le bombe necessarie ed essere pronto a innescarle “su richiesta” – dopo l’inizio della guerra. “Fu allora che noi” – il piccolo gruppo di pianificazione che lavorava a Oslo con la Royal Norwegian Navy e i servizi speciali sul progetto – “capimmo che l’attacco agli oleodotti non era un deterrente, perché con il proseguire della guerra non ricevemmo mai il comando”.
Dopo l’ordine di Biden di innescare gli esplosivi piazzati sugli oleodotti, è bastato un breve volo con un caccia norvegese e il lancio di un dispositivo sonar modificato nel punto giusto del Mar Baltico per riuscirci. A quel punto il gruppo della CIA si era già sciolto da tempo. Anche a quel punto, mi ha detto il funzionario: “Ci siamo resi conto che la distruzione dei due gasdotti russi non era legata alla guerra ucraina” – Putin stava per annettere i quattro oblast’ ucraini che voleva – “ma faceva parte di un’agenda politica neocon per impedire a Scholz e alla Germania, con l’inverno alle porte e i gasdotti chiusi, di avere paura e di aprire” il Nord Stream 2, chiuso.
“La Casa Bianca temeva che Putin avrebbe messo sotto il suo controllo la Germania e poi avrebbe agganciato la Polonia”.
La Casa Bianca non ha detto nulla mentre il mondo si chiedeva chi avesse commesso il sabotaggio. “Così il Presidente ha sferrato un colpo all’economia della Germania e dell’Europa occidentale”, mi ha detto il funzionario. “Avrebbe potuto farlo a giugno e dire a Putin: Vi avevamo detto cosa avremmo fatto”. Il silenzio e le smentite della Casa Bianca sono stati, ha detto, “un tradimento di ciò che stavamo facendo. Se dovete farlo, fatelo quando avrebbe fatto la differenza”.
La leadership del team della CIA considerava le indicazioni fuorvianti di Biden per l’ordine di distruggere gli oleodotti, mi ha detto il funzionario, “come un passo strategico verso la Terza Guerra Mondiale”. E se la Russia avesse risposto dicendo: Voi avete fatto saltare i nostri gasdotti e io farò saltare i vostri gasdotti e i vostri cavi di comunicazione”. Nord Stream non era una questione strategica per Putin: era una questione economica. Voleva vendere gas. Aveva già perso i suoi gasdotti” quando Nord Stream I e 2 sono stati chiusi prima dell’inizio della guerra in Ucraina.
A pochi giorni dall’attentato, i funzionari di Danimarca e Svezia hanno annunciato che avrebbero condotto un’indagine. Due mesi dopo hanno riferito che c’era stata effettivamente un’esplosione e hanno detto che ci sarebbero state ulteriori indagini. Non ne è emersa nessuna. Il governo tedesco ha condotto un’inchiesta, ma ha annunciato che parti importanti delle sue scoperte sarebbero state secretate. Lo scorso inverno le autorità tedesche hanno stanziato 286 miliardi di dollari in sussidi alle grandi aziende e ai proprietari di case che hanno dovuto pagare bollette energetiche più alte per gestire le loro attività e riscaldare le loro case. L’impatto si fa sentire ancora oggi, con un inverno più freddo previsto in Europa.
Il Presidente Biden ha aspettato quattro giorni prima di definire l’attentato al gasdotto “un atto deliberato di sabotaggio”. Ha detto: “Ora i russi stanno diffondendo disinformazione al riguardo”. A Sullivan, che ha presieduto le riunioni che hanno portato alla proposta di distruggere segretamente gli oleodotti, è stato chiesto in una successiva conferenza stampa se l’amministrazione Biden “ora ritiene che la Russia sia probabilmente responsabile dell’atto di sabotaggio?”.
La risposta di Sullivan, indubbiamente pratica, è stata: “Beh, innanzitutto la Russia ha fatto quello che fa spesso quando è responsabile di qualcosa, ovvero accusare che in realtà è stato qualcun altro a farlo. Lo abbiamo visto ripetutamente nel corso del tempo”.
“Ma il presidente è stato anche chiaro oggi sul fatto che c’è ancora del lavoro da fare sulle indagini prima che il governo degli Stati Uniti sia pronto a fare un’attribuzione in questo caso”. Ha proseguito: “Continueremo a lavorare con i nostri alleati e partner per raccogliere tutti i fatti, e poi prenderemo una decisione su come procedere”.
Non ho trovato alcun caso in cui Sullivan sia stato successivamente interpellato da qualcuno della stampa americana sui risultati della sua “determinazione”. Né ho trovato alcuna prova che Sullivan, o il Presidente, siano stati interrogati da allora sui risultati della “decisione” su dove andare.
Non vi è inoltre alcuna prova che il Presidente Biden abbia richiesto alla comunità di intelligence americana di condurre un’indagine approfondita sull’attentato all’oleodotto. Tali richieste sono note come “Taskings” e vengono prese sul serio all’interno del governo.
Tutto ciò spiega perché una domanda di routine che ho posto circa un mese dopo gli attentati a una persona che ha lavorato per molti anni nella comunità dei servizi segreti americani mi ha portato a una verità che nessuno in America o in Germania sembra voler perseguire. La mia domanda era semplice: “Chi è stato?”.
L’amministrazione Biden ha fatto esplodere gli oleodotti, ma l’azione non aveva molto a che fare con la vittoria o la fine della guerra in Ucraina. È nata dal timore della Casa Bianca che la Germania potesse vacillare e attivare il flusso di gas russo – e che la Germania e poi la NATO, per ragioni economiche, cadessero sotto il giogo della Russia e delle sue vaste e poco costose risorse naturali. E così è seguita la paura finale: che l’America perdesse il suo primato di lunga data in Europa occidentale.
Traduzione: Cambiailmondo
Le migrazioni in Europa: l’unicità del caso tedesco (II° Parte)
Le migrazioni in Europa: l’unicità del caso tedesco (II° Parte)

La Germania è da oltre un secolo uno dei più grandi “paesi di immigrazione”; per lungo tempo i vari governi rifiutarono questo appellativo, impegnati come erano a considerare e a rendere congiunturali i flussi immigratori che incentivavano in corrispondenza dei cicli di crescita mentre li disincentivavano nei periodi di crisi favorendo i rientri: l’invenzione del Gastarbeiter (lavoratore ospite provvisorio) fu la sintesi letterale di questa impostazione di lunga durata.
Soltanto da circa venti anni questa politica è cambiata con l’introduzione di una legislazione progressivamente più aperta e anche in considerazione del fatto che una volta acquisite competenze e saperi alla cui formazione non si è investito direttamente e di cui si dispone liberamente, è meglio tenersele in casa: ciò costituisce un guadagno oggettivo e in un’economia sempre più fondata sulle competenze e sempre meno su braccia come appendici di macchine, questo fattore è determinante.
La nuova legislazione in corso di definizione sta puntualizzando queste acquisizioni e attraverso di essa la Germania si predispone a programmare e gestire le politiche migratorie dei prossimi decenni con l’obiettivo di stabilizzare la sua popolazione e il suo potenziale economico.
Una più approfondita conoscenza del caso tedesco ci consente di comprendere meglio le dinamiche interne all’Unione Europea. E potrebbe anche aiutare a modificare in meglio l’approccio italiano all’immigrazione, stabilmente caratterizzato da una controproducente emergenzialità.
La sottovalutazione della nuova emigrazione e l’accentuazione dell’immigrazione (solo come problema securitario) è purtroppo parte costitutiva della vicenda nazionale degli ultimi anni. Invece sarebbe auspicabile una valutazione parallela dei due fenomeni per quello che essi denotano dal punto di vista della loro genesi e per quello che possono comportare nei loro effetti, possibilmente evitando approcci ideologici.
SCARICA IL PDF dell’articolo integrale con tutte le tabelle.
Prima parte: QUI
________________
Nella Tabella 1) possiamo osservare i flussi registrati in Germania, da e per l’Italia, con relativi saldi nel periodo 1964-2021, 2000-2009 e 2010-2021. (Si veda anche la Tabella 6 in appendice che riassume comparativamente i dati dei movimenti migratori annuali dall’Italia alla Germania dal 1964 al 2014 secondo i dati Istat e secondo i dati dello Statistisches Bundesamt di Wiesbaden).
E’ qui rappresentata una parte significativa della lunga storia di emigrazione italiana verso la Germania, una sorta di dato strutturale delle relazioni economiche tra i due paesi nell’arco di quasi 60 anni, delle loro caratteristiche e delle qualità dei due modelli di capitalismo: in questo spazio di tempo, sono approdati sul suolo tedesco per viverci e lavorare per periodi più o meno lunghi, oltre 4 milioni di persone provenienti dall’Italia.
Una quantità notevole con saldi migratori di una certa consistenza. Significativo che il saldo migratorio “guadagnato” dalla Germania a spese dell’Italia soltanto negli ultimi 12 anni sia di circa 250mila persone equivalente ad una città delle dimensioni di Verona o Venezia, (una città, beninteso, fatta in massima parte di giovani, di cui circa 1/3 laureati, ecc.), mentre, nel decennio precedente il saldo migratorio era a vantaggio dell’Italia a causa dei rientri delle precedenti ondate.
I dati mostrano la sequenza delle ultime grandi fasi emigratorie del dopoguerra (che si chiudono tra gli anni ‘70 e ‘80) e, per l’ultimo periodo considerato, la sua ripresa a seguito degli effetti della crisi dei mutui sub-prime del 2007-2008 che ha innescato, in particolare dal 2010, la nuova massiccia emigrazione italiana nei primi anni del secondo decennio.1

Qui, vale però la pena comprendere meglio, al di là degli effetti della crisi e la ripresa dei flussi italiani, l’approccio politico-economico complessivo di un paese, la Germania, che dagli inizi del secolo e in particolare nel secondo decennio, ha prodotto una performance di acquisizione di risorse umane impressionante, con un saldo positivo di oltre 6 milioni di persone dal 2000 al 2021, di cui oltre 5 milioni e mezzo solo negli ultimi 12 anni; la Tabella 2) illustra i movimenti di tedeschi e stranieri nei due primi decenni del secolo, con i relativi saldi migratori:

Come si vede, nel corso del primo ventennio del secolo sono arrivati in Germania oltre 21 milioni di persone, conferendo al paese oltre 6,5 milioni di saldo immigratorio positivo; ma solo tra il 2010 e 2021 ne sono arrivati quasi 15 milioni per un saldo di oltre 5,6 milioni (cioè oltre l’86% dell’intero periodo 2010-2021). Pur in presenza di un saldo emigratorio negativo di cittadini tedeschi di una certa consistenza, il guadagno demografico è di oltre 6 milioni nel ventennio di cui oltre 5 milioni tra il 2010 e il 2021.
Nella seguente Tabella 3) possiamo invece vedere l’entità dei flussi con i relativi saldi migratori tra Germania e paesi UE-27 per i periodi indicati. Gli effetti della “libera circolazione” delle forze di lavoro in un contesto di squilibrio economico-finanziario e di forti differenziali di produttività tra paesi, sono evidenti; il fatto che quasi la metà dei saldi positivi complessivi sia stato acquisito grazie a flussi di immigrazione intra-europea (dall’ est e dal sud) e non dagli arrivi da Medio Oriente, Asia o Africa, come si è soliti pensare, è un altro dato significativo, quanto frequentemente tenuto ai margini delle riflessioni e delle indagini, probabilmente perché registra un’immagine di U.E. non del tutto auspicabile. Allo stesso tempo, la comparazione tra le tabelle 2) e 3) ci permette di vedere che l’immigrazione da paesi europei verso la Germania è pari ad oltre il 61% del totale nel periodo considerato. Ed è infine imponente il numero di coloro che sono arrivati in Germania dall’Europa nei 57 anni che vanno dal 1964 al 2021: quasi 27 milioni.

La Tabella 4) illustra invece flussi e saldi migratori tra Germania e quesi paesi E.U. che hanno devoluto almeno 100mila unità nell’ultimo decennio (in appendice, alla Tabella 5, l’elenco completo) e rende chiaro lo svolgimento delle dinamiche economiche e demografico-migratorie nell’Unione nei periodi presi in considerazione. Come si vede, nel periodo 2010-2021 l’Italia fornisce alla Germania il quarto contributo immigratorio netto dopo Romania, Polonia e Bulgaria; i maggiori flussi di arrivi per tutto il periodo 1964-2021 provengono da Polonia (paese confinante) e Italia; a seguire dalla Romania. Per tutti i paesi presi in considerazione è l’ultimo decennio quello caratterizzato da maggiori flussi e maggiori saldi immigratori positivi per la Germania, a testimonianza dell’impatto durissimo della crisi del 2008-’11 sui paesi periferici e alla loro strutturale compenetrazione (e dipendenza) dall’economia tedesca attorno a cui sembra orbitare tutta l’area est e sud europea.
Allargando lo sguardo al resto del mondo bisogna ricordare che in questo ventennio questo paese è stato il maggior accettore di emigrazione proveniente dalle aree di grandi crisi geopolitiche e di guerra: dal 2000 al 2021 la Siria ha fornito alla Germania un saldo positivo di 740.894 persone, l’Irak 252.483, l’Afghanistan 269.186; lo spazio ex-Jugoslavo 538.418, mentre lo spazio ex-sovietico nel suo complesso, inclusa la parte asiatica, ne ha fornito 1.057.920, proseguendo il trend degli imponenti arrivi di milioni di Aussiedler e Uebersiedler di origine tedesca che erano giunti dopo il 1989 da Russia, Ucraina e dalle repubbliche centro-asiatiche dell’ex Unione sovietica. 2 3
Si vedrà se questa configurazione è destinata a perpetuarsi in presenza della novità (molto negative) dello scontro Nato-Russia e alla forzata rinuncia agli approvvigionamenti energetici di gas a basso costo che erano assicurati dal Nord Stream e che sta portando alla crisi e alla chiusura di migliaia di imprese, oppure se la nuova situazione consentirà alla Germania di continuare, come programmato, nell’incentivazione di flussi di immigrazione selezionata4 alternativamente anche da territori extra-europei – in ogni caso agli stessi ritmi del decennio trascorso se si vuole mantenere più o meno stabile la popolazione residente ed integra la capacità produttiva potenziale del paese. Ma ormai le scelte non sono più solo in mani tedesche; gli effetti dell’attuale crisi si trasferiranno direttamente anche alle economie dipendenti o legate alla Germania; potrebbero anche comportare la permanenza di flussi nella stessa direzione, se permarranno, come presumibile, differenziali relativi di un certo peso; altrimenti i movimenti di persone dai paesi periferici del sud e dell’est Europa potrebbero prendere, almeno in parte, altre direzioni, in corrispondenza di quelle aree che registreranno una migliore performance rispetto alla riconfigurazione (da vedere se a blocchi conflittuali come intenderebbe la Nato o su nuovi equilibri multipolari come proposto dai Brics) delle catene del valore in cui sembra doversi ricomporre lo scenario globale.
Sarà interessante verificarlo nei dati dei prossimi anni che riguarderanno i paesi emergenti del sud America e del Medio e Estremo Oriente, oltre a quelli del nord America e dell’Australia: nello scenario di nuovi blocchi contrapposti sembra evidente che si produrrebbe un declino complessivo non solo della Germania, ma dell’intero continente, con la probabile apertura di nuove rotte emigratorie extra-europee.
TABELLA 4)

L’esempio tedesco ci dice molte cose, direttamente e indirettamente: intanto conferma l’ordine dei rapporti tra centri e periferie e la sostanziale validità delle relazioni di dipendenza che si registrano anche tra paesi sviluppati e che emergono anche dai movimenti di grandi masse di persone.
Dal punto di vista della capacità di programmazione delle politiche migratorie ci dice anche che non vi sono limiti assoluti di capacità di accoglienza e integrazione; essi sono piuttosto relativi alla dimensione economica e alla necessità/capacità di pianificazione centrale e burocratica di accoglienza e integrazione a capo di ogni sistema-paese, una funzione e una scelta eminentemente politica. Per l’Italia c’è molta materia da approfondire.
La capacità della Germania di programmare fin dalla fine del secolo scorso la quantità di ingressi che abbiamo osservato (che implicano tutta una serie di importanti misure di integrazione ad ogni livello: linguistica, scolastica, sociale, formativa e lavorativa), l’intenzione di proseguire e di perfezionare questo modello anche per i decenni a venire – come preannuncia l’approntamento di nuove leggi – confermano, se ce ne fosse bisogno, che le immigrazioni costituiscono un fattore strategico centrale per ogni paese che miri a mantenere o a conquistare una sovranità sul proprio futuro e a non cadere nella spirale della riduzione di popolazione con ciò che ne consegue.
Le attuali dinamiche demografiche e l’ingresso in un imbuto di crisi sovrapposte a diversi livelli suggeriscono l’opportunità che questa ricerca di futuro con cui ogni paese è costretto a confrontarsi sia misurata e negoziata con chi ci sta intorno, cioè cooperativa. E che non dovrebbe essere devoluta a soggetti esterni. Vi sono scelte e responsabilità da esercitare, cambiamenti strutturali da operare a partire dall’orientamento della spesa pubblica e dell’acquisizione delle risorse necessarie (per contenere l’emigrazione e incentivare l’immigrazione), quindi del sistema fiscale e di tassazione: se l’investimento sulle persone è strategico c’è bisogno di una rivoluzione nel modo di pensare il reperimento e l’allocazione delle risorse. E anche di un altro modello di impresa privata che condivida prospettive che riguardano l’intera società non la massimizzazione del profitto a breve termine. L’orientamento dogmatico all’export dei sistemi produttivi, ad esempio, andrebbe mitigato e conciliato con la necessità di crescita del mercato interno, cosa che costituisce tra l’altro un’opportunità anticiclica nelle fasi più turbolente.
Allo stesso tempo, rispetto al contesto comunitario, si imporrebbe una riconsiderazione delle politiche di coesione territoriale: una UE in balia dei liberi movimenti di capitale con annessa piena devoluzione al mercato della sua capacità di programmazione non sembra avere futuro.
Rodolfo Ricci (Fiei), Agosto 2023
NOTE:
1 – Gli Italiani in Germania: ancora un Reservarmee per il mercato del lavoro tedesco? (Edith Pichler) – URL: https://www.neodemos.info/2017/07/11/gli-italiani-in-germania-ancora-un-reservarmee-per-il-mercato-del-lavoro-tedesco/
2 – Sulle conseguenze demografiche nei paesi dell’est Europa e dei Balcani dei flussi emigratori post 1989 si rimanda all’importante Dossier “Uno sconvolgimento demografico in Europa” – Le Monde diplomatique/Il Manifesto del 18 giugno 2018, pp. 11-16 – (Philippe Descamps, Jean-Arnault Dérens e Laurent Geslin, Corentin Léotard e Ludovic Lepeltier-Kutasi, Rachel Knabel, Claude Aubert)
3 – I dati qui forniti sono nostre rielaborazioni delle serie storiche 2000-2021 dello Statistisches Bundesamt di Wiesbaden (Destatis) acquisiti nel maggio 2023 (Vedi Tabella 8 in Appendice).
4 – La Germania vuole diventare attrattiva. La nuova legge sulla immigrazione e il disegno di legge sulla cittadinanza (Edith Pichler) – URL: https://www.neodemos.info/2023/06/23/la-germania-vuole-diventare-attrattiva-la-nuova-legge-sulla-immigrazione-e-il-disegno-di-legge-sulla-cittadinanza/
FONTE: https://fiei.it/?p=802






