di Giovanni Rota e Andrea Vento
Da alcune settimane, l’Iran attraversa una fase di profonda instabilità politica e sociale. A Teheran, cuore amministrativo ed economico del Paese, le tensioni esplose tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 hanno assunto rapidamente la forma di una mobilitazione diffusa, che va ben oltre la contingenza della crisi economica scatenata dalle sanzioni imposte a più riprese dall’Occidente e mai revocate, nonostante l’Accordo sul nucleare con gli Stati Uniti del 2015 (JCPOA) lo prevedesse. L’aumento vertiginoso dei prezzi, il crollo del potere d’acquisto e la disoccupazione hanno acceso la miccia, ma ciò che è emerso nelle piazze è anche una contestazione del sistema di potere della Repubblica islamica.
Scioperi, proteste studentesche e manifestazioni spontanee hanno coinvolto settori sociali diversi: partendo dai commercianti del bazar di Teheran si sono rapidamente estesi a lavoratori, giovani, precari, donne. Questi gruppi si sono ritrovati uniti contro un modello politico che combina autoritarismo religioso, concentrazione del potere economico e repressione sistematica del dissenso. Le richieste non si limitano più a correttivi economici, ma chiamano in causa libertà civili, diritti politici e fine dell’apparato repressivo.
La risposta dello Stato è stata immediata e brutale. Arresti di massa, uso della forza letale, processi sommari e blackout informativi hanno accompagnato le mobilitazioni. Il controllo delle comunicazioni e la criminalizzazione dei manifestanti come agenti stranieri rientrano in una strategia consolidata di gestione autoritaria del conflitto sociale. Ciò non toglie che vi sia una effettiva presenza di infiltrati stranieri nel paese, in primis del Mossad, a scopo destabilizzante, come hanno ammesso più voci all’interno dello stesso Israele.
Quanto sta accadendo a Teheran non è un episodio isolato né una semplice crisi economica: è l’espressione di un conflitto profondo tra una società giovane, impoverita e repressa e un sistema di potere incapace di riformarsi. La repressione può rallentare il cambiamento, ma non elimina le cause strutturali della protesta. Finché disuguaglianze, autoritarismo e negazione dei diritti resteranno l’architrave dello Stato, la frattura di classe tra il regime e l’oligarchia e la popolazione continuerà ad allargarsi.
La situazione si presenta molto critica anche sul piano internazionale, in quanto l’Iran deve fronteggiare le mire egemoniche israeliane sul Medio Oriente, le minacce di un nuovo intervento militare da parte statunitense, dopo quello di giugno scorso, e le tensioni diplomatiche con l’Europa che lo stanno mettendo in una sorta di angolo diplomatico dal quale non sarà agevole svincolarsi.
L’utilizzo da parte degli Stati Uniti della retorica della violazione dei diritti umani e della repressione risulta, tuttavia, del tutto strumentale in quanto Trump non ha tanto a cuore le sorti del popolo iraniano, quanto miri piuttosto ad eliminare un governo ostile, che rappresenta l’ultimo baluardo alle politiche espansionistiche di Tel Aviv, ed a accaparrarsi le risorse petrolifere del paese, le terze a livello mondiale, tramutandole in asset a sostegno del decadente potere valutario globale del dollaro.
Trump ha schierato una potente flotta navale guidata dalla portaerei Lincoln nel Mar Arabico minacciando un intervento, ma la tattica del tycoon sembra essere quella di esercitare forti pressioni tramite la minaccia militare per aprire una trattativa diplomatica, opportunità che peraltro Teheran ha subito colto. Giovedì 6 in Oman è infatti previsto un importante incontro negoziale fra le due parti che potrebbe sbloccare l’impasse.
Hanno espresso contrarietà all’intervento militare Usa, per il quale sta invece spingendo Israele, tutti i suoi alleati in Medio Oriente dalla Turchia alle Monarchie del Golfo, fino al fedele alleato giordano che ha persino negato lo spazio aereo a tal fine, in quanto contrari ad ulteriore escalation bellico che potrebbe destabilizzare l’intero scacchiere mediorientale, soprattutto in caso di caduta del regime guidato da Khamenei. L’opzione di un regime change con la cooptazione di Mohammad Reza Pahlavi al potere a Teheran, benché ventilata in alcuni ambienti occidentali, sembrerebbe alquanto impraticabile vista la netta opposizione interna al paese che ha sollevato.
La gattopardesca operazione occidentale di riportare al potere il rampollo della dinastia Pahlavi, costituirebbe un insulto inaccettabile da rispedire al mittente per i milioni di iraniani che, dopo aver cacciato il padre nel 1979 e aver sostenuto molteplici cicli di lotte contro il regime degli Ayatollah, oggi respingono con forza il solo pensiero di ritrovarsi il figlio dell’ultimo Shah a capo di una nuova monarchia corrotta e reazionaria.
Per l’Occidente l’era dei sepolcri imbiancati sembra non passare mai di moda.
Giovanni Rota
Andrea Vento
4 febbraio 2026





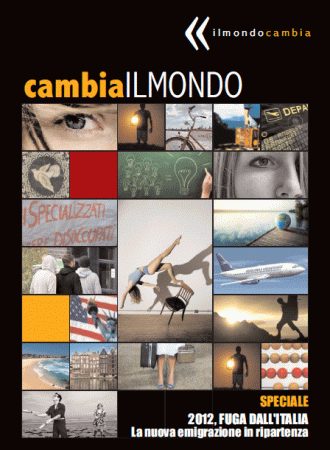










Lascia un commento