di Pier Giorgio Ardeni (Il Ponte 6/1/2026)
L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela, il rapimento del presidente Nicolas Maduro e della moglie sono atti di una gravità inaudita. Uno Stato sovrano violato impunemente, per sequestrarne il presidente e portarlo di fronte alla giustizia a difendersi dalle accuse di organizzare il narcotraffico, questa la motivazione ufficiale, con un’azione di puro gangsterismo. Con l’aggravante, come ha ammesso lo stesso Trump, di puntare in realtà a gestire le risorse petrolifere del paese e «guidarlo verso una transizione giudiziosa». Insomma, qualcosa che dovrebbe essere considerato inaccettabile: rapire il capo di Stato di un paese il cui regime è inviso per poi controllarlo e governarlo, come era già accaduto con l’Iraq di Saddam Hussein e la Libia di Muammar Gheddafi. Con la differenza che, in quei casi, si cercò, a giustificazione dell’intervento, quantomeno l’approvazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. No, in questo caso gli Stati Uniti hanno agito unilateralmente e sfrontatamente in un atto di guerra per il quale il presidente Trump non ha neppure richiesto l’autorizzazione del Congresso, come stabilito dalla legge. Il che pone gli USA in cima alla lista di quegli Stati “canaglia” che essi stessi avevano stilato all’indomani dell’attacco alle torri gemelle nel 2001.
Di fronte a questo, si pongono due questioni. La prima è capire il perché di tale inusitata iniziativa. Quale minaccia poneva il Venezuela? Perché gli USA sono intervenuti per decapitarne il potere e prendere la guida del paese (e ancora non è chiaro come)? La seconda è: come dobbiamo reagire? Quali prospettive politiche si aprono? L’aggressione al Venezuela ha squarciato un velo: il leone imperialista ha dato una zampata per uscire da quella che percepisce come un’agonia e vuole riprendersi il controllo del mondo sul quale la sua supremazia sembrava indiscussa. E il mondo non ha che da temere e deve pertanto reagire cercando il modo migliore per non cadere in una spirale di violenza e disordine senza fine.
Il declino americano
È già stato sottolineato – per esempio da Alessandro Volpi – che l’aggressione al Venezuela sarebbe la «palmare dimostrazione della profonda crisi degli USA che sono schiacciati da un debito federale fuori controllo, da un debito privato non più sostenibile per la popolazione americana, da una radicale deindustrializzazione, messa a nudo dalla concorrenza cinese, da una inflazione pronta a esplodere per i dazi e se Trump ordinerà alla FED una riduzione dei tassi e da una gigantesca bolla finanziaria ormai al limite». Di fronte a questo stato di cose, «Trump ha scelto la soluzione della guerra aggredendo un paese ricchissimo di risorse, per rianimare l’economia interna e proteggere la bolla finanziaria». «Per un’economia in crisi – afferma Volpi – la guerra è, agli occhi di Trump, la soluzione migliore e la legittimazione che ha ricevuto dalle servili élites europee, a cominciare dal governo Meloni, sembra dargli, drammaticamente, ragione».
Certo, se ha ragione Zizek a dire di Trump che «he does business as war and war as business», è anche vero che «lo sceriffo della nuova America» (cit. J.D. Vance) ha comunque agito secondo una logica in cui le ragioni di breve periodo – come il ruolo del dollaro e l’insostenibilità del debito USA (cfr. anche Rogoff su «Foreign Affairs») – si sommerebbero a quelle più strutturali, come la perdita della supremazia economica mondiale ma, soprattutto, una sempre maggiore debolezza dell’economia, causata dalla de-industrializzazione e dal livello dei consumi, esacerbato dalle disuguaglianze crescenti. Oltre, naturalmente, alla sua personale megalomania “imperiale”. Se queste ragioni giustificherebbero l’azione gangsteristica, cerchiamo di capire dunque quanto di vero ci possa essere.
Il PIL degli Stati Uniti, se valutato a parità di potere d’acquisto, rappresenta oggi solo il 14,65% di quello mondiale, superato da quello cinese che ormai si avvicina al 20%, mentre il PIL della UE è appena al 14%. Il “sorpasso”, secondo i dati IMF-WB, è avvenuto nel 2016 e da allora la quota cinese non ha fatto che crescere, mentre quella USA e UE è sempre calata (nel 1980, la quota UE era il 27,5%, quella USA il 21,6% e quella cinese appena il 2,1%). La primazia americana, in altre parole, è ormai superata e in declino da molto tempo.
Certo, il Pil pro capite americano è di 89.600 dollari, quello europeo quasi la metà (46.800 dollari, a parità di potere d’acquisto) e quello cinese solo di 13.810 dollari. Ma nel paese le disuguaglianze di reddito sono enormi, molto maggiori che in molte altre nazioni. Negli USA, infatti, i divari di reddito sono tali che il reddito medio dell’1% più ricco è di oltre 1,3 milioni di dollari, mentre il 99% più povero ha una media di circa 50.000 dollari, una differenza di 26 volte. L’indice di Gini per gli Stati Uniti è pari a 0,42, contro lo 0,36 della Cina e lo 0,294 della media UE.
Gli Stati Uniti sono il maggiore importatore del mondo, con un volume di importazioni pari a più di 4.000 miliardi di dollari (dati 2024) e un volume di esportazioni di 3.192 miliardi. Gli Stati Uniti sono importatori netti sia globalmente che nei confronti dei principali partner, con l’eccezione del Canada (primo mercato per i beni e servizi prodotti negli USA). L’industria manifatturiera USA resta la seconda del mondo dopo la Cina, con il 17% del totale mondiale, dietro al 30% cinese e davanti al 5% di Giappone e Germania. La produzione statunitense, tuttavia, è andata crescendo negli ultimi anni nei settori ad alta tecnologia e alto valore aggiunto, perdendo colpi nei settori delle produzioni di massa. La de-industrializzazione ha avuto effetti non solo sull’output complessivo ma ha colpito soprattutto l’occupazione, ora scesa a 27 milioni di addetti nella manifattura e nelle costruzioni (meno di un quinto degli occupati totali). La quota degli occupati nell’industria era vicina al 28% nel 1951 e da allora è andata costantemente diminuendo, soprattutto nel nuovo secolo, fino al livello attuale appena superiore al 12%. Nell’ultimo decennio, in particolare, l’industria ha perso quasi 750.000 addetti (compensata, in parte, dalla tenuta del settore edile).
Il crollo dell’industria, tuttavia, è avvenuto in concomitanza con l’aumento dell’import di prodotti della manifattura dalla Cina, più economici, ma soprattutto in ragione dell’aumento dei settori finanziari, dei servizi e dell’high-tech, ove ha trovato sbocco la maggiore crescita dell’occupazione (gli occupati totali sono oggi 164 milioni, erano 149 nel 2006).
Se anche la crescita dell’economia USA nell’ultimo decennio è stata comunque sostenuta, tra il 2,5 e il 3% – spinta dai consumi delle fasce più affluenti della società americana –, essa è stata inferiore a quella cinese (attorno al 7,5% medio) e superiore a quella della UE (tra l’1,6 il 2,8%). Oggi la Cina è leader mondiale nel settore manifatturiero (in particolare elettronica, macchinari, veicoli elettrici), dominando le catene di fornitura globali, mentre il suo settore dei servizi (tecnologia, finanza, vendita al dettaglio online) ne spinge il PIL, grazie anche ai contributi dell’agricoltura (pollame, colture) e ai punti di forza emergenti nell’intelligenza artificiale, nell’economia digitale e nella tecnologia verde avanzata (batterie), rendendola la forza dominante sia nei servizi industriali in uscita che in quelli digitali. Gli USA, dal canto loro, sono ancora una forza dominante nel digitale, nell’energia (in petrolio e gas oggi i maggiori produttori mondiali), nei prodotti farmaceutici e sanitari e, soprattutto, nella finanza.
La loro influenza globale, tuttavia, è andata ridimensionandosi negli ultimi anni e la Cina viene vista come una potenza crescente e minacciosa. In molti settori, la dipendenza americana dai cinesi è divenuta cruciale, in particolare per i beni di largo consumo, i prodotti farmaceutici (principi attivi) e i minerali essenziali (terre rare) per la tecnologia e la difesa, mentre oltre il 90% dei prodotti statunitensi contiene componenti cinesi.
Il declino americano come potenza economica è, in sostanza, relativo. È l’esposizione finanziaria che preoccupa, per gli effetti che questa può avere, mentre la de-industrializzazione appare temibile più per ragioni sociali interne (di scarsa importanza, in effetti, per Trump) e per ragioni strategiche. Gli USA sono comunque un player ancora fondamentale nell’economia globale, ma è la perdita della supremazia e del controllo assoluto sui mercati e sulle catene di fornitura che li innervosisce. In quest’ottica, mentre Africa e Asia sono quasi date “per perse” nella conquista di una dominanza economica strategica, l’America latina è vista come un bacino che non deve assolutamente cadere sotto l’influenza cinese (o russa). Nel sub-continente oggi sono cresciuti paesi come Brasile e Messico che non sono più trattabili con supponenza. Il Venezuela è partner importante per la Cina nel petrolio e il controllo delle sue riserve, quindi, rientra in quest’ottica: prendere la Cina, il maggior compratore di petrolio al mondo, “per la gola” e metterla in difficoltà.
Il declino americano – da unica superpotenza di riferimento a primus inter pares – nasconde quindi la volontà di poter disporre delle risorse del mondo come si è sempre fatto, da vero impero “centro del mondo”. Un gigante con i piedi d’argilla, però, un paese sempre più diviso e dilaniato, segnato da divisioni di classe e condizione che hanno radici profonde.
Un paese malato
Gli Stati Uniti sono il paese al mondo con il più alto numero di morti per droga, per arma da fuoco e per incidenti stradali, giusto per selezionare alcuni indicatori, oltre ad avere un’alta mortalità infantile e un’età media più bassa di paesi simili a economia avanzata. 110.000 morti all’anno per droga – una vera e propria epidemia da oppiacei – ovvero 31,2 morti per 100.000 abitanti, contro una media europea di appena 2,5, di cui 19,1 in Scozia, il più alto. Negli USA ben 13,7 persone ogni 100.000 abitanti muoiono per un colpo d’arma da fuoco (più della metà per suicidio). Nel 2023, i morti sono stati quasi 47.000, contro i 6.500 in tutta la UE (meno di 1 ogni centomila abitanti, il 75% dei quali per suicidio). I morti a causa di un incidente stradale sono stati 41.000, 12,2 morti ogni 100.000 abitanti, contro i 20.000 in Europa, cioè 4,5 morti per 100.000 abitanti (e i 7,8 della Romania, il paese con più vittime). Sono questi tre indicatori di malessere e di mal vivere che si commentano da soli.
Il tasso di mortalità complessivo in Europa, peraltro, se si escludono gli anni della pandemia, è passato dai 10,4 morti per mille abitanti del 2019 ai 10,8 del 2023. Negli USA, è pari a 9,2 morti per mille abitanti. Il tasso di mortalità infantile, invece, è di 5,6 morti per mille neonati vivi, contro i 3,3 della UE. L’aspettativa di vita alla nascita negli USA è di 78,4 anni (75,4 per gli uomini, 81,1 per le donne, dati 2023). In Europa, ha raggiunto gli 81,4 anni (78,7 per gli uomini, 84 per le donne), con variazioni che vanno dai 75,8 della Bulgaria, 75,9 della Lettonia e 76,6 della Romania agli 83,8 dell’Italia e 84 della Spagna.
Un paese malato, che soffre di patologie sociali e individuali profonde, le cui cause sono, ovviamente, anche economiche. Negli Stati Uniti 37 milioni di persone – l’11% della popolazione – vivono sotto la soglia di povertà (dati 2023, nel 2024 la quota è scesa al 10,6%). In Europa, secondo Eurostat, la media nel 2023 è stata del 6,8%, con variazioni che vanno dal 24,3% di Romania e Grecia all’1,4% della Slovenia.
È chiaro che la condizione di povertà dipende largamente dalla demografia e dalle caratteristiche socio-economiche: è più alta per neri e ispanici, giovani e persone con bassi livelli di istruzione ed è tipica anche di molte persone che lavorano in occupazioni a bassa remunerazione. In Europa, come negli USA, varia fortemente da regione a regione. Tanto maggiore è la prevalenza delle condizioni di povertà ed esclusione, tanto maggiore è la propensione alla criminalità, all’uso di droghe, alla violenza. E negli USA, a differenza della maggioranza delle città europee, vi sono zone off-limits, di segregazione ed esclusione, opposte alle gated communities dei ricchi.
Il paradiso del capitalismo
Il paradiso del capitalismo? Sì, quello selvaggio. Negli Stati Uniti un’élite sempre più ricca si è giovata della finanza, poggiandosi su quei pochi giganti dell’high tech (il cui aumento vertiginoso dei capitali però rischia di essere una bolla). Il paradiso, sì, ma di un capitalismo oligarchico, che ha mandato in fumo il “sogno americano”, con la compressione della middle class e lo schiacciamento della working class. Nei cinquant’anni tra il 1970 e il 2020, il reddito della classe media è cresciuto del 50% in termini reali, quello delle classi ricche del 70% mentre quello della working class appena del 49% (Pew Research Center). Oggi, il 50% delle famiglie appartiene alla middle class (erano il 61%), laddove il 21% si trova nella classe superiore (erano il 14%). I ricchi oggi detengono metà del reddito nazionale (ne avevano il 29% mezzo secolo prima).
Nel 2024, il coefficiente di Gini calcolato sul reddito disponibile era negli Stati Uniti intorno allo 0,48 (un’alta disuguaglianza), con il quinto più ricco con più del 52% del reddito totale e il quinto più povero con solo il 3,1%. Nell’Europa capitalista, invece, l’indice di Gini segna valori decisamente più bassi e una media attorno a 0,294, con una distribuzione del reddito più uniforme in paesi come Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia e Belgio (sotto 0,25), rispetto a Bulgaria (0,384), Lituania (0,353) e Lettonia (0,342) e anche Italia (0,322), dove le regioni Campania, Calabria e Sicilia hanno un indice superiore a 0,353, tra i più alti in Europa (in UK, l’indice è pari a 0,329).
Le élites economiche, in ogni caso, hanno da tempo guadagnato un’influenza sulle politiche dai tempi di Reagan che non ha eguali negli altri paesi. La patria del neoliberismo ha visto il trionfo delle liberalizzazioni, delle privatizzazioni e della de-regolamentazione – tanto sotto i Democratici che con i Repubblicani – che con Trump ha conosciuto una curvatura che ha dato luogo a un capitalismo oligarchico in cui i padroni della “grande finanza” dei fondi e dell’high-tech si sono definitivamente “comprati” lo Stato (si vedano, tra gli altri, gli ultimi due libri di A. Volpi).
Le disuguaglianze crescenti, maggiori che in Europa, hanno comunque dato linfa al populismo trumpiano, già dal 2016, conquistando fasce crescenti di blue e white-collar workers della middle ma anche della lower class con le promesse della re-industrializzazione e dell’isolazionismo. Ed è per questo che la combinazione tra il turbo-capitalismo finanziario e il populismo suprematista appaiono come due facce della stessa medaglia. Trump e la sua cricca vogliono far tornare l’America prima tanto nella produzione di ricchezza e beni per il largo consumo, potenzialmente stimolando anche l’occupazione, a spese degli altri paesi (che spiega il perché delle guerre dei dazi).
La logica militare
In questo quadro, la stessa espansione militare rientra non solo nella logica di superpotenza ma in quella economica, ai fini di garantire la supremazia globale. Negli ultimi quarant’anni, la spesa per armamenti statunitense ha avuto un aumento costante, particolarmente dopo l’11 settembre 2001 e negli anni 2010-11, raggiungendo nel 2024 i mille miliardi di dollari. Gli Stati Uniti spendono da soli più del 40% del totale mondiale (dati SIPRI) e più di quanto spendono i primi nove paesi in graduatoria. La Cina, il secondo paese per ammontare, spende oggi meno di un terzo degli USA, il 2% del PIL (contro il 3,8% degli Stati Uniti).
Nessun paese si avvicina, neanche lontanamente, a quanto devolvono gli Stati Uniti agli armamenti. La spesa russa non raggiunge i 150 miliardi di dollari, il 7% del PIL (un esborso notevole, per finanziare la guerra in Ucraina, che però mostra anche la dimensione relativa della spesa della Russia). L’Europa, a sua volta, destina alla spesa militare ben 450 miliardi di dollari, tre volte tanto la Russia.
L’allargamento della NATO, voluto dagli Stati Uniti e accomodato dai paesi europei, è stato funzionale alla logica di superpotenza degli USA. La spesa militare dei paesi NATO ha oggi raggiunto i 1.500 miliardi di dollari. E oggi appare chiaro come l’ampliamento della NATO, anche dopo il 2004, sia stato concepito in chiave antirussa, con l’idea di portare quel paese a implodere. La Russia ha retto, certo, il suo PIL è cresciuto a un tasso del 7% medio annuo, grazie ai proventi di petrolio e gas e anche se oggi l’esborso per la spesa militare appare sostenuto, essa sembra ben lontana da quella dissoluzione che si auspicava. E oggi, quella potenza e quella supremazia che la sola economia non basta più a imporre, gli USA paiono volersela conquistare con le armi: indirettamente, finanziando Israele per dominare il Medio Oriente e direttamente, come stanno facendo in Venezuela e minacciano di fare in tutto il continente americano.
Nuovi imperialismi e multipolarità
Che l’aggressione al Venezuela e il sequestro del suo presidente e della first lady siano un atto di imperialismo è evidente. Si potrà anche valutare l’effetto di un “regime change”, ma è chiaro che non è accettabile che questo possa avvenire sotto il controllo militare di un altro paese, in queste condizioni. L’azione di Trump è all’insegna della legge della giungla, dell’imposizione con la forza di un cambiamento istituzionale che è contro ogni accettata prassi internazionale. Che poi tutto questo avvenga con l’obiettivo dichiarato di “guidare” il paese e rimettere in piedi la sua industria petrolifera aprendo alle compagnie americane appare disgustosamente inaccettabile. Trump vuole riappropriarsi delle risorse di un paese non tanto per guadagnarci, quanto per togliere alla Cina un fornitore importante.
Ora, in un certo senso gli Stati Uniti hanno sempre avuto attitudini “imperialiste” e la dottrina Monroe ne è certamente un esempio. In passato, operavano più in segreto, fomentando colpi di Stato e foraggiando milizie. Dopo la fine della guerra fredda, quando si sono sentiti investiti del ruolo di “poliziotto del mondo” per abbattere dittature ed esportare democrazia (ci andrebbero sempre le virgolette, quanto le argomentazioni erano costruite ad arte), sono intervenuti sempre e pesantemente, cercando però un imprimatur, un assenso dell’ONU, costruendo alleanze allo scopo. Ciò che risalta ora è l’assoluta arbitrarietà, la decisione di procedere da soli, senza alcun consenso internazionale neppure di facciata. Non c’è nessuna fiducia né riconoscimento nei confronti dell’ONU, nessun interesse a giustificare azioni che sono tanto temerarie quanto prepotenti. Non è solo Trump che fa lo sceriffo: è una cerchia, rappresentativa di un’oligarchia, che concepisce il mondo in modo “medievale”, dove quello che conta è la forza brutale e la potenza.
È questa non solo una logica imperialistica pura, ma essa è talmente viziata da un gangsterismo di fondo che ci porta a una domanda. Possiamo davvero continuare a pensare a Trump come a un alleato? Gli USA sono oggi uno Stato canaglia, tanto e più di quanto lo erano quelli che essi dipingevano come tali. Agiscono indisturbati, di fatto disconoscendo l’ONU e qualunque possibile consesso internazionale in cui motivare e giustificare le proprie azioni. Certo, le alleanze sono tra paesi, indipendentemente da chi li governa, ma i segnali non sono incoraggianti e andrebbero presi sul serio. La NATO, per metà della sua esistenza, è stato lo strumento per gli USA per garantire che l’Europa rientrasse nella sua area di influenza, contro l’Unione Sovietica. Dissolta l’URSS, la NATO si è nel tempo trasformata in uno strumento di pressione contro la Russia, per provocarne l’indebolimento e l’eventuale sparizione (una mira allettante, essendo questa una potenza nucleare). Le cose, però, non sono andate come si auspicava nei quartieri generali della NATO. La Russia ha reagito, più per proteggere e controllare le aree che riteneva vicine – abitate da popolazioni russe o russofone – che per una sua volontà imperialistica (chi si diletta oggi con questo argomento, solo perché anche in Russia governa un’oligarchia sotto l’autocrate Putin non riesce a dimostrare la validità di questo argomento).
Trump e la sua cricca non hanno in mente l’accettazione del mondo multipolare che si andava delineando già da prima della pandemia. La Cina, l’India, l’Indonesia e finanche il Brasile sono oggi potenze economiche emergenti, che si dividono e conquistano mercati. La Russia, che aveva nei paesi UE i suoi principali partner commerciali, ha trovato modo di diversificare. L’Unione Europea stessa è un concorrente, più che un alleato, ed è militarmente vassalla, così va trattata. E Trump, nella logica imperiale che lo guida, vuole oggi immaginare un mondo suddiviso tra tre “imperi”, gli USA, la Russia e la Cina. Con la differenza che la Cina non ha queste ambizioni imperialistiche (cfr. Sylos Labini), oltre a quelle di un primato economico e tecnologico in cui si relaziona con una pletora di paesi nel mondo.
Che l’Europa possa accettare tutto questo appare finanche incredibile. Neppure l’Europa della Merkel, per non dire di quella di Delors o di Prodi, avrebbe mai anche solo preteso di considerare come possibile un’azione come quella di Trump. I tempi sono cambiati, perché è l’economia che è cambiata, oltre a essere cambiata la politica e i suoi leader. I neo-con, dopo aver mantenuto il potere per anni, sono stati superati da sovranisti, destre estreme e tecno-populisti. Ma è il capitalismo del nuovo neoliberismo che si è liberato dallo Stato, controllandolo, “comprandoselo”, che oggi prevale. Pochi fronzoli democratici e di rispetto del diritto internazionale: ciò che conta è stabilire l’ordine che oggi conviene ai forti, ai dominatori. Nemmeno il più stolto oggi può dire che a nessuno interessi la democrazia in Venezuela (o in qualunque altro posto). I venezuelani, se qualcosa avevano ottenuto dal regime di Chavez o di Maduro, era un miglioramento delle loro condizioni di vita. Ora potrà tornare ad essere, se gli USA lo consentiranno senza mandare i loro soldati con «gli scarponi sul terreno», una repubblica delle banane in mano alle big oil companies yankee.
Le reazioni in Europa all’azione piratesca di Trump sono state pietose e spregevoli. Non solo si sorvola sulla palese violazione di ogni diritto, di ogni legge di convivenza, ma si discute – sui media e tra politici e commentatori – sull’opportunità di un cambiamento di regime in Venezuela come se nulla fosse, indipendentemente da come ci si è arrivati. Tuttavia, se il principale partner dell’alleanza di cui facciamo parte così si comporta, una qualche riflessione dovremmo farla.
La prima, ovviamente, si riferisce non solo al fatto di esigere spiegazioni: può un atto di pirateria internazionale restare impunito? Come può un partner affidabile muoversi al di sopra della legge senza che nessuno lo critichi, lo giudichi? L’appartenenza alla NATO giustifica una nostra accettazione? Ovviamente no. Ed è per questo che dovremmo, ora, rovesciare il tavolo: dell’Alleanza NATO – come fidarsi di un alleato così? – e della UE così com’è oggi. Le destre e i liberal di casa nostra addirittura plaudono e considerano legittimo l’intervento USA. Non osiamo immaginare cosa faranno ora che Trump minaccia Messico, Cuba e Colombia e finanche la Groenlandia.
In realtà, la reazione alla violenta azione trumpiana mette in evidenza una linea di frattura che potrebbe rivelarsi proficua per il futuro per i progressisti pacifisti e globalisti. Agli “americanisti” che accettano questo nuovo stato di cose – il cui possibile prospetto è solo il caos globale – governato da un’America nuovamente al centro dell’impero, temibile e minacciosa, dovremmo iniziare a contrapporre il “multipolarismo” di chi vede l’Europa nel ruolo di ponte, all’insegna della pace, della neutralità e della diplomazia. Arrivare a negoziare con la Russia una convivenza non belligerante potrebbe essere un passo, sottraendosi alla logica di potenza di Trump (e anche di Putin, se ve n’è una), garantendosi il disimpegno attento dagli Usa che lo stesso Trump occhieggia. Lo stesso, potrebbe essere certificato con la Cina.
È chiaro, però, che tutto questo potrà avvenire solo se vi sono cambiamenti più radicali nelle nostre politiche e nelle tendenze di fondo. Anche in Europa, negli ultimi anni, si è affermato un capitalismo delle élites oligarchiche che governano l’economia e le istituzioni. I partiti della cosiddetta sinistra si sono allontanati dai ceti popolari, cui dovrebbero invece tornare a guardare per rimetterli in gioco, ridare loro fiducia nella democrazia e non lasciarsi conquistare dalle illusioni populiste sovraniste. Per rilanciare l’idea di un reale progresso economico per le genti e gli strati meno abbienti è necessario un cambio di paradigma.
La nefasta congiuntura attuale si presta. Un fronte progressista pacifista, anti-trumpiano (e anti-Netanyahu), anti-imperialista e contro il capitalismo delle oligarchie. Rifiutiamo il Far West per rilanciare il multipolarismo e quel capitalismo “ben temperato” che era stato possibile immaginare in altra epoca ma a cui abbiamo rinunciato.





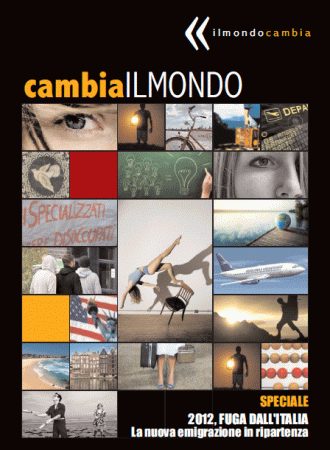












Lascia un commento