I dazi sono un antico sistema di finanziamento delle casse pubbliche di uno stato a spese di altri stati (in modo anche da contenere il livello di tassazione interno).
In regime capitalista e in presenza di un mercato ampio e tendenzialmente globale, i dazi sono stati utilizzati sempre dalle economie più deboli per difendersi da quelle più forti, ovvero da paesi che intendevano tenere a bada o affossare particolari settori di altre economie concorrenziali o in crescita.
L’esempio dell’Inghilterra coloniale rispetto all’India è particolarmente istruttivo: in presenza di una industria tessile molto sviluppata per i tempi nel grande paese asiatico, l’Inghilterra sbarrò la via alle produzioni indiane con politiche protezioniste e dazi fintanto che il telaio meccanico prese piede, costringendola poi a fornire esclusivamente materie prime e ad aprirsi allo stesso tempo senza barriere ai suoi beni finiti; invocando cioè il primato del libero scambio alle colonie (e agli altri paesi), mentre fino a metà ‘800 era stata rigidamente protezionista.
Si è dunque trattato di uno strumento anche geopolitico in mano alle rispettive borghesie nazionali ai fini di aggressione esterna o a difesa interna degli apparati produttivi quando le ragioni di scambio non possono essere regolati attraverso altre norme comunemente riconosciute.
Nel dopoguerra l’introduzione di dazi all’importazione fu una politica abbastanza comune adottata da diversi PVS (Paesi in via di sviluppo) per sviluppare la crescita dell’industria nazionale con l’obiettivo di ridurre il livello di dipendenza dai paesi più avanzati: le “politiche di sostituzione delle importazioni” furono una della misure consigliate da alcuni teorici della “Dipendenza”, abbinate a politiche interne corporative e interclassiste che ebbero tra i maggiori interpreti Getulio Vargas in Brasile e Peron in Argentina. Queste esperienze avevano anche l’obiettivo di far crescere una classe imprenditoriale locale che fosse progressivamente meno subalterna alle multinazionali del nord e che si emancipasse dalla caratteristica di borghesia compradora (e non produttiva); nazionalismo e populismo furono gli approcci che caratterizzarono queste esperienze.
Un altro strumento utilizzato è stato quello delle svalutazioni competitive, adottato frequentemente anche dall’Italia fino agli anni ‘70.
L’avvento del neoliberismo negli anni ‘70 del ‘900 (e del Mercato Unico e dell’Euro in Europa) hanno spazzato via gran parte di queste esperienze ed imposto un regime di massima apertura al commercio internazionale e alla riduzione delle barriere commerciali, ovviamente a vantaggio delle elites imprenditoriali e finanziarie dei paesi guida che hanno visto lievitare enormemente i propri profitti. Così per molti paesi periferici e semiperiferici, gli elementi di competitività sul piano internazionale si sono ridotti al contenimento del costo del lavoro fino alla riduzione dei salari in termini di potere di acquisto.
Ne hanno sofferto le classi medie e i lavoratori di tutti i paesi, con esclusione di quelli che per ragioni geopolitiche dovevano assumere un ruolo di contenimento di altre potenze (per es. Corea del Sud o Taiwan), oppure paesi che sono riusciti a contenere il libero movimento dei capitali (Cina) attraverso adeguate politiche e vincoli agli investimenti, senza comunque intaccare il potere della grandi corporations che hanno lucrato dovunque fino ad oggi grandi quantità di utili producendo a basso costo in tali paesi e rivendendo i loro prodotti a livello globale.
Il problema è che non vi è stata da parte di tali operatori l’attenzione ad una sufficiente redistribuzione sociale di tali profitti neanche nei paesi emanatori (USA e diversi paesi europei).
L’avvento di Trump e di altri movimenti populisti e nazionalisti in occidente è il prodotto di questa bulimia che ha concentrato sempre più profitti in poche mani, senza neanche un equilibrio tra investimenti e consumi, ma trasferendone moltissimi al settore dei servizi finanziari. Il risultato è che anche le classi operaie e medie dei paesi guida sono state tra i grandi perdenti del globalismo neoliberale.
Fino a pochi anni fa gli Usa avevano costituito un caso a sé, in forza della inesauribile capacità del dollaro di rappresentare la primaria divisa di scambio e di riserva, per cui il loro enorme debito pubblico godeva di uno status unico e non comparabile di sostenibilità.
Ma già da qualche anno a questa parte la cosa è cambiata: e la sconfitta in Ucraina insieme all’inarrestabile crescita cinese e dell’Asia nel suo complesso hanno aggravato la situazione e soprattutto le prospettive. E sono le prospettive di ulteriore declino ad aver innescato i dazi di Trump, peraltro iniziate sotto le precedenti amministrazioni.
E’ importante tener presente che la reintroduzione massiccia dei dazi da parte della più grande potenza dell’occidente, a prescindere dai risultati che conseguirà, non implica di per sé un miglioramento della condizione dei lavoratori e delle classi medie americane, poiché non attua alcun trasferimento dei profitti accumulati nell’arco di mezzo secolo di neoliberismo, ma anzi, ne tenta una salvaguardia in extremis, tentando di raggiungere un riequilibrio del debito pubblico a discapito di altre borghesie nazionali che erano diventate da tempo molto più competitive. (E’ anche il motivo per cui Trump si è circondato dei suoi vari campioni del globalismo). Ma può certamente ridurre l’esposizione debitoria e liberare parziali risorse per gli investimenti pubblici.
Gli effetti di questa guerra, almeno nelle intenzioni, saranno pagati essenzialmente dalle classi operaie e medie dei paesi sottoposti a dazi, poiché anche in tali paesi, l’emergenza sarà quella di tutelare le rispettive borghesie produttive, commerciali e finanziarie.
La guerra commerciale è dunque una guerra a bassa intensità (si fa per dire) tra diversi gradi di imperialismo, finché qualcuno degli attori non intenderà passare ad altri scenari.
E’ importante comprendere che la narrativa e la comunicazione a cui si assiste, per esempio in Europa, dopo l’introduzione dei dazi trumpiani, è, come ovvio e naturale per il contesto in cui avviene, neo-nazionalista e decisamente sovranista (se non non a livello nazionale, a livello comunitario) e prova a portarsi dietro le rispettive classi subalterne… per conto delle grandi borghesie continentali.
Ma il tentativo di Trump assomiglia in effetti moltissimo a quello sperimentato dai paesi in via di sviluppo tra gli anni ‘60 e 80: barriere all’import per stimolare ri-localizzazioni produttive di sostituzione delle importazioni. Che queste politiche le assuma il presunto centro imperiale non deve sorprendere: come avevano profetizzato diversi economisti neo-marxisti fin dagli anni ‘70, le multinazionali sarebbero andate così avanti nel loro tragitto di potenza sempre più svincolato e autonomo, fino a rimangiarsi le madri che le avevano prodotte.
E in ogni caso mostra con evidenza che questo modello di globalizzazione neoliberale non è più sostenibile ed ha sonoramente fallito. (Anche se, per evitare scontri all’ultimo sangue al vertice, per il momento Trump si è circondato dei Musk, Bezos, Zuckerberg, ecc.).
Per riconquistare un reale riequilibrio, interno e internazionale, non sono tanto utili i dazi: utile è una ripartizione sociale globale degli impressionanti profitti raccolti dalle imprese multinazionali nel corso degli ultimi 50 anni. Questo dovrebbe essere l’obiettivo politico delle forze popolari di ciascun paese, in ciascun paese. Cosa che, da un punto di vista tecnico, significherebbe una grande riconversione dalla produzione, dall’export al mercato interno. Qualcosa di contiguo a quanto suggeriva Keynes, col suo Bancor, che rendeva del tutto superflui dazi e barriere di ogni sorta.
R.R.T.





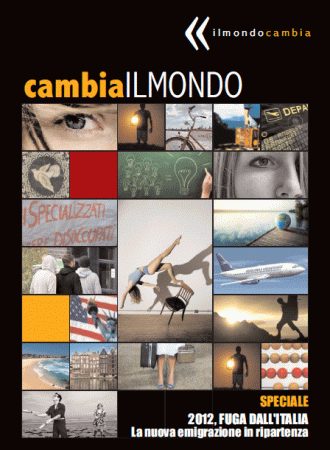












Lascia un commento