𝗣𝗲𝗻𝘀𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗶. 𝗟𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗯𝗶𝗽𝗼𝗹𝗮𝗿𝗲: 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲
Questo incontro costituisce il momento di avvio di una serie di incontri sul tema della guerra che si terranno nei prossimi mesi a Bologna in diversi spazi. Al centro della discussione saranno le trasformazioni della guerra dopo la fine del mondo bipolare, con l’obiettivo di misurare continuità e differenze.
L’incontro si è tenuto Giovedì 10 ottobre 2024 presso Mediateca “Giuseppe Guglielmi” (Via Marsala, 31 – Bologna) – Fondazione Gramsci Emilia-Romagna web: https://iger.org/
Intervengono:
Sandro Mezzadra (Università di Bologna), Carlo Galli (Università di Bologna), Laura Bazzicalupo (Università di Salerno)
TRASCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
INTERVENTO DI Sandro Mezzadra
[Sono molto contento che il primo incontro si svolga al Gramsci, un luogo che mi è caro, e ringrazio Paolo Capuzzo per l’interesse e la disponibilità; ringrazio anche tutto lo staff del Gramsci per la collaborazione organizzativa. Il seminario di oggi si intitola “Pensare la guerra”. Sulla locandina ci sono tre nomi, il mio, quello di Carlo Galli e di Laura Bazzicalupo.]
Pensare la guerra. Un esercizio di carattere teorico che naturalmente non può prescindere dalla realtà angosciante delle guerre attualmente in corso. Vorrei cominciare indicando in modo telegrafico alcuni aspetti di queste guerre – della guerra in Medio Oriente e della guerra in Ucraina in particolare – che spesso non sono assunti pienamente nella loro importanza.
Pensiamo alle due mappe che Netanyahu ha presentato all’assemblea Generale dell’ONU – da lui definita una “palude antisemita”, cosa di per sé significativa – alla fine di settembre. Una mappa si intitolava “la maledizione”, e mostrava l’“asse del male”, come viene spesso definito quello della resistenza sciita; l’altra mappa si intitolava “la benedizione”. Ciò su cui vorrei richiamare l’attenzione è che questa seconda mappa, “la benedizione”, mostra un Medio Oriente riorganizzato intorno al corridoio economico India-Medio Oriente-Europa, progetto fortemente sponsorizzato dagli Stati Uniti e rilanciato circa un anno fa al G20 a Nuova Delhi.
Spostandoci sul secondo terreno di guerra particolarmente significativo oggi – per quanto naturalmente non siano soltanto questi due i teatri di guerra –, tra domenica scorsa e lunedì [6-7 ottobre, ndr] ci sono stati attacchi russi nel mar Nero a due navi che trasportavano cereali ucraini. Era molto tempo che questo non accadeva e riporta con la memoria alle prime settimane di guerra, quando il blocco delle catene di fornitura dei cereali, tanto ucraini quanto russi, ha determinato una crisi alimentare in diverse parti del mondo, dal Corno d’Africa all’America Latina.
Questi due esempi rendono conto delle poste economiche in gioco nei conflitti del presente, in particolare per quel che riguarda le supply chains, le catene di fornitura, che costituiscono l’ossatura del commercio mondiale. Ciò che ne derivo, è una consapevolezza dei limiti di una lettura unicamente geopolitica delle guerre del presente: la geopolitica può certamente aiutare a comprenderle, ma non è sufficiente a comprendere ciò che è realmente in gioco in queste guerre.
Abbiamo pensato che, per cominciare ad approssimare questa questione, nel primo incontro fosse utile ragionare su continuità e differenze tra le guerre di oggi e quelle che hanno segnato la fine della guerra fredda, gli anni ’90 e i primi anni 2000.
Io vorrei molto brevemente tornare a quelle guerre, tra loro piuttosto diverse, con qualche cenno a due letture che mi sono particolarmente vicine e care: in “Impero” – libro che ebbe grande successo quando fu pubblicato nel 2000 – Michael Hardt e Toni Negri sostenevano che la prima guerra del Golfo avesse mostrato gli Stati Uniti come unica potenza in grado di amministrare la giustizia internazionale. Gli Stati Uniti da questo punto di vista si presentavano all’interno di “Impero” come la “polizia della pace”; le guerre, combattute nel Golfo ma anche in teatri come la Somalia e i Balcani, apparivano ai due autori operazioni di polizia internazionale. Dopo l’11 settembre, mentre si profilava l’inizio della guerra globale al terrorismo, l’analisi di Hardt e Negri in un libro intitolato “Moltitudine” cambia direzione, e sottolinea come si stesse delineando uno stato di “guerra globale” – cito – che “erode a tal punto la distinzione tra guerra e pace che nessuno di noi immagina più una pace reale”. Come molti altri e molte altre in quegli anni, Hardt e Negri riprendono la categoria di eccezione e parlano di uno “stato di eccezione permanente”.
La seconda lettura di quei conflitti su cui voglio brevemente soffermarmi è quella offerta da Carlo Galli nel 2002 in un libro intitolato “La guerra globale”. Al centro di questo libro, uscito nel 2002 e dunque sotto l’impressione dell’11 settembre, è il conflitto tra le identità: qui Galli decostruisce questo conflitto, sostiene che benché esso coinvolga la carne, cosa da non dimenticare, quello tra le identità sia un conflitto “di fantasmi”. Galli prendeva sul serio la determinazione globale della guerra, riconosceva l’intreccio inestricabile tra guerra globale e guerra economica, e con toni in fondo simili a quelli di Hardt e Negri scriveva, anche qui cito, “la guerra globale non è uno scontro di differenze chiare e distinte ma un unico caos in cui si mescolano i volti contrapposti di un Uno in lotta con sé stesso”. Emerge qui la logica dell’“uno”; la convinzione che la guerra si svolgesse, nelle sue diverse manifestazioni, all’interno di un mondo definitivamente unificato.
A lungo, dal punto di vista delle retoriche di giustificazione dell’intervento militare occidentale, è prevalso il riferimento a categorie come quella di “stato fallito” e “stato canaglia”. Quest’ultima è una categoria magistralmente smontata e decostruita da Jaques Derrida in quegli anni. Tuttavia credo che valga la pena soffermarsi brevemente sul significato di questa categoria. Parlare di “stati canaglia” significava respingere la guerra ai margini di un sistema internazionale che si supponeva funzionasse a pieno regime secondo le sue norme e i suoi standard.
Vengo al nostro presente, ora. Quello che mi interessa mettere in evidenza può apparire un paradosso. Oggi siamo circondati da discorsi e da processi che sembrano annunciare la fine di quel processo di unificazione di cui ho appena parlato. Basti pensare alla figura del decoupling, della “separazione”, della riduzione dell’interdipendenza, oppure del re-shoring, della riorganizzazione delle catene di fornitura. Pensiamo alle guerre commerciali, pensiamo al protezionismo, pensiamo ai dazi, per esempio a quelli varati nei giorni scorsi dall’Unione Europea sulle auto elettriche cinesi. Tutto questo ci parla di fratture. Io credo si debba fare lo sforzo di leggere queste fratture all’interno di una cornice che continua ad essere caratterizzata da potenti processi globali di unificazione. Questo è esattamente quello che può sembrare un paradosso ma che dovremmo tenere sempre presente per comprendere ciò che accade oggi, per comprendere le guerre del presente. Si tratta certamente di guerre che non si possono in alcun modo leggere o giustificare attraverso una categoria come quella di “stato canaglia”, soprattutto se teniamo presente che sullo sfondo delle due guerre maggiori di cui ho parlato, c’è la competizione strategica tra Stati Uniti e Cina che viene spesso interpretata secondo la figura, fuorviante ma ampiamente circolante oggi, della “nuova guerra fredda”. Stiamo parlando di guerre che coinvolgono direttamente o indirettamente potenze nucleari. Stiamo parlando soprattutto – e questo è un altro punto che vorrei sottoporre alla discussione – di guerre che si combattono all’interno di una doppia crisi: la crisi del sistema internazionale e la crisi del sistema-mondo. C’è evidentemente una differenza tra sistema internazionale e sistema-mondo: il sistema internazionale è quello che si organizza intorno agli stati; il sistema-mondo è quello che, si può dire, si organizza intorno alle operazioni di attori capitalistici. Oggi io credo che entrambi stiano attraversando una radicale crisi: caos sistemico, per citare Giovanni Arrighi, uno dei grandi teorici del sistema-mondo. È proprio all’interno di questa doppia crisi che si è prodotta una concatenazione tra la guerra in Ucraina e la guerra a Gaza e poi in Medio Oriente. Sono evidentemente guerre che, se considerate singolarmente, non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra, né quanto alle storie specifiche, né quanto alle poste in gioco. Ma è dentro la doppia crisi di cui ho parlato, che si è determinata oggettivamente una concatenazione tra queste due guerre, internamente a quella che abbiamo scelto di chiamare nel titolo del ciclo di incontri una “congiuntura di guerra”. La guerra appare oggi, del tutto diversamente da come appariva negli anni ’90 e nei primi anni 2000, al centro dei processi globali.
Mi avvio verso la conclusione. Ciò che unisce e che consente di spiegare la crisi del sistema internazionale e la crisi del sistema-mondo, è una terza crisi: la crisi dell’egemonia globale degli Stati Uniti d’America. Questa è una crisi che i teorici del sistema-mondo hanno analizzato fin dalla metà degli anni ’90 e che successivamente, con la sostanziale sconfitta militare degli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan, e con la grande crisi finanziaria del 2007-8, è diventata agli occhi di molti una evidenza. Ho menzionato un paio di volte la teoria del sistema-mondo, teoria secondo cui la storia del sistema-mondo capitalistico fin dal XVI secolo è organizzata intorno a cicli egemonici, attorno alla successione di potenze capaci di determinare un’articolazione tra territorialismo e capitalismo. Nella prospettiva di questa teoria, un momento chiave nella storia, un momento estremamente complesso e delicato, è quello che viene chiamato il momento della transizione egemonica, del passaggio cioè da una egemonia all’altra. Per motivi che sarebbe troppo lungo spiegare, io non credo che oggi la prospettiva di uscita dalla doppia crisi di cui ho parlato sia una transizione lineare dagli Stati Uniti ad un’altra potenza, per esempio la Cina. Però, credo che la situazione in cui stiamo vivendo abbia tutti i segni e tutte le caratteristiche delle precedenti transizioni egemoniche, e se guardiamo a queste precedenti transizioni egemoniche c’è da preoccuparsi: le transizioni egemoniche sono state caratterizzate da un succedersi di guerre sempre più devastanti. In breve, l’affermazione dell’egemonia britannica viene a compimento sui campi di battaglia delle guerre napoleoniche; l’affermazione dell’egemonia statunitense richiede le due guerre mondiali della prima metà del ‘900. Questi sono certo precedenti storici poco incoraggianti, ma che dovrebbero rafforzare la nostra determinazione a cercare delle vie d’uscita dalle crisi di cui ho parlato che siano diverse da quella bellica.
Oggi viviamo in una congiuntura nella quale occorre tornare a nominare al plurale l’imperialismo: siamo in presenza di diversi imperialismi e questo è naturalmente un altro aspetto preoccupante. Dobbiamo comprendere come funzionano questi imperialismi in una situazione, per concludere, in cui sistema internazionale e sistema-mondo, spazi politici e spazi del capitale, sono sempre più evidentemente sconnessi, disarticolati. Certamente questa affermazione può suonare astratta, ma penso che sia sufficiente ripensare alle due “vignette” con cui ho aperto questo intervento, per comprendere l’assoluta materialità di quello che ho detto.
La mia ipotesi è che, in una situazione come questa, convenga ragionare non soltanto sulle guerre “guerreggiate”, ma anche su quello che chiamiamo il “regime di guerra”, ovvero la penetrazione della logica della guerra all’interno della cultura, della società, dell’economia, anche in paesi non direttamente coinvolti nelle operazioni belliche. Pensiamo al dual-use, all’uso duale di tecnologie e produzioni industriali, sempre più spostato verso la possibilità dell’uso militare. Certamente quello che sto dicendo coinvolge in modo particolare i settori di punta dell’innovazione tecnologica: la ricerca, la produzione industriale, nel campo dell’intelligenza artificiale e più in generale delle tecnologie digitali. Quello che è in gioco dunque è la qualità stessa dello sviluppo, la qualità stessa dello sviluppo culturale, politico, sociale ed economico.
Ultimo esempio: la transizione ecologica ed energetica. Evidentemente la guerra, la logica della guerra, il regime di guerra, impattano molto violentemente sulle prospettive della transizione ecologica e della transizione energetica. Sono cose che credo dobbiamo tenere presente quando parliamo oggi di guerra allo stesso titolo degli sviluppi bellici in Israele, in Medio Oriente, in Russia, in Ucraina.
La domanda con la quale vorrei segnare l’avvio di questo ciclo di incontri è: come si lotta oggi contro la guerra e contro il regime di guerra? È una domanda che naturalmente non ha risposte semplici, che difficilmente può trovare risposta esauriente a tavolino, ma per noi è la domanda che orienta l’intero ciclo di incontri.
INTERVENTO DI Carlo Galli
Il mio punto di vista è parzialmente coincidente con quello di Sandro Mezzadra, ma con delle sottolineature diverse. Abbiamo il problema di decifrare le guerre di oggi, che ci riguardano molto più da vicino delle guerre di ieri, poiché si sta molto restringendo lo spazio “esente” dalla guerra, cioè l’Occidente – che era “lo spazio esente dalla guerra”, che faceva le guerre “fuori”.
Per capire è necessario mettere in successione storica gli schemi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto uno schema duale delle relazioni internazionali, con sostanzialmente due modelli di civiltà, entrambi moderni ed entrambi unificati dalla loro modernità; erano due modi diversi di interpretare l’epoca, ma entrambi interni all’ideologia del progresso, al culto della tecnica. Erano l’uno l’eresia dell’altro: il numero chiave era due, ma sotto c’era anche l’uno.
Questo, sotto il profilo del rapporto tra guerra e politica produceva questo risultato: che la guerra era improbabile, la pace impossibile. Cioè, vi era una situazione di tensione continua che si manifestava nei punti in cui i due imperi si toccavano, ma soprattutto all’interno di ciascuno dei due imperi, ciascuno percorso da “eresie” che venivano addebitate all’influenza dell’altro. Basti pensare al maccartismo negli Stati Uniti – che era una persecuzione dei progressisti – o al fatto che nell’Impero sovietico scoppiassero continuamente rivolte nei paesi occupati.
Le guerre dov’erano? Certamente non nel punto di contatto tra i due imperi; erano fenomeni periferici che ovunque si manifestassero erano sempre legati al grande conflitto, che però era tutto potenziale. Con questo s’intende ad esempio che le guerre di liberazione coloniale erano a loro modo supportate dal blocco comunista; al contrario, il blocco occidentale, gli Stati Uniti di fatto, difendeva in vari modi posizioni di dominio o apertamente coloniale o semi-coloniale – basti pensare ai rapporti tra gli Stati Uniti e l’America Latina, oppure al fatto che l’Inghilterra e la Francia abbiano a lungo e sanguinosamente difeso i propri imperi coloniali, che si sono disfatti solamente nel 1960.
C’era un due, la cosa più evidente; c’era l’uno, la sostanza. E poi, c’era il proliferare di guerre, il cui scopo fondamentale non era però quello di mettere in discussione la sicurezza reciproca, che era invece assicurata dal potenziale di mutua distruzione – e pur essendo questo un modo molto costoso di “assicurarsi” la sicurezza, ha funzionato.
Tutto ciò salta quando il capitalismo fa un passaggio fondamentale dal paradigma di Bretton Woods al paradigma neoliberista, passaggio che impegna gli anni ’70, che produce una capacità del capitalismo di sfidare mortalmente il comunismo – cioè l’economia di piano, l’economia di comando –, con conseguente crollo disastroso dell’“antagonista” russo, sovietico. Nel frattempo i cinesi, essendo più malleabili, assorbono ciò che può essere assorbito e conservano il potere comunista.
Si apre a questo punto un decennio, possiamo dire anche quindicennio, di monopolio mondiale della potenza reale, il monopolio statunitense, l’iper-potenza solitaria: ciò fa si che molte analisi dell’epoca siano centrate su una idea di “unità” del mondo. Questa “unità” non è né omogeneità né uguaglianza. L’irruzione del capitalismo negli spazi del comunismo, l’irruzione globale del capitalismo, non implica che “tutti diventano capitalisti”, ma che il mondo venga attratto all’interno di un sistema che ha delle gerarchie: c’è chi ci mette il capitale, chi le idee e l’innovazione, chi la manodopera altamente qualificata, chi la manodopera semplice, chi le materie prime, chi gli schiavi. C’è una grossa differenza dunque: non possiamo pensare al mondo come “unificato”; semplicemente, c’è una forma di produzione, anche se anch’essa complicata dal fatto che, pur essendo diffusa in tutto il mondo, veda un predominio netto della finanza sull’economia reale, cosa che va a costituire un mondo complesso, niente affatto semplice. Questo è un mondo in cui i conflitti ci sono: cambia però la tipologia del conflitto. Quella egemonica in questo decennio o quindicennio è chiamata “terrorismo”: si tratta di qualcosa di non localizzabile, qualcosa che non ha confini, che si muove come se il mondo fosse tutto un mare e questi fossero tutti pirati.
A questa sfida, senza approfondirla nel merito, si risponde con altrettanta infinitezza: il concetto è quello di una guerra globale e senza fine contro il terrorismo. Ciò poi significa una serie di attacchi che non hanno caratteristica formale di guerra, benché siano espressioni di violenza: assassini mirati; attacchi che colpiscono stati che si vanno disgregando (basti pensare alla Somalia, che diventa luogo in cui ci sono tanto forme di annientamento del terrorismo quanto anche forme di contro-terrorismo, più o meno efficace e fortunato); si può pensare a Bin Laden che colpisce le torri e a sua volta viene colpito; si può pensare all’Afghanistan, si può pensare all’Iraq. È una violenza continua, non è un quindicennio di pace: è un quindicennio in cui la violenza è quotidiana, normale, pare essere ciò di cui si nutre il sistema. Ma ciò di cui si nutre è il contorno, essendo invece la sostanza l’economia: è un contorno che non può mai mancare, ma il piatto forte è lo sviluppo del capitale.
Questo sviluppo del capitale, però, si interrompe: il neoliberismo è in crisi almeno dal 2007, non è nella fase del trionfo e dell’euforia, e dunque del consenso ricevuto dalle società. È da molto tempo ormai una macchina ansimante, una macchina che marcia male, che non produce più benessere. Tanto è vero che in tutto l’Occidente le società stanno rispondendo attraverso fenomeni che possono essere definiti in vario modo (“populismo”, ad esempio): forme di dura reazione nei confronti del paradigma affermato e non più praticabile, del paradigma neoliberista, che ha sempre più bisogno di politica per sostentarsi, non è più “auto-propulso”. L’idea è che il cuore teorico del neoliberismo – che poi non è altro che neo-marginalismo – sia il fatto che i processi economici siano di per sé in equilibrio (un equilibrio almeno statistico) ove non disturbati. Questa teoria oggi non è più affermabile in sede scientifica – a livello propagandistico si può ancora dire “lasciamo lavorare i produttori”, “lo Stato non crea ricchezza”, “l’economia ce la fa da sola”, ma non è nulla più che propaganda in malafede. L’idea reale, ciò che sta capitando, è invece il continuo ricorso alle strutture della politica, e al loro aspetto più duro: dove non arriva l’austerità, che arrivino i provvedimenti di polizia! Dove non arriva la capacità di convincersi che “siamo tutti sulla stessa barca”, che questa convinzione venga prodotta dal fatto che siamo perennemente in guerra contro nemici che ci vogliono male! Dobbiamo essere uniti, e “marciare”: questo, con la differenza sostanziale rispetto alle retoriche e alle strategie reali della destra di un tempo, che ragionava tendenzialmente così, ma che faceva funzionare l’economia con sistemi para-keynesiani; in secondo luogo e soprattutto, quella funzione di unificazione contro il nemico esterno e interno, la voleva realizzata attraverso la produzione di “masse eroiche”. La differenza, oggi, è che si produce una funzione di unificazione assolutamente esterna ed estranea al concetto di “masse eroiche”. Oggi c’è soltanto la costruzione di una società atomizzata – ed è il neoliberismo ad averla preparata negli ultimi trent’anni – di individui spaventati, ansiosi, privi di legame sociale, che hanno preoccupazioni varie, paura; e alle tante paure del quotidiano (economiche principalmente) aggiungiamo la paura delle autocrazie.
Questo perché, mentre andava in crisi il neoliberismo, capitava anche un’altra cosa: la formuletta dell’“uno” – con gli “n” che si muovono all’interno di questo “uno”, che creano fastidio e danno turbolenza, ma senza toccarne l’essenza – non esiste più. La crisi del neoliberismo è una crisi interna, ma è dettata anche dal fatto che alla produzione capitalistica sono arrivati anche altri soggetti, nel mondo, nel pianeta. Detto con una immagine: il crollo dell’URSS può essere interpretato come diluvio – in cui le acque coprono la terra e il capitalismo copre la terraferma. Proviamo a porla in un altro modo: la geopolitica perde molto peso come capacità di spiegazione delle dinamiche internazionali; magari diviene invece più importante la geo-economia. Questo, dopo il 2007-8, non è più troppo vero. Le acque calano e dalle acque emergono le formazioni rocciose: qualcuno si ricorda del concetto di “interesse strategico nazionale”. La Cina se lo ricorda eccome: nel suo interesse economico nazionale c’è essenzialmente Taiwan, cui la Cina “vuole bene”, con cui fa affari continuamente, sistematicamente, massicciamente; semplicemente, ne vuole il possesso politico e militare, grazie al quale farebbe una cosa che gli americani non le consentiranno mai di fare e cioè accedere, liberamente, all’Oceano. È esattamente ciò che provò a fare il Giappone: costruirsi un impero terrestre. E così minacciare il dogma americano per cui gli USA devono controllare entrambe le sponde di entrambi gli oceani su cui si affacciano. Se la Cina si prendesse Taiwan, gli Americani, nella loro idea, perderebbero il Pacifico.
L’altra linea, transitoria e minacciata, è la via della seta, la via di terra. Ed ecco il significato della guerra in Medio-Oriente: costruire una linea, dall’India – che non ama la Cina –, vincendo gli sciiti, arrivando ad Iran e magari Siria, con la benedizione di Arabia Saudita e Israele; tutto ciò è in fieri, è quello che sta succedendo. Questo è uno dei motivi che portano, con il calo (simbolico) delle acque, a far emergere una terra frastagliata, che è in sé divisa, non è una unità; è fatta di separazioni e di interesse strategico permanente. Questo lo vediamo anche in Ucraina, dove la spiegazione è una spiegazione “vecchio stile”: la Russia è una potenza che ha a che fare con l’Europa solo nella misura in cui controlla l’istmo Ponto-Baltico (una linea che va da Riga o da Kaliningrad, a Mariupol o Odessa). Se la Russia qui ha il controllo, ha la possibilità di premere sull’Europa, se non lo controlla è come se avesse un piede tagliato: l’Ucraina è “il piede della Russia” verso l’Europa.
La Russia ha perso la Guerra Fredda, ma per un motivo o per l’altro non si è seguita la grande indicazione di Machiavelli (“atterrato un nemico, lo si deve finire”), e dunque la Russia, come era evidente, si è ripresa. Con 17 milioni di kmq, non è certo rimasta a fare il “servitore muto” degli americani. La prima cosa che vuole è l’Ucraina: non per invadere l’Europa – anche perché i russi sono pochi, non possono invadere l’intera Europa –, ma per essere fuori dalle porte di casa dell’Europa stessa, essendo così un vicino molto grosso, molto arrabbiato, molto maleducato.
Dunque, un’ipotesi di geopolitica, lì, io ce la vedo. Tanto che la guerra economica contro la Russia è sostanzialmente fallita: ed è fallita incrinando molto l’unità del capitalismo mondiale. Tra le crisi che hanno reso difficile il meccanismo capitalistico mondiale non ci sono solo i dazi, che pesano molto, ma ci sono anche le sanzioni. Eppure, si vive anche sotto sanzioni. La Russia ha sul proprio territorio tutte le materie prime che le possono servire, ed è complicato quindi “vincere” con le sanzioni: le sanzioni l’hanno obbligata, certo, ad istituire un meccanismo finanziario diverso da quello controllato dagli occidentali – lo Switch –, ma questo non è sufficiente a perdere una guerra. Non si perde la guerra neanche se, dall’altra parte, c’è un rifornimento massiccio di armi e di qualche uomo: ma soprattutto di armi, sulla base del principio per cui “combatteremo fino all’ultimo ucraino”, cosa che la Russia è sostanzialmente disposta ad accettare, per quanto non fosse la sua idea iniziale. Poi c’è un interesse diverso, l’interesse americano dell’“adesso glielo diamo noi il Vietnam”, dunque l’idea che la Russia debba essere costretta in una situazione vietnamita, in cui si deve logorare e “perdere la faccia”. Poi, c’è la vecchissima idea inglese, che osteggia la presenza di una superpotenza sul continente – e se la Russia vincesse la guerra in Ucraina diventerebbe un po’ troppo ingombrante. C’è anche l’idea, sempre tutta inglese, che la Polonia e gli stati Baltici ricadano in un qualche modo all’interno della sfera d’influenza inglese. Quanto agli altri europei, non hanno un motivo al mondo per fare quella guerra: la Germania è l’ultima a poter avere motivi per quella guerra, infatti non la voleva fare, ha recalcitrato fino all’ultimo, e poi, avendo scarsa influenza politica, ha dovuto cedere, dopo essersi visti tagliati i rifornimenti; lì, il modello economico nel XXI secolo era un neo-mercantilismo che produceva un surplus della bilancia dei pagamenti mostruoso, fondato sul fatto che avesse energia sotto costo ma esportasse BMW e Mercedes ad altissimo costo.
Siamo dunque davanti al ritorno della geopolitica; esso potrebbe essere anche descritto come un ritorno della geopolitica che non è ammessa. Se fosse ammessa, saremmo serenamente all’interno di una pratica dei “grandi spazi”, per la quale esistono pochi “grandi spazi”: ma gli americani all’idea dei grandi spazi non accederanno mai, perché hanno l’idea che l’unico grande spazio sia il mondo, nel quale loro vogliono avere una posizione privilegiata, economica – con il dollaro come base dell’economia mondiale – e militare – con 800 basi militari nel mondo. Da questa posizione non è facile scalzarli, c’è chi ci sta provando: la Cina, non entusiasta di una reale e piena interruzione dell’unità dell’economia mondiale, vi forse è disposta, se c’è un trade off a lei favorevole. Ma, politicamente, la Cina è la prima a teorizzare i “grandi spazi”. Abbiamo, così, una discrasia tra una politica forte – un ritorno della geopolitica –, e due posizioni che vi si oppongono, quella americana sotto il punto di vista politico e militare – nella volontà che non esistano centri di potere realmente paritetici – e quella delle logiche economiche – che per quanto rese più difficoltose certamente non hanno spezzato la propria unità, non ci sono situazioni di autarchia.
Dunque oggi non si può più dire che le guerre non siano tante e molto presenti, che non pullulino all’interno di un unico sistema economico-politico: oggi il pullulare di guerre non è all’interno di un sistema, il sistema qui è messo in discussione. Non sono più guerre di periferia rispetto ad un centro intatto ma si avvicinano: il centro non è intatto, ha qualche problema, e non solo il fatto che Putin voglia l’Ucraina. Esso ha problemi interni, nel funzionamento del sistema economico, nella legittimazione delle istituzioni politiche. A ciò si risponde con un inedito miscuglio tra logiche che dovrebbero essere universalistiche del capitalismo e logiche vecchio stile della politica hard, che mira alla guerra, anche se solo a parole, visto che nessuno stato occidentale sopporterebbe la benché minima situazione bellica; non parlo di una bomba atomica che colpisca una città occidentale, ma anche solo una bomba convenzionale. Quello ci porterebbe immediatamente ad essere tutti pacifisti. La nostra capacità di resistere ad una situazione di guerra, ad una gran brutta situazione di guerra e per questo basti vedere Gaza, non c’è. Le nostre minacce, gli appelli e le chiamate alle armi, hanno un limite intrinseco: non ci crede nessuno. Veramente vogliamo fare la guerra alla Russia? Qual è l’interesse strategico italiano lì? Davvero siamo i “difensori” del diritto internazionale?
Questo, solo come indicazione del fatto che il regime di guerra, che c’è, è anche una tigre di carta. Certo è che se non si leva mai una voce critica, impareremo a pensare sempre più in termini di “nemico”, in termini di “aggressione”, in termini di asse del “bene” contro asse del “male”. Serve una voce critica che dica che “il re è nudo”, che si chieda se davvero vogliamo la guerra.
Il punto però è che è vero questo: oggi non c’è un nomos della terra. Siamo, se va molto bene, in una fase di assestamento, che torno a dire è rifiutato di principio dagli americani, per i quali il mondo va bene così com’è – e da qui deriva qualche preoccupazione. Questo assestamento può avvenire in forma catastrofica, come ricordava Sandro Mezzadra; può avvenire con qualche buonsenso, come non credo; può non avvenire in un tempo ragionevole, o potremmo dire mai – e ciò significherebbe avere davanti a noi qualche decennio di gravissima instabilità, di peggioramento delle relazioni internazionali, di peggioramento della qualità della vita all’interno delle singole società.
Il piano che ho qui esposto è drammatico, ma forse nominandone bene gli aspetti peggiori, facendo vedere come di tutte le configurazioni del dopoguerra quest’ultima sia una non-configurazione – poiché non c’è ora una “figura”, non c’è il nomos –, forse, e io lo spero, ci si accorgerà che la propaganda di guerra contro il “grande nemico autocratico” è un atteggiamento poco responsabile. Che poi, questa è dal mio punto di vista la risposta alla domanda posta da Sandro Mezzadra, come si fa a lottare? La prima risposta, per me, è delegittimare.
INTERVENTO DI Laura Bazzicalupo
Ho preso sul serio il titolo, e ho tentato di rispondere a questo. “Continuità e differenza nelle guerre” dopo la fine dell’equilibrio bipolare, fondate sulla deterrenza, katechon della sopravvivenza in epoca nucleare. Ovviamente ci sono elementi di continuità ma anche una notevole discontinuità. Dopo l’implosione dell’Unione Sovietica, il mondo postbellico bipolare, che era fortemente conflittuale, molto carico di ideologia, si trova con un solo polo vincente, come diceva Carlo Galli, la cui identità sta tutta nello scontro binario: noi buoni, loro cattivi, di colpo trovandosi senza antagonisti legittimi.
Si tratta quindi di una egemonia incontrastata, pace senza minacce. È una egemonia che dura ancora oggi? Certamente è ancora superpotenza militare, tecnologica e parzialmente finanziaria, ma non corrisponde più ad una capacità reale di regolare – non dico i poli di potere regionali esplicitamente antagonisti – nemmeno gli orientamenti degli alleati che agiscono sotto il suo ombrello, si vedano le linee rosse di Biden e Netanyahu.
E qui, il consenso frana. Quando frana il consenso, frana, come ci insegna Gramsci ma anche Arrighi, la seconda gamba dell’egemonia, che senza di esso tende al puro dominio; prima lentamente – e nel mentre “The Rest”, 7 miliardi e passa di persone, cresce vertiginosamente. Poi, dopo le crisi, soprattutto quella del 2007-2008, molto rapidamente comincia a franare, sboccando in un aperto antagonismo. Non è questa una ripresa del bipolarismo, tutt’altro.
Ancora oggi la superpotenza è una sola, la stessa, gli Stati Uniti, ed è questa la continuità. Ma i lunghi anni del declino alimentano oggi il caos, come si è ben visto, e la pretesa di quanti – come per esempio negli Stati Uniti i neocons che tengono le briglie dell’apparato strategico-militare – sperano, nel caos, di imporre la soluzione militare. Anche in Israele avviene questo, e forse in Russia. Forse, alcuni dicono, è una trappola di Tucidide – una guerra preventiva, quando l’egemone è declinante, contro lo sfidante, e con esiti disastrosi per entrambi. Oppure, forse, non è una trappola di Tucidide, io dubito, e questi neocons e similari, dimenticano che la grande vittoria sull’impero sovietico – l’evento della caduta del muro di Berlino, mito fondativo del new liberal global order, il nostro mito fondativo insieme a quello della caduta dei nazisti – fu dovuta alla sua auto-implosione, non ad una sconfitta militare; dimenticano anche l’esito fallimentare degli interventi militari americani nell’ultimo trentennio. Dall’Iraq all’Afghanistan… alle infinite guerre d’Israele. Per non risalire al Vietnam, che per Arrighi rivela già la perdita di egemonia.
In ogni caso, ci troviamo di fronte ad una egemonia unipolare, come quella degli anni ’90, sull’intero pianeta, ed è qualcosa di inaudito, di diverso dai vecchi imperi. Una pretesa, questa dell’unipolarità, che implica un’abolizione del fuori, della distinzione tra interno ed esterno sulla quale si è retta la politica: come insegna Carlo Galli, una complementarietà di ordine interno e guerra esterna. In un mondo unipolare, se salta questa distinzione, chiunque dissente o lotta, è un nemico interno, intollerabile per la logica politica moderna dell’ordine, come è intollerabile la guerra civile. Cade la distinzione tra interno ed esterno, che è il cardine della rappresentazione politica decisiva per il politico: e allora ogni guerra è guerra civile, nella moralizzazione della politica, nel processo di eticizzazione della politica che comincia con la Rivoluzione Francese. Diventa operazione di polizia; non c’è un fuori.
C’è solo un’accoppiata vincente: un ordine neoliberale di mercato che copre l’intero spazio, presunto liscio, della globalizzazione e la sua legittimazione nell’universalismo dei diritti umani, che viene diffusa e difesa dall’egemone benevolente per tutto il globo terracqueo.
L’ONU, con un formale multilateralismo “copre” l’unipolarità di fatto; accredita l’esportazione armata della democrazia come un bene per tutti; accetta i doppi standard dei tribunali internazionali. Tutto questo mina, per quanto lentamente, la credibilità della legittimazione, e prepara l’attuale patetica impotenza.
Forse la discontinuità più macroscopica è la rapidità davvero incredibile con cui tutto l’apparato, tanto esaltato, di legittimazione dei diritti umani, sia franato in un attimo, mostrando di essere, letteralmente, cartaceo. Un castello di carte.
In ogni caso la pace infinita, la fine della storia – in cui sono tutti dentro l’accoppiata vincente, salvo piccoli aggiustamenti marginali, periferici, che non si chiamano neanche guerre ma “interventi umanitari” per far ragionare i riottosi – insomma, l’accecante bolla ideologica dura quanto i gloriosi anni ’90: la decantata “fine della storia” finisce presto, col brusco risveglio dell’11 settembre, preparato già dalla prima guerra del Golfo. Si scopre così che Qualcuno è scontento, anzi molto scontento! Le pratiche terroristiche sono conseguenza sia della rimozione delle “ragioni” del conflitto – degradato a duro disciplinamento di gente “arretrata”, governata da dittatori e riottosa al controllo occidentale della regione –, sia della totale asimmetria di potenza bellica: è proprio la iperpotenza che impedisce di fare una guerra “guerra”. Un kamikaze non ha nulla da perdere e non può che seminare terrore, non ha margini di vittoria, e neanche di contrattazione; è però ubiquitario, imprevedibile e imprendibile. Muore e risorge. La pace si è infilata in un cul de sac.
Nomino subito le date-evento, il 1991, l’11 settembre, il 2008, il 2014/16, il 2022, il 7 ottobre. Le date contano, certo, ma raramente coincidono con i reali processi e le reali biforcazioni e trasformazioni del sistema. Quello che voglio dire è che una cosa è l’analisi geopolitica di superficie, e una cosa è studiare genealogicamente i processi stessi. Per capire i processi che portano a questi eventi iconici è necessaria una analisi genealogica. L’ampiezza del programma di questo seminario potrebbe riuscire a soddisfare questa necessità. Per comprendere i processi, la teoria del sistema-mondo cui si è riferito Sandro Mezzadra, è certamente d’aiuto, sia pur con qualche problematicità: essa, innanzitutto, Organizza l’analisi in modo sistemico e quindi articola i diversi aspetti della complessità, li pone uno articolato nell’altro. Così, fa emergere ciò che il tabellone del Risiko della geopolitica televisiva non vede o non dice: la continuità, il tempo lungo del capitale, Proteo, multiforme, con una sua costante, che non è affatto il libero commercio presto accantonato dai monopoli, ma è la pura accumulazione di profitto ed estrazione del valore in operazioni molto diverse. Dovremmo seguire l’andamento delle sue crisi cicliche per afferrare la genealogia delle guerre che si innestano in esse, dal momento che è impossibile districare, almeno ad oggi, il capitale dalle strutture del politico. Poi c’è il peso della finanziarizzazione che, per loro, per chi teorizza il sistema-mondo, rappresenta il sintomo dell’autunno, del declino. E ancora, al di là dei teorici del sistema-mondo, c’è il protagonismo e il potere sociale della tecnologia e dei media, legati a capitale e finanza ma irriducibili ad essi. Sono tempi lunghi e trasformazioni che richiedono analisi genealogiche.
Le date iconiche evidenziano piuttosto il cambiamento “visibile” della retorica legittimante e delle tecniche di guerra. Entrambi elementi da non sottovalutare, in quanto sintomi del cambiamento radicale delle relazioni internazionali e belliche.
Dopo l’11 settembre l’atmosfera si fa cupa: la bandiera dei diritti umani e dell’ordine liberale o neoliberale resta la stessa ma trova un vento contrario, un ostacolo, sia pure dequalificato e non riconosciuto come politico. Si contrappone quest’ordine al criminale, al terrorista, figura cui non si riconosce dignità politica. I terroristi sono barbari subumani, supportati da “stati canaglia” o sedicenti stati. Così la guerra diventa l’infinita caccia al terrore che non ha bisogno di legittimazione giuridica, anzi sospende il diritto: in nome del mondo giusto e della sua sicurezza, è ovvio e giusto combattere e punire i “tagliagole dell’orrore”. Con ogni mezzo. Il Patriot act è prova della progressiva irrilevanza del diritto.
Morale e sicurezza così si saldano. Sicurezza significa guerra preventiva, ed essa è letteralmente infinita perché sempre nuovi nemici possono emergere, ovunque: il possibile, nella svolta securitaria, prende il posto del probabile. La caccia ai sospetti si sovrappone alla caccia ai malvagi dittatori e autocrati – quelli che non sono liberal-democratici – e autorizza un ampliamento abnorme dei metodi polizieschi, che possono disciplinare e reprimere penetrando nei gangli del quotidiano.
E così la guerra si fa ibrida. Per colpire ovunque la tecnica di guerra deve adeguarsi all’ubiquitarismo, alla copertura, alla segretezza. Questa è sempre più lontana dal modello westfaliano della guerra en forme – con i riti di inizio e di fine, combattuta solo da stati sovrani formalmente paritari, solo da militari in divisa: non è che allora non ci fosse la violenza, ma la violenza bruta e sregolata veniva esclusa dallo spazio interno e chiuso che era l’Europa, e le si lasciava mano libera nelle “conquiste” coloniali, ove la regolazione delle une poggiava sulla brutalità delle altre. Oggi è improponibile, non solo dopo la decolonializzazione, ma soprattutto in una integrazione globale e unipolare, entrambi fattori decisivi dell’attuale trasformazione della guerra in una guerra tutta interna, che si afferma riguardi tutti e che a tutti chiede fedeltà: questo è proprio delle guerre civili, seppur qui derubricate.
Le tecniche della guerra ibrida c’erano già nella guerra fredda, ma ora diventano la chiave dello scontro. Manifestano la discontinuità più importante: la indistinguibilità del conflitto interno ed esterno. Guerra ibrida significa propaganda, intelligence e deception, ma anche cyber-attacchi, omicidi mirati, truppe mercenarie e private, mezzi irregolari e non convenzionali: sanzioni, blocchi delle supply chains, affamamento delle popolazioni, regime changing. Guerra ibrida è guerra coperta, fuori dagli sguardi della gente che vede solo – per esempio pensiamo all’Iraq – uno spettacolo pirotecnico dove il cattivo è fatto fuori dai superpoteri dell’egemone, del gigante buono. Così la guerra non fa male, la gente non si sporca le mani: ecco perché la gente è bellicista, perché non la fa, la guerra, e non protesta come invece fece nella guerra del Vietnam con il conseguente crollo di consensi.
Questo mix di guerra convenzionale – con armi ipertecnologiche e costosissime, oppure economicissime come i droni – e tecnologia bellica invisibile e ibrida – che fa terra bruciata dall’interno, bonifica i territori –, questo mix così tipico delle attuali guerre di Ucraina e di Medio Oriente è un tratto fondamentale della trasformazione della guerra e ha una doppia conseguenza sulla quale richiamo la vostra attenzione.
Innanzitutto, la legittimazione slitta dalla giustizia universale e dai diritti umani – naturalmente occidentali – alla sicurezza; dalla celebrata Rule of Law alla gestione securitaria e poliziesca che sospende e abolisce i diritti e restringe la libertà in nome della sicurezza, come è proprio di una situazione di emergenza. L’emergenza in questo caso, però, diventa continua, ubiquitaria e ininterrotta: non si sa mai dov’è il terrorista, la spia, il fiancheggiatore, la quinta colonna… per esempio tra i migranti in arrivo o tra i manifestanti di un corteo.
La seconda conseguenza della internizzazione della guerra – il fatto che non ci sia più un fuori, la sua gestione securitaria e ibrida – è lo scopo parallelo e non esibito in queste nuove guerre: la prevenzione e repressione della conflittualità interna. E se ci sono fratture – e ci sono – vanno riorientate verso uno scontro “principale”, totalizzante. Il capo dell’Intelligence britannica, non so se avete sentito, ieri [9 ottobre ndr.] ha accusato Iran e Russia di stare dietro ai movimenti di piazza a Londra. Infatti la conflittualità diffusa, soprattutto quella interna – interna ed esterna in realtà, visto che un “esterno” non c’è – esplode via via che le crisi incalzano, soprattutto dopo il tracollo del 2007-2008, e rende fragili tutti i regimi, ma specialmente quelli occidentali. Non sottovaluterei la controrivoluzione autoritaria rispetto al libertarismo sociale, esploso nei movimenti degli anni ’70 e sbandierato dalla rivoluzione neolib, che con tutte le sue ambiguità aveva in ogni caso liberato l’espressione sociale. La svolta autoritaria neocons investe tutte le liberal-democrazie mostrandone la natura ibrida e irrisolta, come insegna il maestro Galli.
Io vorrei sottolineare come le tecniche ibride messe a punto nella lotta al terrorismo – terrorismo ininterrotto che presto riprenderà alla grande – siano funzionali alla repressione della conflittualità diffusa, innanzitutto quella delle metropoli, di tutte le metropoli di tutto il mondo. La metropoli è il concentrato dell’attuale spazio politico, indeterminato, dentro-fuori, globale e locale. E lì, dentro la metropoli, c’è una doppia conflittualità – e anche quella è guerra –, o se permettete una doppia guerra civile, diversa dalla classica lotta di classe più o meno addomesticata; penso a quella afasica e distruttiva dei riots delle banlieu – facilmente derubricabile a delinquenza impolitica e manipolabile dall’identitarismo religioso ed etnico, ma la cui dimensione politica è nel suo stesso manifestare la rabbia –; e penso a quella ben più consapevole e politica, ma informale, non rappresentata dalle istituzioni riconosciute: quelle della protesta, della indignazione, della richiesta di cambiamento dei movimenti contro-egemonici, che voce ne hanno e articolano lotte che minacciano il sistema egemonico, il momento egemonico del sistema.
A lotta informale risponde controllo di polizia e guerra informale, e viceversa.
Dunque un clima di guerra – cioè un regime di guerra indeterminata – serve a forzare la conflittualità diffusa, lo scontento e la stessa violenza anti-sistemica dentro l’opposizione binaria della guerra “guerra”, quella del noi/loro, bloccando gli altri conflitti specifici e contestualizzati. La prima “sopravvivenza” è la legittimazione ultima, chiude tutte le altre possibilità.
La guerra è, infatti, per usare un termine di Durkheim, un fatto sociale totale, che totalizza la produzione, espressione e comunicazione sociale tutta: lo fa tacitando e assorbendo le lotte specifiche che sono pensabili solo dentro la struttura aperta, non binaria, dei rapporti di potere.
Se seguiamo le trasformazioni delle guerre quasi interrotte del nuovo secolo, fino a queste ultime nelle quali è diventato altissimo il rischio di una guerra globale, dobbiamo allora almeno allargare lo spettro della conflittualità. Dobbiamo considerare molti conflitti dentro i molti attori apparentemente omogenei, che non sono visibili nel famoso cartellone del Risiko e dei quali dunque non si parla per niente nei dibattiti, televisivi e non. Parliamo di conflitti che la totalizzazione bellica tenta di assorbire e ri-orientare: questo è un classico della gestione dell’ordine quando diviene precaria. Basti pensare a Cecil Rhodes – che non era propriamente un’anima candida – che lo dice chiaramente: le guerre coloniali risolvono il problema dello scompenso degli operai, indirizzano verso l’esterno lo scontento.
Ho detto, ed è stato detto assai meglio, che si deve smontare il macroattore che è il capitale: vedere per esempio le fragilità e le contro-fattualità della potenza del dollaro che domina il mondo ma che ha depauperato il sistema produttivo (anche americano) e fa sì che il paese viva sul lavoro del resto del mondo – cosa che in piccolo vale anche per Gran Bretagna e Francia. Bisogna scomporre anche la finanza e mettere a fuoco le guerre intestine all’interno di essa; la guerra non guerreggiata del tentativo dei BRICS e della piattaforma mBridge di svincolarsi dal dollaro. Dovremmo problematizzare la territorialità, rivendicata giustamente da Carlo Galli, delle guerre africane e di queste due ultime guerre. Sono territoriali e dunque tradizionali, ma diventano geopolitiche e fatti “del mondo” per la lotta sulle supply chains: vediamo Stati Uniti contro Nord Stream – non senza un bell’attentato terrorista, che fa sempre comodo –; vediamo la Nuova via della seta, la Belt and Road Initiative; ma anche la spazialità marittima degli incombenti conflitti nel sud Pacifico.
Tutto si coagula e si ri-orienta in una conflitto globale. Siamo ancora nell’ordine di macro-attori geopolitici in qualche modo afferrabili, materiali o materialissimi, che possiamo tentare di riportare agli attori istituzionali tradizionali. Del tutto sfuggente, imprendibile, sebbene inseguito da tentativi di regolazione, è invece il capitale tecnologico dell’infosfera – con il suo impressionante iper-sviluppo, certamente dominato da capitali monopolistici in lotta, stimolato e finanziato dagli apparati militari. Ma esso è così potente da produrre contro-effettuazioni, derivazioni non controllabili. Dove la collochiamo? Come influisce sugli scenari di guerra? Come li utilizza e se ne appropria? Pensiamo solo all’inedito, inaudito agente singolo Elon Musk, che si candida esplicitamente – e non in posizione di supporto o di subordine – ad attore principale del riassetto geopolitico, magari proprio attraverso una guerra civile.
Infine, arriviamo al fronte dei movimenti informali di dissenso dentro e contro Stati che si pretendono omogenei ed esibiscono una compattezza sempre meno consensuale, ottenuta attraverso la forza repressiva – è un elemento importante, importantissimo, e ne ho già detto qualcosa parlando delle metropoli. Essi sottraggono potenza e consenso all’egemonia, fanno pressione. In quelle lotte ci sono parole d’ordine non sottovalutabili, non sempre allineate a quelle per cui noi vogliamo combattere. Emerge quindi l’annosa storia del campismo, complessa e non risolvibile con la semplice “difesa della purezza”. Il fatto che queste lotte non siano riconosciute come “politica” significa che al contrario sono potenti, sono politiche, avvertite come pericolose per il sistema. Quando declina l’egemone, lacerato dalla crisi democratica interna gigantesca, incapace di farsi ascoltare dai suoi stessi alleati, preda della arroganza dell’apparato militare, il caos scatena la massima ed eterogenea conflittualità, molti ed eterogenei conflitti.
E allora, in uno stato di guerra indeterminata e infinita, la posta politica in gioco diventa decidere quale è il conflitto davvero decisivo.
FONTE: https://congiunturadiguerra.blog/elementor-1890/
PROSSIMI INCONTRI
La guerra non è mai scomparsa dalla storia. Nell’ultimo trentennio, dalla prima guerra del Golfo ai Balcani negli anni Novanta, passando per l’Afghanistan, l’Iraq e le decine di conflitti in Africa nei primi vent’anni dei Duemila, numerosi fronti bellici hanno costellato l’approfondirsi dei processi di globalizzazione. Le recenti devastazioni in Ucraina e in Palestina che stanno accompagnano il periodo post-pandemico segnano tuttavia una forte discontinuità. Quello che è cambiato rispetto al passato è infatti una accelerata trasformazione del contesto economico-politico a livello planetario. La crisi dell’egemonia statunitense e l’affermarsi di una dimensione multipolare stanno infatti ponendo sempre più al centro la guerra come forma di gestione delle contese tra numerose potenze per il controllo degli spazi globali.
Siamo di fronte a una dinamica di escalation bellica che pare inarrestabile. Escalation non significa solo il continuo aumento di morti e devastazioni lungo le linee dei fronti di guerra. Indica piuttosto un complessivo ri-orientamento della società-mondo verso la forma-bellica. Siamo in altre parole di fronte alla diffusione di una serie di regimi di guerra che ridefiniscono i panorami economici, politici, culturali e antropologici del nostro presente. Una società proiettata verso la guerra è una società in cui la ricerca sulle tecnologie viene guidata da esigenze militari, in cui la formazione delle nuove generazioni si piega verso la disciplina con le proposte di una nuova leva obbligatoria, in cui l’industria si organizza per la produzione di nuovi armamenti, in cui la circolazione delle merci deve fare i conti con nuovi colli di bottiglia, in cui le risorse pubbliche si spostano dal welfare al warfare, in cui il dissenso politico diventa nemico interno, in cui la competizione per le risorse finanziarie e materiali si fa sempre più armata, in cui il lavoro produttivo e riproduttivo viene irregimentato anche per via dell’esasperazione di sessismo e razzismo.
La sensazione è sempre più quella di vivere su un piano inclinato, nel quale una serie di interessi economici e politici tendono in modo automatizzato verso l’esplosione della guerra a tutte le latitudini. La guerra viene da più parti vista come il modo più semplice per tagliare la complessità del presente, per uscire dalla policrisi che lo caratterizza, per riordinare la confusione planetaria, per rilanciare le economie in crisi, per imporre nuove egemonie o per difenderne di vecchie. Questa devastante inclinazione va posta al centro della riflessione pubblica e politica. Per questo abbiamo organizzato un ciclo annuale di incontri che intende pensare e discutere la congiuntura bellica per elaborare strumenti di comprensione critica del presente e delle sue tendenze a partire da una molteplicità di prospettive.
Programma
10 Ottobre 2024
con Laura Bazzicalupo, Carlo Galli e Sandro Mezzadra
5 Novembre 2024
con Sandro Mezzadra, Damiano Palano, Cristina Basili, Giorgio Grappi e Maurilio Pirone
12 Dicembre 2024
con Ruba Salih, Ilan Pappé e Rafeed Ziadah
23 Gennaio 2025
con Raúl Sánchez Cedillo e Nadia Urbinati
20 Febbraio 2025
con Raffaella Baritono, Matteo Bolocan, Francesca Governa, Michael Hardt e Maurizio Lazzarato
21 Febbraio 2025
con Giso Amendola, Carlotta Cossutta, Maddalena Fragnito e Michele Lancione
20 Marzo 2025
con Francesco Strazzari e Mariasole Pepa
17 Aprile 2025
con Silvano Cacciari, Claudia Pozzana e Domenico Quirico





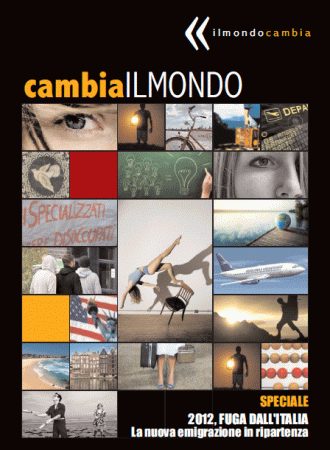












Lascia un commento